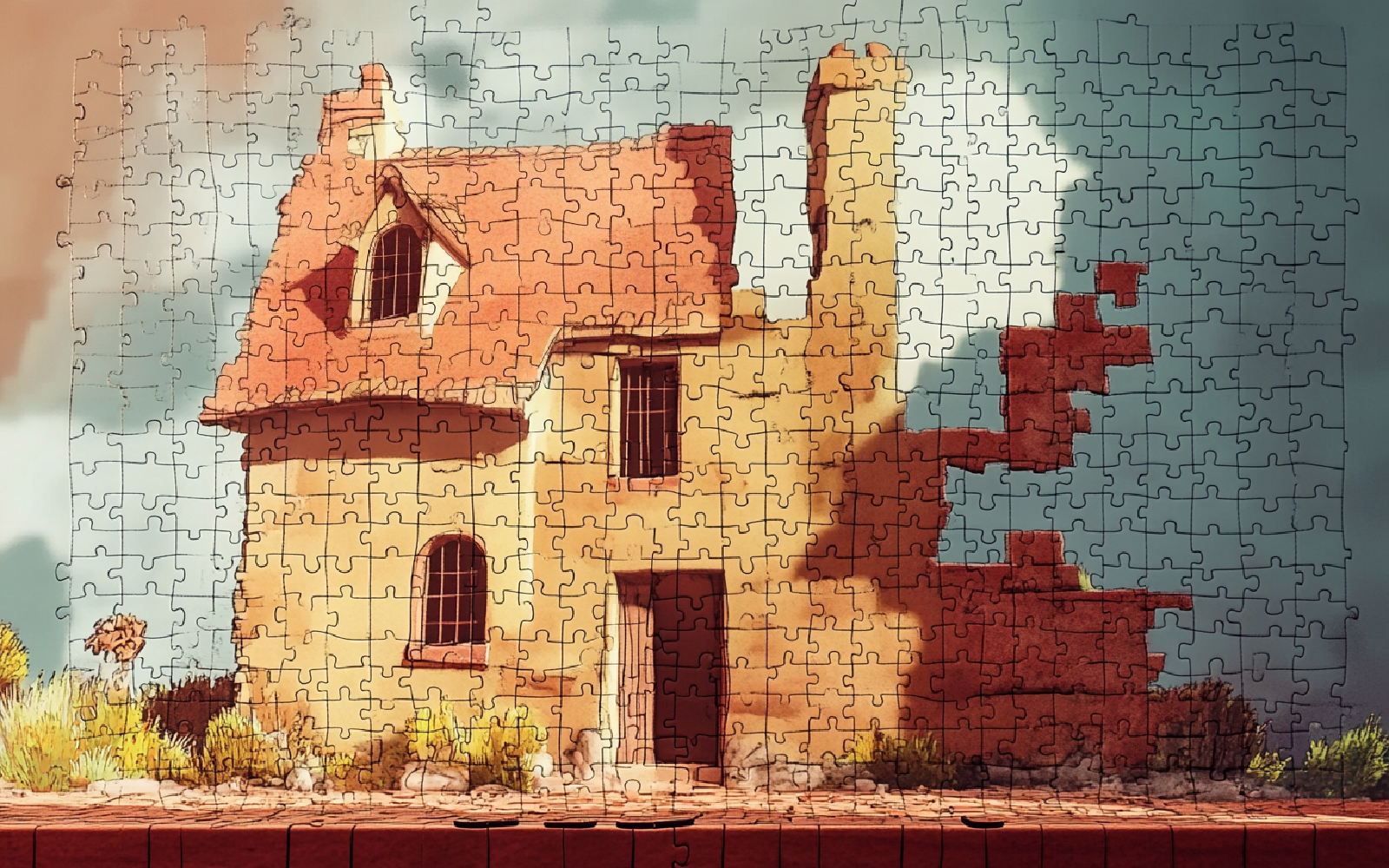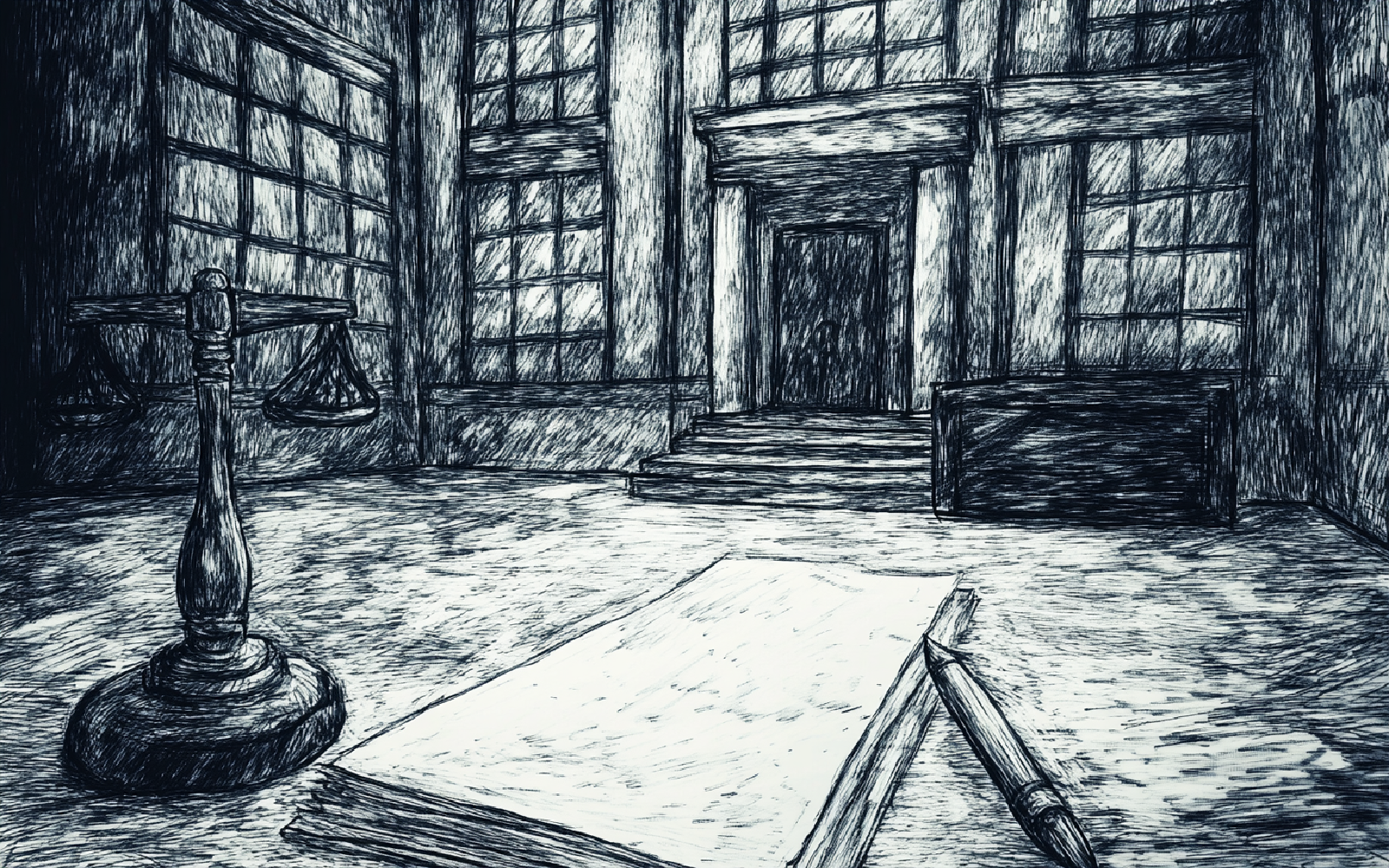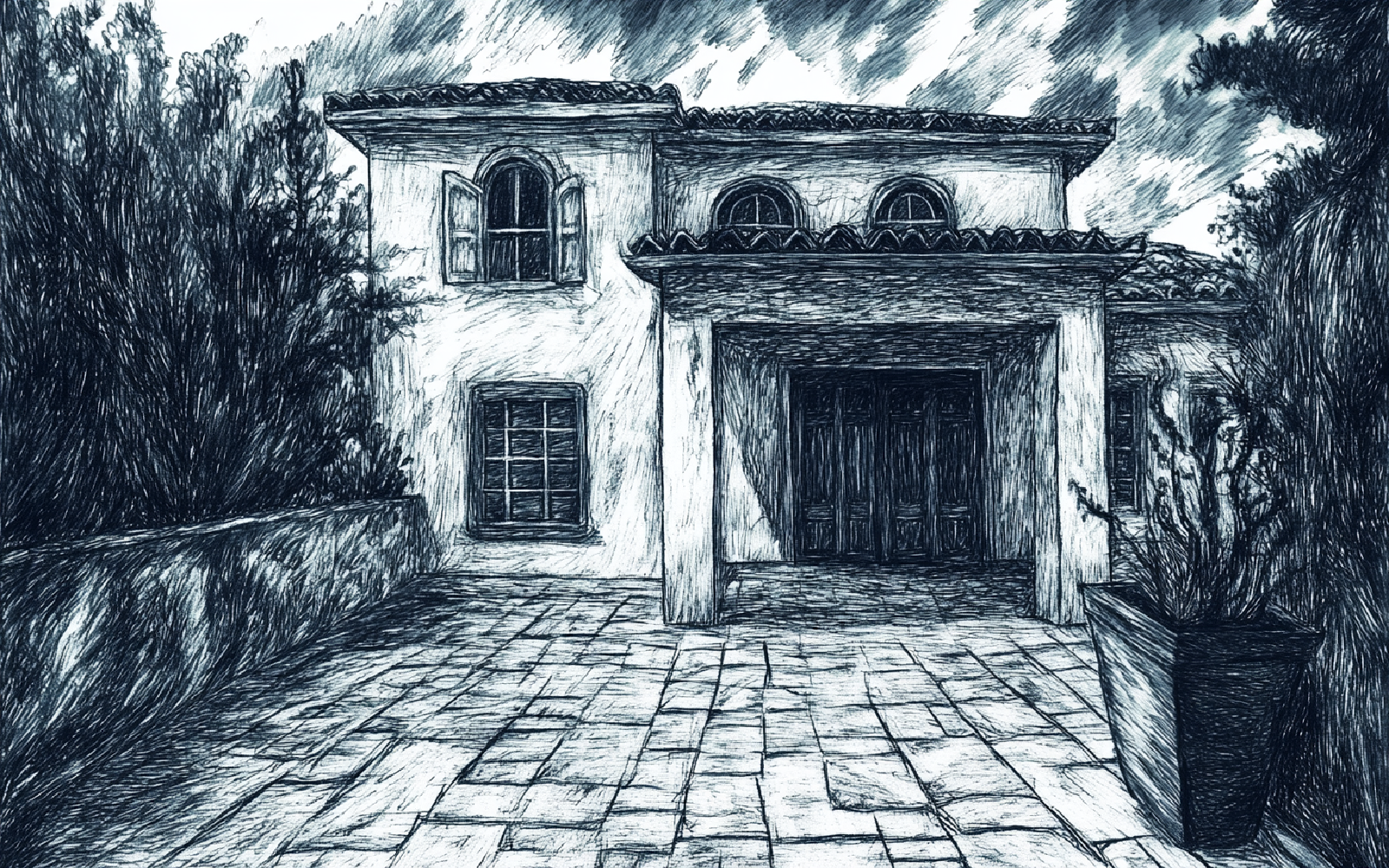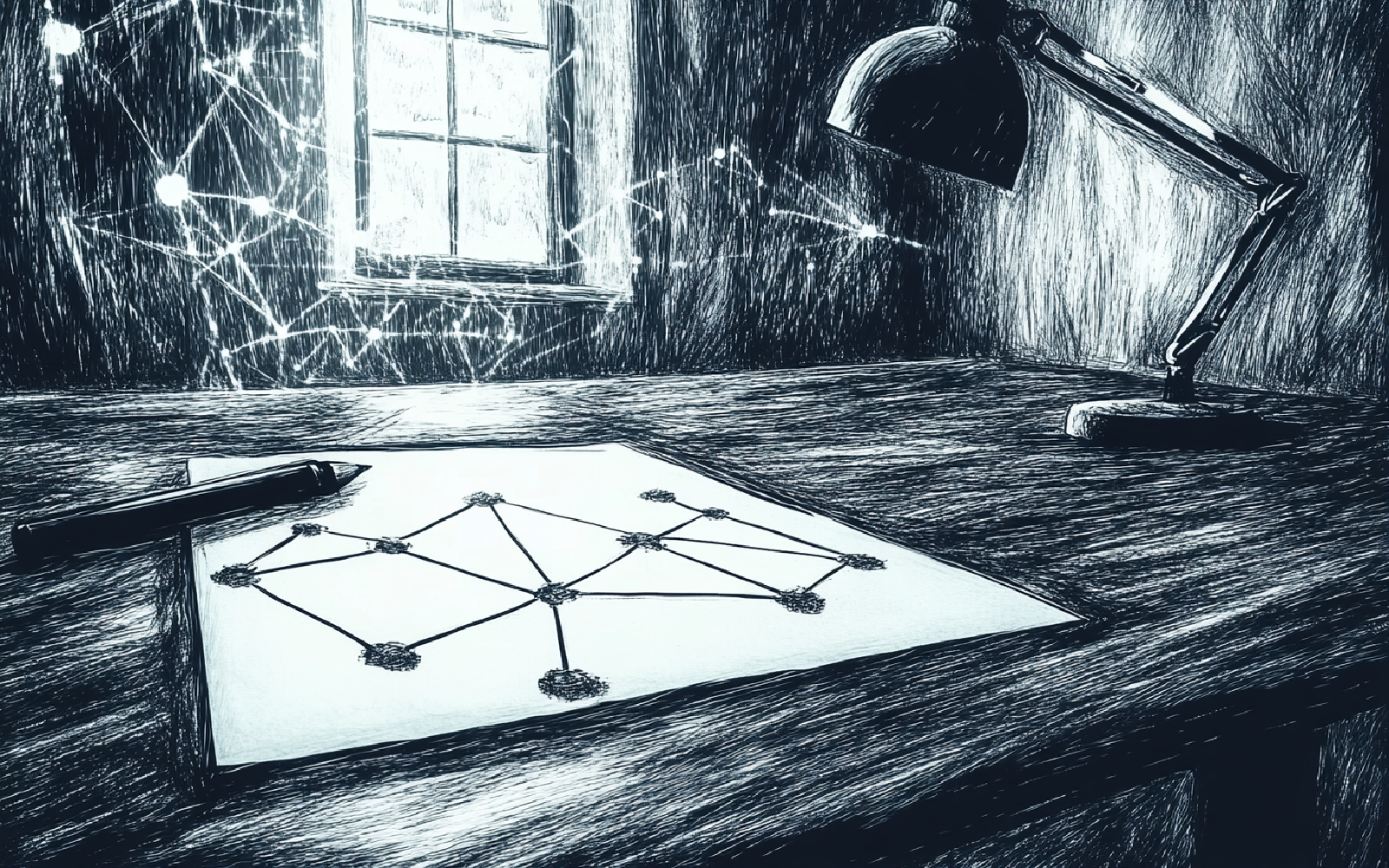Decalogo Latouriano - Il pensiero meno noto di Bruno Latour, Prima parte
Questo è un dono alle tante laturiane[1] superficiali e distratte, che hanno preso di Bruno Latour (1947-2022) solo gli aspetti più eclatanti (come mettere sullo stesso piano umani e non-umani, l’agency degli oggetti, il messaggio apparentemente post-moderno ecc.), affinché diventino laturiane profonde, meticolose e convinte. Tirato per la giacca da tante (postmoderniste, sociologhe interpretative, nuove materialiste, decostruzioniste ecc.), Latour è stato infatti un personaggio poliedrico, contraddittorio, escapologico. Per cui, è lui a essere il primo responsabile dei tanti fraintendimenti della sua opera.
Al fine di recuperare la parte meno utilizzata del suo messaggio e del suo metodo, propongo una collezione del suo pensiero, così come delineato ne Riassemblare il sociale (2005), diviso in sette sezioni:
- Il sociale, la società e la sociologia
- Una critica agli altri approcci e tradizioni di ricerca
- Il costruzionismo
- Gli attanti
- Il micro e il macro
- Il metodo ANT: come tracciare associazioni
- Con Latour, oltre Latour
In questo primo post affronteremo i primi due.
1. IL SOCIALE, LA SOCIETÀ E LA SOCIOLOGIA
- Il “sociale” non è un dominio particolare. Per cui di un fenomeno non esiste una spiegazione sociale, accanto a quella psicologica, economica, culturale ecc.
- Per questo motivo, la scienza (o meglio, un contenuto scientifico) non può essere spiegata dal suo contesto sociale. Anzi, è proprio il contrario: è il contenuto scientifico che spiega la società. Sono gli oggetti della Scienza che possono spiegare il sociale.
Non bisogna, però, essere deterministi, e convenire che nemmeno il contenuto scientifico deve essere usato per spiegare i componenti delle relazioni sociali. Il tema è quindi molto più complesso: possiamo dire che la scienza lega le varie entità in modo scientifico.
- Per cui il “sociale”, agli occhi dell'Actor-Network Theory (ANT), è un movimento assai peculiare, di riassociazione e riassemblaggio di tutte le entità che attraversano un campo d’azione. Cogliere questo movimento è compito dello studioso. Tuttavia, per farlo, egli deve sviluppare una sensibilità particolare, che consiste nel potenziare il nostro “senso del movimento”, ovvero nell’acquisire “il senso del sociale”. Infatti, i fisiologi hanno mostrato che, perché una percezione abbia luogo sono necessari continui movimenti e aggiustamenti: se non c'è movimento, non c'è sensazione. Con l'assenza di movimenti sopraggiunge un offuscamento dei sensi. Lo stesso vale per il ‘senso del sociale’: se lo studioso non è capace di vedere nuove associazioni, non sarà nemmeno in grado di vedere il sociale.
- Il compito dello studioso è quindi il tracciamento di nuove associazioni (configurazioni), fra forze sino ad allora inassociate.
- Nel fare questo, occorre quindi tener ben presente che la società non esiste. Esistono solo i raggruppamenti, il collettivo, che è il progetto di assemblaggio di entità nuove non ancora riunite; inoltre bisogna mettere in luce l’eterogeneità di attanti molto diversi fra loro, i quali si mescolano come “una squadra di operai che costruisce un muro di mattoni: le loro strade si separano di nuovo solo dopo che il muro è stato completato. Tuttavia, mentre lo si costruisce, non c'è dubbio che siano collegate. Come? Sarà la ricerca di determinarlo”
- Bisogna riconoscere appieno chi e che cosa partecipa all’azione, includendo anche le “masse mancanti” di entità non-umane. Infatti, gli aggregati (associazioni che hanno una forma, seppur momentanea) si muovono all'interno di fenomeni non formattati. Questo sfondo Latour lo chiama "plasma": esso è astronomicamente enorme per dimensioni e portata, un immenso repertorio di masse
- A tal fine, i termini e i concetti di “sociale” e “naturale” devono perciò essere accantonati. Perché i pesci e pescatori non si fronteggiano come ‘naturale’ e ‘sociale’, ‘oggetto’ e ‘soggetto’, ‘materiale’ e ‘simbolico’. Per Gabriel Tarde (1843-1904), ricorda Latour, non c’era alcuna ragione per separare il “sociale” umano da altre associazioni come gli organismi biologici o persino gli atomi. Il sociale, per Tarde, era un fluido in circolazione, e non organismo. Ogni cosa era una società e ogni fenomeno era un fatto sociale: società cellulari, società atomiche, società di astri. Tutte le scienze, pronosticava Tarde, sembrano destinate a divenire rami della sociologia.
2. UNA CRITICA AGLI ALTRI APPROCCI E TRADIZIONI DI RICERCA
- Latour si definisce “oggettivista”, dicendo di non avere alcuna simpatia per le “sociologie interpretative”, perché l'ANT non apprezza l’eccessiva enfasi data dai fenomenologi alle fonti umane dell’azione, e ignora completamente la lunga battaglia tra oggetto e soggetto. E invita alla lettura del filosofo tedesco Peter Sloterdijk che, con i tre volumi sui diversi tipi di sfere, ha offerto una nuova e potente metafora per uscire dalla dicotomia interno/esterno.
- Ciò non significa che dovremmo privarci del ricco vocabolario descrittivo della fenomenologia; semplicemente che dobbiamo estenderlo alle entità ‘non intenzionali’.
- Per cui bisogna ritornare all’oggetto. Nel rivendicare il proprio “realismo”, Latour però ne dà un’interpretazione diversa da quella tradizionale. Egli ritiene che l’oggettività non sia una proprietà privata dei positivisti. Anzi, condivide l’affermazione del microbiologoe filosofo polacco Ludwik Fleck (1896-1961): “più sociale c'è, più realismo c'è”.
- Latour accetta anche l’etichetta di “relativista”: “ma certo, cos'altro potrei essere?”, dice. In linea con quanto scriveva Peter L. Berger (1963) sul progetto di “alternanza”, ma senza mai citarlo, Latour sostiene che “per raggiungere l'oggettività, devo essere in grado di navigare da un quadro di riferimento all'altro, da un punto di vista all'altro. Senza questi spostamenti, sarai limitato al mio ristretto punto di vista per sempre”. La “relatività”, più che il relativismo, è la bussola dello studioso.
- Latour è quindi “oggettivista”, “realista” e “relativista” nello stesso tempo; una miscela originale che attribuisce nuovi significati a vecchi termini, che tuona contro l’empirismo tradizionale a favore di un nuovo empirismo.
- Infatti l'empirismo storico è stato “una resa piuttosto povera all'esperienza. Questa povertà, tuttavia non si supera allontanandosi dall'esperienza materiale per esempio in direzione della ‘ricca soggettività umana’, ma avvicinandosi alle forme di resistenza variegate che la materia ha da offrire”. Perché “artificialità totale e oggettività totale si muovono in parallelo”.
- “Non siamo più obbligati a combattere il riduzionismo aggiungendo alla descrizione qualche ‘aspetto’ umano, simbolico, soggettivo o sociale, perché il riduzionismo, tanto per cominciare, non rende giustizia ai fatti oggettivi. Quel che si potrebbe chiamare il primo empirismo è riuscito, per ragioni politiche, a oscurare i numerosi percorsi e deviazioni dell'oggettività e a ridurre in umani all'ombra di se stessi”, scrive Latour.
- Lungi dal ‘possedere oggettività’, “i positivisti somigliano piuttosto proprietari terrieri assenteisti, che sembrano non sapere cosa farsene dei loro latifondi”. Per cui, “il riduzionismo è un'impossibilità pratica, nella misura in cui gli elementi a cui si riduce un ‘livello superiore’ saranno tanto complessi quanto il ‘livello inferiore’. Se solo gli umani nelle mani di sociologi critici potessero essere trattati al pari delle balene in zoologia…” termina sconsolato Latour.
- E alla fine, uccide il padre: “devo finalmente congedarmi da Tarde (...) Egli ha mantenuto una definizione sostanziale e non relativista della sociologia”.
NOTE
[1] Uso il femminile sovraesteso.
BIBLIOGRAFIA
Berger, Peter L. (1963), trad. it. Invito alla sociologia, Venezia: Marsilio.
Descola, Philippe (2005), trad. it. Oltre natura e cultura, Milano: Cortina, 2014.
Fleck, Ludwik (1935), trad. it. Genesi e sviluppo di un fatto scientifico, Bologna: Il Mulino
Ginzburg, Carlo (1976), Il formaggio e i vermi. Il cosmo di un mugnaio del Cinquecento, Torino, Einaudi.
James, William (1890), trad. it. Principi di Psicologia, Milano: Società Editrice Libraria, 1909.
Latour, Bruno (2005), tr. Riassemblare il sociale, Milano: Meltemi, 2022.
Sloterdijk, Peter (1998), trad. it. Sfere / Bolle vol. 1, Milano: Meltemi 2009.
Sloterdijk, Peter (1999), trad. it. Sfere / Globi vol. 2., Milano Cortina, 2014.
Sloterdijk, Peter (2004), trad. it. Sfere / Schiume vol. 3., Milano: Cortina, 2015.
Tarde, Gabriel (1894), La logique sociale, Paris: Alcan.
Intelligenza artificiale e creatività - Seconda parte: c’è differenza tra i pennelli e l’IA?
Qualche settimana fa avevamo iniziato una riflessione sull’interazione tra processo creativo artistico e Intelligenza Artificiale.
Ci eravamo chiesti se realizzare un’immagine con l’IA può essere definito come un atto creativo e abbiamo avuto le risposte di tre amici di Controversie, ognuno dalla propria ottica che deriva da un diverso percorso professionale e culturale (trovate le risposte nell’articolo pubblicato il 10 settembre scorso).
Riporto di seguito le conclusioni di quella prima riflessione:
“Non c’è dubbio che queste tre risposte siano estremamente stimolanti e che vi si possa rintracciare un minimo comune denominatore che le lega: l’idea che l’IA sia solo un mezzo, per quanto potente, ma che l’atto creativo resti saldamente appannaggio di colui che ha nel suo animo (umano) l’obiettivo concettuale.
Ottenere un risultato con l’IA si delinea, qui, come un vero atto creativo, che, però e ovviamente, non è detto che si trasformi in arte, ovvero in una manifestazione creativa in grado di dare emozione universale.
In termini più concreti: molti di noi, forse, potrebbero avere “nella testa” La notte stellata di Van Gogh (giusto per fare un esempio), ma la differenza tra la grandissima maggioranza di noi e il genio olandese è che non sapremmo neppure lontanamente “mettere a terra” questa intuizione.
Con l’IA, a forza di istruzioni che la macchina esegue, potremmo invece, avvicinarci al risultato di Vincent?”
La domanda che sorgeva spontanea, e a cui chiedo ai nostri amici un’ulteriore riflessione, è la seguente: Se così fosse, in che modo cambierebbe l’essenza stessa dell’artista?
Inserisco però un ulteriore elemento che deriva dall’aver letto la bella riflessione di Natalia Irza del 29 ottobre scorso su Controversie dal titolo “Il rating sociale tra digitale e moralità”.
Riporto testualmente un passaggio a mio avviso molto importante anche per il nostro ragionamento su processo creativo e IA. Scrive Irza:
“Per stabilire la verità su una persona, sono necessari strumenti umani. Lo stesso si può dire dell’uso dell’IA nell’arte: la pittura non è uguale alla composizione di colori, la musica non è uguale alla composizione di suoni, la poesia non è uguale alla composizione di parole. Senza la dimensione umana, che significa non solo l’operare algoritmi ma creare idee umane, l’arte cessa di essere arte.”
Aggiungo quindi una provocazione per i nostri amici chiamati a rispondere alla prima domanda, e cioè: dobbiamo quindi pensare che esisteranno in futuro due forme d’arte, una “analogica”, tradizionale, in cui l’essere umano si esprime attraverso strumenti controllati completamente dall’artista e una “nuova arte”, digitale, in cui l’autore si avvale di uno strumento che interviene nel processo creativo “aggiungendo” all’evoluzione concettuale dell’artista?
E quale sarà il livello di contaminazione fra queste due diverse situazioni?
Ecco le prime due risposte, scrive Diego Randazzo:
Quello che rende un artista tale è soprattutto il suo percorso. Un percorso interiore ed esteriore che lo porta a sviluppare una ricerca unica e indipendente. In assenza di tale percorso non vi può essere Arte, ma solo degli isolati appuntamenti con la tecnica.
Quindi, davanti alla possibilità di ricreare dei modelli digitali molto simili a capolavori storicizzati attraverso l’IA, non si può che riconoscere tale pratica come un tentativo, sicuramente curioso e sorprendente, ma molto lontano dalla definizione di Arte.
Non è un caso se utilizzo le parole tentativo e modello, che ne evidenziano l’approccio germinale, automatico e inconsapevole.
In altre parole, penso che la tensione verso la dimensione umana, a cui si riferisce Natalia Irza nell’articolo menzionato, sia necessaria e fondamentale. Del resto come possiamo capire in profondità un artista, senza conoscere qualche dettaglio, anche superficiale, della sua biografia? La Storia dell’Arte è punteggiata, da sempre, da questo binomio, indissolubile anche nel vischioso territorio dell’arte contemporanea: la pratica artistica come estensione e manifestazione della vita stessa degli artisti.
Pensiamo anche al potere del mercato odierno nel dare valore all’opera d’arte: oggi più che mai notiamo che sono le caratteristiche biografiche a fare da volano e non la qualità intrinseca dell’opera (vedi il successo della banana ‘Comedian’ di Cattelan).
Seguendo questo principio, dove la dimensione (e presenza) umana dell’artista sono sempre al centro, trovo assai difficile riconoscere valore nelle sperimentazioni con l’IA condotte dai non addetti ai lavori (non artisti?). Da considerare diversamente sono invece le incursioni degli artisti che utilizzano lo strumento dell’IA con consapevolezza e visione.
Infine di fronte alla possibile convivenza tra due tipologie di Arte (una totalmente analogica ed una totalmente mediata dallo strumento IA) nutro profondi dubbi; non ho mai creduto nella classificazione e scolastica separazione tra discipline, piuttosto credo nella ricerca della complementarità tra queste due modalità. Ad esempio, è molto stimolante l’uso dell’IA per creare ‘modelli e reference’, delle basi da cui partire e su cui innestare il gesto unico dell’autore. Tale gesto si può quindi esemplificare in una copia o rielaborazione analogica (manuale) dei modelli iniziali.
Facendo così, non solo ripercorriamo la storia dell’arte, seguendo il classico ed insuperato paradigma modello/rappresentazione, ma, contestualmente, attualizziamo il contesto: il modello da studiare e copiare non è più la realtà che ci circonda, ma una realtà mediata e spesso incontrollabile, formulata da un algoritmo.
Vorrei proseguire il discorso dando la parola ad Aleksander Veliscek, interessante artista sloveno, che attraverso i dettagli dei suoi affascinanti dipinti mette a punto proprio questa modalità, svelandoci le possibilità di un uso virtuoso ed intelligente dell’IA in pittura.
------------------------------
Ed ecco l’intervento di Aleksander Veliscek:
Penso che creare un’immagine con l’IA oggi può essere considerato un atto creativo, ma con una specificità: è una creatività mediata, e dove non necessariamente appartiene alla sensibilità di tutti gli artisti. Durante il workshop che ho curato quest’anno sul tema PITTURA e IMMAGINI I.A. a Dolomiti Contemporanee (ex stazione, Borca di Cadore), ho potuto constatare da parte di molti allievi-artisti un interessante dialogo tra chatGPT e gli autori.
Un esempio curioso era un artista che lavora in ambito astratto. Si è creato un confronto critico da entrambe le parti nella costruzione dell’immagine. Ne è risultato un pezzo indubbiamente riuscito. Spesso invece c’era un rigetto, in quanto le soluzioni proposte dalla I.A. erano banali e non riuscivano a centrare le sottili sfumature che l’artista cercava anche dopo lunghi tentativi.
È, così, evidente quanto l’essere umano giochi un ruolo essenziale nella progettazione e nell’interpretazione del risultato.
Quindi L’I.A., è sicuramente uno Strumento, sempre più potente e innovativo, ma non sostituisce l’immaginazione e il giudizio umano.
Invece come artista trovo più interessante capire l’aspetto ontologico. Le macchine intelligenti, pur essendo create dall’uomo, possono simulare comportamenti complessi che sembrano riflettere aspetti tipici dell’essere umano, come l’apprendimento, la creatività o persino l’autonomia. Tuttavia, queste simulazioni sono autentiche manifestazioni di “essere” o sono semplicemente imitazioni prive di sostanza?
Martin Heidegger, nel suo studio sull’essere, distingueva tra l’“essere autentico” e l’“essere per altri”. L’IA, in questo contesto, può essere vista come un “essere per altri”, progettata per servire scopi umani, ma incapace di una propria esperienza ontologica. Tuttavia, alcuni teorici suggeriscono che, con lo sviluppo di sistemi sempre più complessi, potremmo dover ripensare questa distinzione.
 Un mio dipinto ad olio raffigurante William Shakespeare, dove l’effigie realistica del grande drammaturgo è stata creata con l’intelligenza artificiale combinando diverse fonti, partendo dalle incisioni, sculture e dipinti.
Un mio dipinto ad olio raffigurante William Shakespeare, dove l’effigie realistica del grande drammaturgo è stata creata con l’intelligenza artificiale combinando diverse fonti, partendo dalle incisioni, sculture e dipinti.
--------------------------------------
Queste due riflessioni sono certamente molto interessanti ma, tuttavia e inevitabilmente, non portano a risposte certe. Stiamo viaggiando, infatti, su un territorio privo di confini definiti, fluido e in rapido divenire.
Mi sembra si possa dire che ci sono due punti chiave nel ragionamento dei nostri due artisti: la centralità dell’uomo - con tutto il suo portato esistenziale - come attore primario e non sostituibile del processo artistico; e la contaminazione dei modi di fare arte, che per altro è cominciata ben prima dell’I.A..
Contaminazione che è un dato di fatto.
E quindi non è possibile una distinzione rigida (Diego usa la parola “scolastica”) tra arti “tradizionali” e arti in cui tecniche nuove e l’apporto potentissimo dell’I.A, irrompono nel processo creativo.
L’I.A. cambierà presto l’essenza di molti lavori; si pensi a cosa potrebbe diventare la giustizia se le sentenze dovessero passare dall’interpretazione dei fatti data da esseri umani a quelle, teoricamente neutrali, dell’IA (l’oggettività nell’interpretazione dell’agire umano non può esistere).
Forse tra pochi anni le domande che ci siamo posti in questa sede non avranno più senso, superate dalla prassi dell’utilizzo di nuove tecnologie in tutti i settori dell’agire umano, arte compresa.
Ma su questi punti aspettiamo anche il parere degli altri due amici del gruppo di questa discussione…
Legge 13 maggio 1978, n. 180 – Testo integrale
Comunemente, la legge n. 180 viene chiamata “legge Basaglia”; in realtà il suo estensore fu lo psichiatra e politico democristiano Bruno Orsini e Franco Basaglia non ne fu particolarmente soddisfatto – anche se la difese come impianto teorico ed ideologico, come dichiarò in una intervista fatta da Maurizio Costanzo:
«Non è importante tanto il fatto che in futuro ci siano o meno manicomi e cliniche chiuse, è importante che noi adesso abbiamo provato che si può fare diversamente, ora sappiamo che c'è un altro modo di affrontare la questione; anche senza la costrizione.»
La legge n. 180 nacque con un iter frettoloso: il progetto iniziale – che recepiva le istanze e le proposte di Franco Basaglia, del movimento di Psichiatria Democratica e di un numero non indifferente di psichiatri – prevedeva che la precedente legge che regolava il trattamento “dei matti” (Legge 14 febbraio 1904, n. 36 - Disposizioni sui manicomi e sugli alienati. Custodia e cura degli alienati) fosse parzialmente abrogata attraverso un referendum e sostituita nell’ambito della legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale.
Tuttavia, il referendum rappresentava un rischio, perché il tema “dei matti” poteva essere sentito in modo controverso nella società, e la legge sul Sistema Sanitario avrebbe potuto avere tempi più lunghi del previsto. Il governo Andreotti optò, allora, per lo stralcio degli articoli che riguardavano i principali temi correlati ai manicomi e ne fece la legge n. 180, abrogando in buona parte (fatta esclusione per i temi economici e fiscali) la legge del 1904.
La “180” è una legge breve, molto sintetica, densa di contenuti e difficile da mettere in opera, soprattutto negli anni ’70.
Controversie ha ritenuto – per evitare che il dibattito viaggi sull’onda dei soli commenti e opinioni – di riportarla qui integralmente, insieme all’articolo 64 della legge n. 833/1978, istituiva del Sistema Sanitario Nazionale.
Legge 13 maggio 1978, n. 180
Sommario
Art. 1 Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori
Art. 2 Accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori per malattia mentale
Art. 4 Revoca e modifica del provvedimento di trattamento sanitario obbligatorio
Art. 7 Trasferimento alle regioni delle funzioni in materia di assistenza ospedaliera psichiatrica
Art. 8 Infermi già ricoverati negli ospedali psichiatrici
Art. 9 Attribuzioni del personale medico degli ospedali psichiatrici
Art. 10 Modifiche al codice penale
" Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori "
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 1978, n. 133.
Art. 1 Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori.
Gli accertamenti e i trattamenti sanitari sono volontari. Nei casi di cui alla presente legge e in quelli espressamente previsti da leggi dello Stato possono essere disposti dall'autorità sanitaria accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori nel rispetto della dignità della persona e dei diritti civili e politici garantiti dalla Costituzione, compreso per quanto possibile il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura. Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori a carico dello Stato e di enti o istituzioni pubbliche sono attuati dai presidi sanitari pubblici territoriali e, ove necessiti la degenza, nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate. Nel corso del trattamento sanitario obbligatorio chi vi è sottoposto ha diritto di comunicare con chi ritenga opportuno. Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori di cui ai precedenti commi devono essere accompagnati da iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi è obbligato. Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori sono disposti con provvedimento del sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria locale, su proposta motivata di un medico.
Art. 2 Accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori per malattia mentale.
Le misure di cui al secondo comma del precedente articolo possono essere disposte nei confronti delle persone affette da malattie mentali. Nei casi di cui al precedente comma la proposta di trattamento sanitario obbligatorio può prevedere che le cure vengano prestate in condizioni di degenza ospedaliera solo se esistano alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici, se gli stessi non vengano accettati dall'infermo e se non vi siano le condizioni e le circostanze che consentano di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extra ospedaliere. Il provvedimento che dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera deve essere preceduto dalla convalida della proposta di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 da parte di un medico della struttura sanitaria pubblica e deve essere motivato in relazione a quanto previsto nel precedente comma.
Art. 3 Procedimento relativo agli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera per malattia mentale.
Il provvedimento di cui all'articolo 2 con il quale il sindaco dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera, corredato dalla proposta medica motivata di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 e dalla convalida di cui all'ultimo comma dell'articolo 2, deve essere notificato, entro 48 ore dal ricovero, tramite messo comunale, al giudice tutelare nella cui circoscrizione rientra il comune. Il giudice tutelare, entro le successive 48 ore, assunte le informazioni e disposti gli eventuali accertamenti, provvede con decreto motivato a convalidare o non convalidare il provvedimento e ne dà comunicazione al sindaco. In caso di mancata convalida il sindaco dispone la cessazione del trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera. Se il provvedimento di cui al primo comma del presente articolo è disposto dal sindaco di un comune diverso da quello di residenza dell'infermo, ne va data comunicazione al sindaco di questo ultimo comune. Se il provvedimento di cui al primo comma del presente articolo è adottato nei confronti di cittadini stranieri o di apolidi, ne va data comunicazione al Ministero dell'interno e al consolato competente, tramite il prefetto. Nei casi in cui il trattamento sanitario obbligatorio debba protrarsi oltre il settimo giorno, ed in quelli di ulteriore prolungamento, il sanitario responsabile del servizio psichiatrico di cui all'articolo 6 è tenuto a formulare, in tempo utile, una proposta motivata al sindaco che ha disposto il ricovero, il quale ne dà comunicazione al giudice tutelare, con le modalità e per gli adempimenti di cui al primo e secondo comma del presente articolo, indicando la ulteriore durata presumibile del trattamento stesso. Il sanitario di cui al comma precedente è tenuto a comunicare al sindaco, sia in caso di dimissione del ricoverato che in continuità di degenza, la cessazione delle condizioni che richiedono l'obbligo del trattamento sanitario; comunica altresì la eventuale sopravvenuta impossibilità a proseguire il trattamento stesso. Il sindaco, entro 48 ore dal ricevimento della comunicazione del sanitario, ne dà notizia al giudice tutelare. Qualora ne sussista la necessità il giudice tutelare adotta i provvedimenti urgenti che possono occorrere per conservare e per amministrare il patrimonio dell'infermo. La omissione delle comunicazioni di cui al primo, quarto e quinto comma del presente articolo determina la cessazione di ogni effetto del provvedimento e configura, salvo che non sussistano gli estremi di un delitto più grave, il reato di omissione di atti di ufficio.
Art. 4 Revoca e modifica del provvedimento di trattamento sanitario obbligatorio.
Chiunque può rivolgere al sindaco richiesta di revoca o di modifica del provvedimento con il quale è stato disposto o prolungato il trattamento sanitario obbligatorio. Sulla richiesta di revoca o di modifica il sindaco decide entro dieci giorni. I provvedimenti di revoca o di modifica sono adottati con lo stesso procedimento del provvedimento revocato o modificato.
Art. 5 Tutela giurisdizionale.
Chi è sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio, e chiunque vi abbia interesse, può proporre al tribunale competente per territorio ricorso contro il provvedimento convalidato dal giudice tutelare. Entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla scadenza del termine di cui al secondo comma dell'articolo 3, il sindaco può proporre analogo ricorso avverso la mancata convalida del provvedimento che dispone il trattamento sanitario obbligatorio. Nel processo davanti al tribunale le parti possono stare in giudizio senza ministero di difensore e farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce al ricorso o in atto separato. Il ricorso può essere presentato al tribunale mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Il presidente del tribunale fissa l'udienza di comparizione delle parti con decreto in calce al ricorso che, a cura del cancelliere, è notificato alle parti nonché al pubblico ministero. Il presidente del tribunale, acquisito il provvedimento che ha disposto il trattamento sanitario obbligatorio e sentito il pubblico ministero, può sospendere il trattamento medesimo anche prima che sia tenuta l'udienza di comparizione. Sulla richiesta di sospensiva il presidente del tribunale provvede entro dieci giorni. Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, dopo aver assunto informazioni e raccolte le prove disposte di ufficio o richieste dalle parti. I ricorsi ed i successivi procedimenti sono esenti da imposta di bollo. La decisione del processo non è soggetta a registrazione.
Art. 6 Modalità relative agli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera per malattia mentale.
Gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione relativi alle malattie mentali sono attuati di norma dai servizi e presìdi psichiatrici extra ospedalieri. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge i trattamenti sanitari per malattie mentali che comportino la necessità di degenza ospedaliera e che siano a carico dello Stato o di enti e istituzioni pubbliche sono effettuati, salvo quanto disposto dal successivo articolo 8, nei servizi psichiatrici di cui ai successivi commi. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche con riferimento agli ambiti territoriali previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, individuano gli ospedali generali nei quali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, devono essere istituiti specifici servizi psichiatrici di diagnosi e cura. I servizi di cui al secondo e terzo comma del presente articolo - che sono ordinati secondo quanto è previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, per i servizi speciali obbligatori negli ospedali generali e che non devono essere dotati di un numero di posti letto superiore a 15 - al fine di garantire la continuità dell'intervento sanitario a tutela della salute mentale sono organicamente e funzionalmente collegati, in forma dipartimentale con gli altri servizi e presìdi psichiatrici esistenti nel territorio.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano le istituzioni private di ricovero e cura, in possesso dei requisiti prescritti, nelle quali possono essere attuati trattamenti sanitari obbligatori e volontari in regime di ricovero. In relazione alle esigenze assistenziali, le province possono stipulare con le istituzioni di cui al precedente comma convenzioni ai sensi del successivo articolo 7.
Art. 7 Trasferimento alle regioni delle funzioni in materia di assistenza ospedaliera psichiatrica.
A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge le funzioni amministrative concernenti la assistenza psichiatrica in condizioni di degenza ospedaliera, già esercitate dalle province, sono trasferite, per i territori di loro competenza, alle regioni ordinarie e a statuto speciale. Resta ferma l'attuale competenza delle province autonome di Trento e di Bolzano. L'assistenza ospedaliera disciplinata dagli articoli 12 e 13 del decreto-legge 8 luglio 1974, numero 264, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n. 386, comprende i ricoveri ospedalieri per alterazioni psichiche. Restano ferme fino al 31 dicembre 1978 le disposizioni vigenti in ordine alla competenza della spesa. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge le regioni esercitano anche nei confronti degli ospedali psichiatrici le funzioni che svolgono nei confronti degli altri ospedali. Sino alla data di entrata in vigore della riforma sanitaria, e comunque non oltre il 1° gennaio 1979, le province continuano ad esercitare le funzioni amministrative relative alla gestione degli ospedali psichiatrici e ogni altra funzione riguardante i servizi psichiatrici e di igiene mentale. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano programmano e coordinano l'organizzazione dei presìdi e dei servizi psichiatrici e di igiene mentale con le altre strutture sanitarie operanti nel territorio e attuano il graduale superamento degli ospedali psichiatrici e la diversa utilizzazione delle strutture esistenti e di quelle in via di completamento. Tali iniziative non possono comportare maggiori oneri per i bilanci delle amministrazioni provinciali. E' in ogni caso vietato costruire nuovi ospedali psichiatrici, utilizzare quelli attualmente esistenti come divisioni specialistiche psichiatriche di ospedali generali, istituire negli ospedali generali divisioni o sezioni psichiatriche e utilizzare come tali divisioni o sezioni neurologiche o neuropsichiatriche. Agli ospedali psichiatrici dipendenti dalle amministrazioni provinciali o da altri enti pubblici o dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza si applicano i divieti di cui all'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 1978, n. 43. Ai servizi psichiatrici di diagnosi e cura degli ospedali generali, di cui all'articolo 6, è addetto personale degli ospedali psichiatrici e dei servizi e presidi psichiatrici pubblici extra ospedalieri. I rapporti tra le province, gli enti ospedalieri e le altre strutture di ricovero e cura sono regolati da apposite convenzioni, conformi ad uno schema tipo, da approvare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della sanità di intesa con le regioni e l'Unione delle province di Italia e sentite, per quanto riguarda i problemi del personale, le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative. Lo schema tipo di convenzione dovrà disciplinare tra l'altro il collegamento organico e funzionale di cui al quarto comma dell'articolo 6, i rapporti finanziari tra le province e gli istituti di ricovero e l'impiego, anche mediante comando, del personale di cui all'ottavo comma, del presente articolo. Con decorrenza dal 1° gennaio 1979 in sede di rinnovo contrattuale saranno stabilite norme per la graduale omogeneizzazione tra il trattamento economico e gli istituti normativi di carattere economico del personale degli ospedali psichiatrici pubblici e dei presidi e servizi psichiatrici e di igiene mentale pubblici e il trattamento economico e gli istituti normativi di carattere economico delle corrispondenti categorie del personale degli enti ospedalieri.
Art. 8 Infermi già ricoverati negli ospedali psichiatrici.
Le norme di cui alla presente legge si applicano anche agli infermi ricoverati negli ospedali psichiatrici al momento dell'entrata in vigore della legge stessa. Il primario responsabile della divisione, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, con singole relazioni motivate, comunica al sindaco dei rispettivi comuni di residenza, i nominativi dei degenti per i quali ritiene necessario il proseguimento del trattamento sanitario obbligatorio presso la stessa struttura di ricovero, indicando la durata presumibile del trattamento stesso. Il primario responsabile della divisione è altresì tenuto agli adempimenti di cui al quinto comma dell'articolo 3. Il sindaco dispone il provvedimento di trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera secondo le norme di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 e ne dà comunicazione al giudice tutelare con le modalità e per gli adempimenti di cui all'articolo 3. L'omissione delle comunicazioni di cui ai commi precedenti determina la cessazione di ogni effetto del provvedimento e configura, salvo che non sussistano gli estremi di un delitto più grave, il reato di omissione di atti di ufficio. Tenuto conto di quanto previsto al quinto comma dell'articolo 7 e in temporanea deroga a quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 6, negli attuali ospedali psichiatrici possono essere ricoverati, sempre che ne facciano richiesta, esclusivamente coloro che vi sono stati ricoverati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e che necessitano di trattamento psichiatrico in condizioni di degenza ospedaliera.
Art. 9 Attribuzioni del personale medico degli ospedali psichiatrici.
Le attribuzioni in materia sanitaria del direttore, dei primari, degli aiuti e degli assistenti degli ospedali psichiatrici sono quelle stabilite, rispettivamente, dagli articoli 4 e 5 e dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128.
Art. 10 Modifiche al codice penale.
Nella rubrica del libro III, titolo I, capo I, sezione III, paragrafo 6 del codice penale sono soppresse le parole: "di alienati di mente". Nella rubrica dell'articolo 716 del codice penale sono soppresse le parole: "di infermi di mente o".
Nello stesso articolo sono soppresse le parole: "a uno stabilimento di cura o".
Art. 11 Norme finali.
Sono abrogati gli articoli 1, 2, 3 e 3-bis della legge 14 febbraio 1904, n. 36, concernente "Disposizioni sui manicomi e sugli alienati" e successive modificazioni, l'articolo 420 del codice civile, gli articoli 714, 715 e 717 del codice penale, il n. 1 dell'articolo 2 e l'articolo 3 del testo unico delle leggi recanti norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, nonché ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge. Le disposizioni contenute negli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della presente legge restano in vigore fino alla data di entrata in vigore della legge istitutiva del servizio sanitario nazionale. Fino a quando non si provvederà a modificare, coordinare e riunire in un testo unico le disposizioni vigenti in materia di profilassi internazionale e di malattie infettive e diffusive, ivi comprese le vaccinazioni obbligatorie, sono fatte salve in materia di trattamenti sanitari obbligatori le competenze delle autorità militari, dei medici di porto, di aeroporto e di frontiera e dei comandanti di navi o di aeromobili.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Data a Roma, addì 13 maggio 1978
Leone - Andreotti - Bonifacio - Anselmi
Visto, il Guardasigilli: Bonifacio
STRALCIO DELLA LEGGE 833/1978
TITOLO III
Norme transitorie e finali
Art. 64 - Norme transitorie per l'assistenza psichiatrica.
La regione nell'ambito del piano sanitario regionale, disciplina il graduale superamento degli ospedali psichiatrici o neuropsichiatrici e la diversa utilizzazione, correlativamente al loro rendersi disponibili, delle strutture esistenti e di quelle in via di completamento. La regione provvede inoltre a definire il termine entro cui dovrà cessare la temporanea deroga per cui negli ospedali psichiatrici possono essere ricoverati, sempre che ne facciano richiesta, coloro che vi sono stati ricoverati anteriormente al 16 maggio 1978 e che necessitano di trattamento psichiatrico in condizioni di degenza ospedaliera; tale deroga non potrà comunque protrarsi oltre il 31 dicembre 1980 . Entro la stessa data devono improrogabilmente risolversi le convenzioni di enti pubblici con istituti di cura privati che svolgano esclusivamente attività psichiatrica . È in ogni caso vietato costruire nuovi ospedali psichiatrici, utilizzare quelli attualmente esistenti come divisioni specialistiche psichiatriche di ospedali generali, istituire negli ospedali generali divisioni o sezioni psichiatriche e utilizzare come tali divisioni o sezioni psichiatriche o sezioni neurologiche o neuro-psichiatriche. La regione disciplina altresì con riferimento alle norme di cui agli articoli 66 e 68, la destinazione alle unità sanitarie locali dei beni e del personale delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza (IPAB) e degli altri enti pubblici che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge provvedono, per conto o in convenzione con le amministrazioni provinciali, al ricovero ed alla cura degli infermi di mente, nonché la destinazione dei beni e del personale delle amministrazioni provinciali addetto ai presidi e servizi di assistenza psichiatrica e di igiene mentale. Quando tali presidi e servizi interessino più regioni, queste provvedono d'intesa. La regione, a partire dal 1° gennaio 1979, istituisce i servizi psichiatrici di cui all'articolo 35, utilizzando il personale dei servizi psichiatrici pubblici. Nei casi in cui nel territorio provinciale non esistano strutture pubbliche psichiatriche, la regione, nell'ambito del piano sanitario regionale e al fine di costituire i presidi per la tutela della salute mentale nelle unità sanitarie locali, disciplina la destinazione del personale, che ne faccia richiesta, delle strutture psichiatriche private che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge erogano assistenza in regime di convenzione, ed autorizza, ove necessario, l'assunzione per concorso di altro personale indispensabile al funzionamento di tali presidi. Sino all'adozione dei piani sanitari regionali di cui al primo comma i servizi di cui al quinto comma dell'articolo 34 sono ordinati secondo quanto previsto dal D.P.R. 27 marzo 1969, n. 128 , al fine di garantire la continuità dell'intervento sanitario a tutela della salute mentale, e sono dotati di un numero di posti letto non superiore a 15. Sino all'adozione e di provvedimenti delegati di cui all'art. 47 le attribuzioni in materia sanitaria del direttore, dei primari, degli aiuti e degli assistenti degli ospedali psichiatrici sono quelle stabilite, rispettivamente, dagli artt. 4 e 5 e dall'art. 7, D.P.R. 27 marzo 1969, n. 128 . Sino all'adozione dei piani sanitari regionali di cui al primo comma i divieti di cui all'art. 6 del D.L. 8 luglio 1974, n. 264 , convertito, con modificazioni, nella L. 17 agosto 1974, n. 386, sono estesi agli ospedali psichiatrici e neuropsichiatrici dipendenti dalle IPAB o da altri enti pubblici e dalle amministrazioni provinciali. Gli eventuali concorsi continuano ad essere espletati secondo le procedure applicate da ciascun ente prima dell'entrata in vigore della presente legge. Tra gli operatori sanitari di cui alla lettera i) dell'art. 27, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 , sono compresi gli infermieri di cui all'art. 24 del regolamento approvato con R.D. 16 agosto 1909, n. 615 . Fermo restando quanto previsto dalla lettera a) dell'art. 6 della presente legge la regione provvede all'aggiornamento e alla riqualificazione del personale infermieristico, nella previsione del superamento degli ospedali psichiatrici ed in vista delle nuove funzioni di tale personale nel complesso dei servizi per la tutela della salute mentale delle unità sanitarie locali. Restano in vigore le norme di cui all'art. 7, ultimo comma, L. 13 maggio 1978, n. 180
Controcanto - Mario Tobino e la controversia con Basaglia
«I novatori social-psichiatrici».
(Per le antiche scale, 1982, Arnoldo Mondadori Editore)
Così, con questo linguaggio sorpassato e con evidente fastidio, Mario Tobino – psichiatra e scrittore che esercita nei manicomi dal 1939 al 1980 - chiama gli psichiatri che sostengono le proposte di Franco Basaglia e di Psichiatria Democratica.
Tobino rappresenta – di fatto - il controcanto alla rivoluzione basagliana e della Legge n. 180, controcanto che cerchiamo di far emergere analizzando la controversia con Franco Basaglia, che, nel 1978, si sviluppa sui quotidiani La Nazione e Paese Sera.
Alla fine del testo si trovano una Nota Biografica, una Bibliografia e le Note, che permettono di leggere le esatte parole usate da Tobino e da Basaglia.
LA CONTROVERSIA
Tra i due psichiatri, a pochi giorni dalla approvazione della Legge 180, si svolge una discussione pubblica, molto dura, dipanata sulla stampa in tre articoli: Lasciateli in pace, il manicomio è la loro casa, scritto da Tobino e pubblicato il 18 aprile su La Nazione; una intervista di Paese sera a Basaglia, Magliano, le false donne (4 maggio 1978); Dolorosa follia, ho udito la tua voce, di nuovo su La Nazione, 7 maggio.
(Ringraziamo la Fondazione Mario Tobino che ha messo a disposizione - dai propri archivi - le immagini dei tre articoli linkate sopra).
LASCIATELI IN PACE
Lasciateli in pace nasce dai dubbi sulla legge 180 e sulla presumibile difficoltà nel metterla in atto, preoccupazioni condivise con alcuni medici e paramedici di Maggiano. Il contenuto rilevante è nella seconda parte dell’articolo, nel dialogo tra lo psichiatra e l’infermiere Scipioni, in cui si enunciano i principi della carità continua e dell’assistenza amorevole, senza sosta, verso i malati e verso le loro esigenze. Scipioni si fa rappresentante dei timori sulla abolizione degli ospedali psichiatrici, decretata dalla legge in procinto di essere approvata.
La preoccupazione di Scipioni – e di Tobino, che sembra parlare attraverso l’infermiere – è per il destino dei tanti malati. Soprattutto quelli anziani e soli, che hanno vissuto per anni nel manicomio di Lucca e che – una volta dimessi per decreto – non avrebbero un posto dove andare. Per loro non ci sarebbe nessuna famiglia ad accoglierli, sarebbero lasciati all’abbandono e allo scherno, se non alla violenza, del mondo “libero”.
In sostanza, Tobino difende l’istituzione manicomiale come luogo di cura e di protezione per i malati di mente; una casa, per loro che una casa “fuori” non avrebbero più. È l’appello di un medico che ha vissuto tra i matti e per i matti, che adotta un criterio morale con al primo posto la dignità e l’individualità complessa di ogni singolo malato.
UNA RISPOSTA POLITICA
La risposta di Basaglia su Paese sera è durissima, quasi violenta, su un registro completamente diverso da quello di Tobino: egli accusa Tobino di ostacolare il progresso della psichiatria, di puntare sulla dimensione emotiva[1], di essere lui stesso demagogico e sprezzante quando definisce la nuova linea della psichiatria demagogia e moda.
In questa intervista, Basaglia attacca violentemente la psichiatria tradizionale e manicomiale, che ritiene essere al servizio del potere per controllare le persone emarginate, e accusa Tobino di essere al servizio del potere[2] con il suo articolo.
Il suo discorso è di carattere politico: Franco Basaglia sostiene[3] che carità continua e aspetto umano non abbiano alcun significato e che Tobino non affronti il discorso politico che sta dietro al tema della chiusura dei manicomi; egli oppone - alla dignità dell’individuo di cui parla Tobino – la dimensione antropologica molto più ampia, teoretica, della dignità dell’uomo[4]; nega la possibilità di dialogare con le posizioni altre, perché lo ritiene inutile e impossibile[5], nell’ottica di distruggere il potere.
A conclusione dell’intervista, denigra l’avversario per minarne l’autorevolezza, attaccando il romanzo Le libere donne di Magliano[6] che, a suo avviso, contiene solo falsità[7].
L’ULTIMO ATTO, TOBINO RISPONDE SULLO STESSO PIANO
Mario Tobino non può esimersi dal controbattere alle accuse di Basaglia e lo fa 3 giorni dopo, sul quotidiano toscano La Nazione, con l’articolo intitolato Dolorosa follia, ho udito la tua voce.
La controrisposta non è più né aneddotica né di piglio letterario, ma calata nello spazio analitico, teorico e metodologico. [8]
Dopo un breve preambolo di deviazione dei colpi diretti alla sua persona, va diritto ai punti che gli premono: la realtà di manicomi ben diversi dalle prigioni; l’effettiva esistenza della follia [9]; l’inopportunità della chiusura dei manicomi.
In risposta alla ideologizzazione del concetto di manicomio - prigione, Tobino ricorda che le esperienze “liberalizzanti” di Gorizia, di Colorno e di Trieste – dove ha operato Basaglia - non sono le uniche in Italia, ma ne esistono altre, altrettanto “aperte” e innovative; che lo stesso manicomio di Lucca[10] fu tra i primi ad aprirsi; che, a Lucca, i matti sono trattati con attenzione alle singole esigenze, sono liberi e girano tranquillamente, giocano a carte, lavorano allo spaccio, fanno riparazioni, sostituiscono i custodi.
Tobino ricorda - e fa appello alla memoria dello stesso Basaglia – le manifestazioni della follia, i deliri, le urla e le violenze; reali, innegabili, spesso difficilmente controllabili; la follia, secondo Tobino è questa, non la si può dimenticare.
Ed è solo grazie alla nuova chimica, all’alleanza con gli psicofarmaci[11], che si danno questi progressi: senza di essi non sarebbe stato possibile né controllare la follia – pur sopprimendo[12] una parte della personalità dei malati – né aprire i manicomi.
È l’ultimo tema, quello della chiusura dei manicomi[13], su cui Tobino pone l’accento più accorato e pone le domande critiche: dove andranno i malati che da anni vivono nei manicomi e che non hanno un luogo dove andare? Come saranno assistiti sul territorio dove le strutture ipotizzate dalla Legge non esistono, dove i reparti psichiatrici negli ospedali avranno al massimo 15 posti?
Di fatto, Tobino, affronta in modo esplicito la dimensione politica della follia e ne sottolinea l’esistenza puntuale, sociale e contestuale, chiamando in causa la fragilità dei dispositivi della Legge 180, l’impreparazione del tessuto sociale e la necessità di un posto per questi malati, di sapere che c’è un luogo adatto alla follia, seppure mascherata dalla chimica.
UNA ANALISI DELLA CONTROVERSIA
Ci sono elementi, tra quelli che emergono dalla controversia, per i quali si può intravedere una possibilità di conciliazione. È il caso della cancellazione dei trattamenti coercitivi e segreganti dei soggetti psichiatrici e dell’apertura nei confronti della società e della quotidianità, che sembrano essere obiettivi comuni a entrambi gli psichiatri.
Entrambi, inoltre, sembrano essere su una linea simile sulla modalità di gestione dei pazienti non più internati: Basaglia parla di diffusione della cura sul territorio, di somministrazione delle cure vicino a dove stanno i malati, di reinserimento; Tobino ipotizza l’ospedale come luogo di riferimento[14] per il malato; entrambi coinvolgono i pazienti in attività costruttive di laboratorio o di lavoro socialmente utile.
Nel focalizzare i principi, i criteri morali, che stanno alla base di questa etica della psichiatria, si possono trovare alcuni medesimi fondamentali: l’attenzione al malato, la cura e non la repressione, l’occupazione come mezzo per restituire un senso del tempo e dell’utilità sociale, la libertà di scelta sul ricovero e sulla presenza nel luogo di cura, il rapporto con il tessuto sociale.
Invece, sul punto dell’esistenza o meno della follia, non è possibile una composizione della controversia: Tobino, seppure non escluda del tutto l’origine sociale, ha una visione organica, fisiologica della follia, e accusa[15] Basaglia di credere che la chiusura dei manicomi cancelli ogni traccia della follia. Basaglia, infatti, la nega e nello stesso tempo, ne attribuisce la creazione alla società malata, al potere, per rinchiudere i disallineati, i disturbatori dell’ordine e dello sfruttamento[16].
Altro punto di dissidio insanabile è il tema della presenza e della forma delle strutture di cura, che coinvolge anche la visione politica delle due posizioni: Tobino non prescinde dalla necessità di un luogo dove i matti possano trovare – per periodi lunghi o brevi, più o meno volontariamente, in modo comunque aperto – riparo, protezione, cura e tranquillità[17]; e sottolinea l’assenza di preparazione dei territori, della popolazione e delle famiglie per la trasformazione dalle strutture accentrate a quelle diffuse; Basaglia, al contrario, non transige, insiste sulla necessità di distruggere l’istituzione manicomiale[18] e ribadisce la necessità della riforma, da farsi subito, in nome della «crescita politica, e quindi civile e culturale del paese».
VINCITORI
A volte le controversie scientifiche hanno un vincitore (come tra Pasteur e Pouchet[19], a metà del XIX secolo), a volte nessuno, a volte vincitori e vinti, ben oltre i contendenti.
In questo caso, la “vittoria” arride a Basaglia e alle proposte di Psichiatria Democratica[20], che vedono il parlamento prendere atto del lavoro fatto[21] e varare la legge 13 maggio 1978, n. 180.
Oltre che dalla condizione di possibilità fornita dai farmaci, questa vittoria è stata decretata:
- dal fatto che il progetto di riforma della psichiatria è nato e cresciuto nel mezzo degli anni ’70[22], in un contesto con cui condivideva lo stile di pensiero[23], il linguaggio[24] e le forme di espressione;
- dall’abilità degli innovatori nell’arruolare le forze politiche usando – appunto – concetti evocativi irrinunciabili in quegli anni: libertà dalle costrizioni, distruzione delle istituzioni, lotta contro il potere; e evocando la lotta anche contro chi resiste all’innovazione[25].
- dalla leva su elementi motivazionali anch’essi parte integrante della cultura rivoluzionaria di quegli anni, come il senso di colpa della “società”, rea della creazione e dell’espulsione della follia e dei folli[26].
ALTRI VINCITORI E MOLTI PERDENTI
Alla lunga, hanno vinto, dopo 20-30 anni, tutte le persone colpite da problemi psichiatrici – depressione, psicosi, schizofrenia – che hanno guadagnato il diritto a essere curati restando, almeno in parte, all’interno del proprio tessuto sociale (grazie al duro lavoro di chi quella legge[27] ha voluto interpretare e attuare e grazie alla diffusione e alla messa a punto dei farmaci antipsicotici).
Hanno perso, invece, i matti che vivevano dentro ai manicomi, progressivamente espulsi, poiché – scrivono Corbellino e Jervis nel 2008 – l’impossibilità di nuovi ricoveri negli ospedali psichiatrici genera una drammatica situazione di mancata assistenza per i malati critici[28].
Hanno perso anche le famiglie dei ricoverati e dei nuovi malati che, a causa della fretta della rivoluzione e dell’assenza di reali alternative alla struttura psichiatrica, si trovano sulle spalle tutto il carico della gestione, i sacrifici e le tragedie[29].
Hanno perso, più di tutti, alcune centinaia di malati che – dimessi dal manicomio – sono morti per suicidio o accidentalmente, per incapacità di vivere in un mondo ad essi ormai sconosciuto.
Dice lo psichiatra Cherubino Trabucchi[30] che si tratta di duemila – tremila persone.
MARIO TOBINO, NOTA BIOGRAFICA
Mario Tobino nasce a Viareggio nel 1910, si laurea in medicina nel 1936 e prende la specializzazione in clinica delle malattie nervose e mentali nel 1941, con una tesi sulla necessità di una rifondazione umanizzante della psichiatria contemporanea.
Esercita come psichiatra nei manicomi dal 1939 al 1980: ad Ancona, a Gorizia e a Firenze San Salvi (1939-1940), dal 1941 al 1980 nell’ospedale psichiatrico di Maggiano, in provincia di Lucca, dal 1948 come primario del reparto femminile. Nel 1944 partecipa alla guerra partigiana. Vive all’interno del manicomio – nelle stanze dei medici – fino quasi alla morte (1991).
La scrittura contende alla psichiatria il ruolo di principale occupazione. Dalla prima raccolta di poesie del 1934 a Una vacanza romana del 1992, Tobino pubblica 4 raccolte di poesie e 23 romanzi e raccolte di racconti. Di questi, almeno 4 sono incentrati sull’esperienza psichiatrica a Maggiano: Le libere donne di Magliano, Per le antiche scale (Premio Campiello 1972), Gli ultimi giorni di Magliano, Il manicomio di Pechino (Premio Strega 1990).
BIBLIOGRAFIA
M. Tobino, Lasciateli in pace, il manicomio è la loro casa, La Nazione, 18 aprile 1978
F. Basaglia, Magliano: Le false donne, Paese sera, 4 maggio 1978
M. Tobino, Dolorosa follia, ho udito la tua voce, La Nazione, 7 maggio 1978
M. Tobino, Le libere donne di Magliano, Arnoldo Mondadori Editore, 1963
M. Tobino, Per le antiche scale, Arnoldo Mondadori Editore, 1972
M. Tobino, Gli ultimi giorni di Magliano, Arnoldo Mondadori Editore, 1982; Ed. del 2019, Mondadori Libri
M. Tobino, Il manicomio di Pechino, Mondadori, 1990
health, volume 14, 1985, issues 1 and 2, The Unfinished Revolution in Italian Psychiatry: An International Perspective
https://doi.org/10.1080/
G. Corbellino - G. Jervis, La razionalità negata: psichiatria e antipsichiatria in Italia, Bollati-Boringhieri, 2008
F. Basaglia, F. Ongaro, A. Pirella, S. Taverna, La nave che affonda, Cortina, 2008
V. Furlanetto, Cento giorni che non torno – Storie di pazzia, di ribellione e di libertà, Laterza, 2024
V. Andreoli, Fratelli di Carmelo Samonà: il matto in casa, in Il matto di carta. La follia nella letteratura, BUR, 2008
S. Redaelli, Circoscrivere la follia, Mario Tobino, Alda Merini, Carmelo Samonà, Sub Lupa Academic Publishing, Warsaw, 2013
NOTE
[1] Basaglia parla di «equivoca pietà» e di «agire emotivo» (Magliano: Le false donne, Paese sera, 4 maggio 1978)
[2] «il suo scritto rende un grosso servizio al potere, su questo non si può discutere» (Cit.)
[3] «Tobino parla “di carità continua e aspetto umano”. Quale significato hanno oggi queste espressioni? Nessuno. Il discorso è politico e Tobino non lo affronta. Anzi, finge di non affrontarlo poiché tutta l’impostazione del suo articolo è politicizzata al massimo» (Cit.)
[4] «la dignità dell’uomo, di tutti gli uomini» (Cit.)
[5] «instaurare un dialogo comune, generale […] impresa impossibile poiché l’istituzione che vogliamo distruggere è il potere stesso e nessuno rinuncia senza lottare al suo potere» (Cit.)
[6] Romanzo che lo stesso Basaglia, in gioventù, aveva amato e considerato una sorta di trattato psichiatrico (cfr. Magliano: Le false donne, Paese sera, 4 maggio 1978
[7] «a Gorizia […] ho potuto verificare ogni cosa, controllare ogni sensazione. Era tutto falso» (Cit.)
[8] «non ho potuto non sorridere quando ho letto che sarei strumento del dominante potere. Da quasi quarant'anni vivo al manicomio di Lucca e in verità mai sono stato in relazione, a contatto con chi comanda, chi è dominante. Per anni e anni la mia vita si è svolta in compagnia dei malati; adesso la mattina il primo dialogo lo faccio allo spaccio, al loro spaccio, dove vado a prendere il caffè e poi ancora durante la giornata. Nel dopopranzo sono solito passeggiare qui intorno e molto spesso con malati mi accompagno, malati liberi, che se la girano tranquillamente. La sera, dopo cena, quante volte ho giocato con loro a carte e, lo giuro, mai, mai abbiamo insieme trescato col potere, mai ordimmo per difenderlo» (Dolorosa Follia, ho udito la tua voce, La Nazione, 7 maggio 1978)
[9] Come già visto, in tutta la sua produzione Mario Tobino usa in modo diretto i termini follia, malattia mentale, matto/matti, lasciando poco spazio agli eufemismi; da una parte può essere un retaggio del periodo in cui ha studiato ed esercitato, dall’altra possiamo considerarlo un modo per non dimenticare di cosa si parla in termini comuni.
[10] Tobino definisce l’ospedale psichiatrico di Maggiano «libero e umano» e ricorda che «con entusiasmo […] fummo tra i primi a tirare giù i muri di cinta, strappare le inferriate, aprire, dare luce» (M. Tobino, Dolorosa follia, ho udito la tua voce, La Nazione, 7 maggio 1978)
[11] «nel 1952, arrivarono gli psicofarmaci che riescono a velare, a intorpidire, a rendere apparentemente molli molti segni della pazzia» (Cit.);
[12] «Sono stati gli psicofarmaci a rivoluzionare i manicomi e non le loro teste. E nemmeno si domandano se la follia loro la conoscono, se ne saprebbero distinguere il volto, loro che l'hanno frequentata soltanto dopo l'avvento degli psicofarmaci, se ne sanno la violenza, la fantasia, l'orrore, l'inesprimibile immacolatezza, l'impenetrabile lutto. E neppure amano conoscere, per nulla sono ansiosi di valutare di quanto con i composti chimici la follia è stata offuscata, travestita, mascherata (ma non vinta); e a volte costretta a brancolare.
Neppure sorge loro l'inquietante interrogativo, l'as-sillo morale, se è giusto con gli psicofarmaci ottundere la personalità, arginare, imbavagliare, legare una delle più profonde, meravigliose, misteriose manifestazioni umane: la follia.» (Gli ultimi giorni di Magliano, p. 20)
[13] « fuori, come gli andrebbe? I cittadini, che hanno da lavorare, che trascinano i loro affanni, li ascolterebbero, li sopporterebbero? I cittadini debbono essere sensibilizzati ma io finora di questa sensibilizzazione non ho visto nessun progresso, se anche non è aumentato il sospetto» (M. Tobino, Dolorosa follia, ho udito la tua voce, La Nazione, 7 maggio 1978)
[14] «[Un luogo] dove ritornare, rifarsi vedere, venire […] a prendere le cure, […] un luogo dove si entra e si esce tranquillamente» (Cit.)
[15] «io credo che la follia esista e Basaglia invece mi pare che sia convinto che, chiusi i manicomi, svanisca la cupa malinconia, l’architettura della paranoia, le catene delle ossessioni» (Cit.)
[16] «La follia non esiste, non è mai esistita. Sono stati la Società, il Potere a crearla [...] hanno eretto i manicomi per rinchiudere chi disturbava il loro sfruttamento [...]» (F. Basaglia, F. Ongaro, A. Pirella, S. Taverna, La nave che affonda, Cortina, 2008)
[17] Tobino è autore, nel 1958 in tempi non sospetti, insieme a due giovani architetti, di un progetto di «un futuro ospedale psichiatrico, un ospedale per matti in armonia con le vicende dei savi, un istituto che avesse, dopo le sequele di cattiverie, dopo tanto sangue versato, un grano, appena un grano di più di bontà e tolleranza» (Gli ultimi giorni di Magliano, ed. 2019, p. 206); per avere un’idea del progetto: Mappe del progetto per l'Ospedale di Vicenza (Mario Tobino, Giorgio Ramacciotti, Piero Marello) (MTb.II.30.41), Mostre Virtuali Ficlit, #3508
[18] «I manicomi […] noi diciamo che si possono distruggere e lo abbiamo dimostrato in anni di lotta» (F. Basaglia, Magliano: Le false donne, Paese sera, 4 maggio 1978)
[19] Cfr. H.M. Collins, T. Pinch, Il Golem, Tutto quello che dovremmo sapere sulla scienza, Edizioni Dedalo, 1995
[20] https://it.wikipedia.org/wiki/Psichiatria_Democratica, https://www.psichiatriademocratica.org/
[21] «Sono perciò soddisfatto che il Parlamento abbia preso ufficialmente atto della lotta di questi anni» (F. Basaglia, Magliano: Le false donne, Paese sera, 4 maggio 1978)
[22] Cfr. Franco Basaglia e la legge 180: frammenti dello scenario sociale e politico, Controversie, 4 dicembre 2024
[23] Cfr. L. Fleck, Genesi e sviluppo di un fatto scientifico : per una teoria dello stile e del collettivo di pensiero, Il Mulino, 1983; L. Fleck, Stili di pensiero, La conoscenza scientifica come creazione sociale, a cura di F. Coniglione, Mimesis Edizioni, 2019
[24] scrive Tobino: «Si indicono di continuo le riunioni - qualsiasi scusa è buona - alle quali debbono assistere medici, infermieri e anche malati di mente […] Nelle riunioni si rimuginano le prossime salutari innovazioni, ciò che si è in procinto di operare per il trionfo della giustizia, lo smascheramento del Potere, la liberazione degli schiavi, dei martiri», (Gli ultimi giorni di Magliano, p. 19)
[25] «Tutti hanno paura: sanno che il potere, quello politico in primo luogo - quello che in molti casi li ha fatti assumere nell'ospedale -, è con la 180, e con questo i mezzi di comunicazione» (M. Zappella, Introduzione a Gli ultimi giorni di Magliano, ed. 2019)
[26] «La follia non esiste, non è mai esistita. Sono stati la Società, il Potere a crearla [...] hanno eretto i manicomi per rinchiudere chi disturbava il loro sfruttamento [...]» (Paese sera, Cit.)
[27] La legge n. 180 e il suo successivo incoroporamento nella legge istitutiva del Servizio Sanitari Nazionale, Legge 23 dicembre 1978, n. 833.
[28] «La nuova legge rendeva immediatamente illegale ogni nuovo ricovero negli ospedali pubblici […] fattore principale che causò […] una drammatica – e talora tragica – carenza di assistenza per i nuovi pazienti affetti da disturbi mentali acuti e gravi» (G. Corbellino – G. Jervis, La razionalità negata: psichiatria e antipsichiatria in Italia, Bollati-Boringhieri, 2008)
[29] «gran parte del carico fu sostenuto dalle famiglie dei pazienti con grandissimi sacrifici e non poche vere tragedie» (Cit.)
[30] Gli ultimi giorni di Magliano, p. 258
Investire sulla relazione e sugli operatori - Intervista a Raffaella Bricchetti
L: Buongiorno Dott.ssa Bricchetti.
R: Buongiorno a Lei
L: Vorrei iniziare questa nostra chiacchierata chiedendole anzitutto se ci potesse raccontare qualcosa di Lei, di cosa fa. Per poter introdurre meglio i lettori nel vivo dell’intervista
R: Certo. Dunque, chi sono e cosa faccio... Sono laureata in filosofia specializzata in psicologia alla facoltà di Lettere e Filosofia con indirizzo psicologico all’Università Statale di Milano perché ai miei tempi le facoltà di psicologia erano solo a Padova e a Roma e non avendo la possibilità di andare a Padova per mille motivi familiari ho intrapreso questa strada. Laureata mi sono iscritta alla specializzazione e sono stati altri quattro anni. Ricordo tra i miei docenti anche il Dottor Musatti[1]. Nel frattempo, sia per la prima tesi, quella di facoltà, che per la tesi di specializzazione, avevo contattato il dottor Erba[2], che ai tempi lavorava al Paolo Pini (manicomio cittadino per eccellenza ai tempi) come psichiatra.
L: Ecco Dottoressa Bricchietti, può raccontarci per la sua esperienza la realtà manicomiale Italiana prima del 1978? Qual era il vero tessuto quotidiano dell’esperienza d’esser folli e del tentare di curare e lenire?
R: Certamente, come le dicevo ho conosciuto Erba nel ’74 e insieme abbiamo fatto la prima tesi (quella di facoltà) analizzando moltissimi casi di persone che arrivavano in manicomio. Persone con delle storie psichiatriche assolutamente incredibili, “gli alienati”. Persone che non potevano essere considerate soggetti, ma erano considerate semplicemente dei reietti che dovevano essere controllati, sedati, repressi perché creavano scompiglio all’interno della società. Ricordo in manicomio, ad esempio, quest’uomo di nome Luciano che era comunque una persona molto degna, non saprei come altro definirla, sempre vestito bene con camicia e giacca, mai sciatto o trasandato, di una famiglia modesta che dall’età di 15 anni l’aveva mandato in manicomio perché era un “masturbatore compulsivo”. Lui si masturbava sempre, continuamente, anche in manicomio poi lo faceva perché in realtà diciamocelo, cosa diavolo aveva da fare di meglio?! E così lui era lì da sempre.
Ai tempi i manicomi erano dei luoghi di contenimento perché queste persone venivano prese e lì stavano. Mi ricordo anche Angela, che è stata anche uno dei capitoli della mia tesi; quando l'abbiamo presa in considerazione era arrivata al centocinquantesimo ricovero. Lei entrava, stava dentro due giorni, si rifocillava un po' e poi se ne andava. Le porte le venivano riaperte sempre perché era una donna giovane di nessuna pericolosità né per sé né per gli altri... era molto bizzarra quello sì. Mi è capitato di rivederla poi dopo la chiusura del reparto psichiatrico e mi prese in giro dicendomi “ma guarda io ti ho vista che eri grande così!” Ecco, c'erano anche questi personaggi che andavano e venivano in questo reparto molto aperto. Faccia conto che in Italia ai tempi c’erano 98 manicomi con 100mila persone dentro. La cosa che colpì di più Basaglia quando entrò nell’ospedale di Gorizia fu “l’odore di morte e di piscio”, che è vero perché l’odore di morte e di piscio caratterizzava tutto.
Io da bambina mi ero fatta delle fantasie su come fosse un manicomio. Abitavo in un piccolo paese vicino a Brescia e c’erano alcune persone che lavoravano a Canton Mombello che era il manicomio di Brescia. Ai tempi la cosa che mi aveva incuriosito molto era che gli infermieri venivano assunti anche in base alla stazza perché più erano grandi, grossi e potenti più erano in grado di contenere le persone che avrebbero potuto avere delle manifestazioni violente. Questo anche per farvi capire il clima riguardo questi luoghi, le idee che circolavano. A me però questa voce mi aveva sempre incuriosita e quando decisi di fare la prima tesi di laurea sul tema fu perché avevo casualmente letto un articolo su un giornale in cui intervistavano Sergio Erba che aveva introdotto il concetto di “terapia della famiglia all’interno del manicomio”. Ecco questa cosa mi fece scattare ulteriormente la curiosità e gli chiesi di poter assistere e di poter fare la tesi. Mi avvicinai così alla settima divisione del Paolo Pini di Milano dove il Dottor Erba dirigeva un reparto. Quando entrai scoprì che il clima era completamente diverso da quello che avevo immaginato da bambina: ad esempio, il giovedì mattina c’era un’assemblea di reparto dove i pazienti non erano considerati dei numeri ma delle persone, ciò che poi è stato uno dei principi della Legge Basaglia, considerare la persona ricoverata una persona non da sedare o da contenere con fascette ma una persona con la quale parlare. Era faticoso e questa fatica non era tanto dovuta al comportamento dei pazienti, quanto dal personale infermieristico che non era abituato a mettersi in gioco nella relazione con il paziente. Era difficile per loro non intrattenere con i pazienti rapporti che non fossero di forza. Ad un certo punto infatti ci fu proprio una divisione degli infermieri tra chi voleva provare a lavorare in questa maniera e chi no. Così funzionava al piano dove c’era il Dottor Erba, al piano di sotto un altro psichiatra di cui non ricordo il nome procedeva con idee molto ma molto più tradizionaliste...
L: Nel 1978 grazie a Franco Basaglia inizia quindi il percorso verso la riorganizzazione dell’assistenza psichiatrica ospedaliera, ci racconti di questo periodo di transizione...
R: Faccia conto che io sono entrata in questo mondo nel ’74, la Legge 180 è del maggio ’78. Già prima comunque c’era una tendenza ad un approccio diverso alla malattia mentale solamente che era riservata al singolo psichiatra e al reparto dove lavorava, non era una cosa generalizzata e generalizzabile... Qualcosa a livello di chi operava nei contesti manicomiali si stava muovendo ma il livello di establishment diciamo “ufficiale” e politico era ancora orientato nel mantenere il manicomio come luogo di contenimento. È stato molto più difficile a livello istituzionale cambiare qualcosa. Le singole persone erano sicuramente più illuminate ma a livello di istituzioni è stato difficile. Con l’avvento della Legge Basaglia e la chiusura di questi manicomi uno dei temi di base della legge era proprio quella dell’umanizzazione del manicomio.
Basaglia aveva iniziato giovanissimo a Gorizia come direttore e lì aveva avuto grossi problemi. Era finito quindi a Colorno, in provincia di Parma, poi era andato a Trieste, insomma aveva girato vari manicomi sempre con questa idea che voglio esprimere leggendo proprio le sue parole:
“restituire l’individualità e la dignità ai pazienti che dovrebbero essere riconosciuti prima come esseri umani e poi come delle persone da riabilitare. La prima cosa da fare è sospendere ogni forma di giudizio e considerare l’individuo nella sua interezza partendo dalla sua storia, dal ruolo sociale svolto, dalle emozioni e dal malessere, per poi procedere con diagnosi e terapia ma evitando stigmatizzazioni inutili”. Questa legge è stata talmente rivoluzionaria che era arrivata ben prima alle orecchie di tanti psichiatri che non potevano ignorare queste cose. A Milano ad esempio c’era il “Gruppo di Psichiatria Democratica” che era molto attivo (ne facevano parte personaggi come Benedetto Saraceno[3], Leo Nahon[4] etc). I concetti quindi di cui parlava Basaglia li si maneggiava. Cercavamo di andare verso una nuova realtà, il desiderio di umanizzare il manicomio cercando di trasformarlo in quelle che potevano essere delle comunità terapeutiche dove per i pazienti, ad esempio, si iniziavano ad introdurre delle attività per evitare che questi passassero l’intera giornata a letto o in giro per i vialetti del Paolo Pini senza niente da fare se non fumare, fumare, fumare...
Un’altra innovazione di questo momento di transizione era l’idea di ricoverare anche i famigliari del paziente designato. Ricordo questi due ragazzi molto giovani che erano istituzionalizzati al Paolo Pini entrambi con diagnosi di schizofrenia e ad un certo punto venne invitata a rimanere tutta la famiglia, con questa madre molto dominante e un padre che si faceva più piccolino e la seguiva sempre da dietro. Questa donna arrivava sempre alle 9 del mattino con una borsa piena di cibo per i figli, che per altro erano magrissimi e lei riempiva loro la bocca di polpette, questi ragazzi me li ricordo come degli scoiattolini con le guanciotte piene di polpette che tenevano lì. La mattina avevamo un appuntamento fisso e si cercava di lavorare sulle dinamiche che venivano ad instaurarsi, ad un certo punto avevamo lavorato anche sul suo riempire le bocche dei figli. Insomma, esperienze ed esperimenti molto particolari.
La legge Basaglia comunque era molto bella nella teoria ma nella pratica è stata disattesa per molti anni. Addirittura se non ricordo male quelli che erano i precursori degli attuali Cps iniziarono ad aprire negli anni ’90. L’unica cosa rapida fu l’apertura dei reparti di psichiatria negli ospedali civili “normali” chiamiamoli così, come conseguenza immediata della chiusura manicomi.
L: Ma secondo lei quindi che cos’è cambiato veramente dopo che questi posti hanno chiuso?
R: Beh, hanno iniziato a creare i servizi di igiene mentale... A quei tempi Milano era divisa prima in 20 zone, poi 13, etc e una zona che faceva riferimento alla divisione del Paolo Pini era (adesso non si chiama più così) la zona 13 che era attorno all’aeroporto Forlanini (quindi via Mecenate, viale Ungheria etc) dove tutta la via Ungheria aveva un “buon gettito” di pazienti psichiatrici, invece la via Salomone erano tossici e lì cerano prima le case minime, poi le case bianche dove c’era, e forse c’è ancora oggi, una grossa presenza di tossicodipendenti. Quando hanno chiuso il Paolo Pini, hanno aperto in zona un ambulatorio con tre stanzette: una per l’infermeria, una per l’assistente sociale e una dove ruotavamo noi. Ecco lì siamo stati parecchi anni, nella stessa palazzina misero il consultorio e il fatto che ci fosse questa commistione tra matti e tossici (perché ai tempi ancora non avevano creato i servizi per la tossicodipendenza) non piaceva.
E nel concreto cosa succedeva, succedeva che c’erano appunto tutti questi tentativi di creazione di comunità terapeutiche, ambulatori zonali dove affluivano i pazienti psichiatrici mandati dai medici o che venivano ricoverati 10/15 giorni nei reparti di psichiatria e poi una volta dimessi passavano direttamente al territorio mandati con tanto di foglio di via in queste strutture per prendere contatti con il personale. Molti assumevano farmaci, per cui venivano a prenderli e a questo punto non ci si limitava a dare solamente il farmaco al paziente ma si cercava di parlare con lui, di vedere che cos’era successo nel frattempo, che cosa l’aveva portato in ospedale. Sempre in quell’ottica di umanizzazione e di rispetto della persona, di rendere la persona soggetto della propria potenziale -non tanto guarigione- quanto consapevolezza che il disagio che lui stava vivendo poteva essere affrontato diversamente e non solo con il farmaco. Ad esempio, se veniva una signora depressa si cercava di instaurare un approccio relazionale sia con lei, persona che arrivava portando una sofferenza, che con la famiglia.
L: Come prendevano i pazienti, a livello di cambiamento di approccio e non solo di cambiamento strutturale, l’esser trattati così diversamente, in questa maniera appunto relazionale?
R: Non era facile, non era facile. Però questo era ciò che ritenevamo l’approccio migliore cioè di “responsabilizzazione del paziente”. Il paziente non è oggetto di cura ma è soggetto. Il lavoro era quello di fare in modo che la persona si rendesse conto di essere portatore di una domanda e portatore di un possibile dimensionamento del suo star male. Solo lui poteva in qualche modo fare qualcosa per uscire da quella situazione. Noi, nella nostra posizione di curanti, potevamo “aiutarlo a”.
L: Lei prima diceva che però i manicomi erano dei luoghi per i pazienti di contenimento sì, ma in qualche modo luoghi in cui le persone che li abitavano ci avevano passato tutta la vita per poi ritrovarsi a dire “cosa faccio/dove vado”?
R: Assolutamente! Persone smarrite... Se vi ricordate Luciano di cui vi parlavo prima, quando hanno chiuso i manicomi lui si era trovato veramente perso perché dentro almeno era in una situazione molto protetta. Chiuso il manicomio lui è stato sbattuto fuori ma la famiglia non lo voleva, non sapevano dove cacciarlo e onestamente non mi pare siano riusciti a trovargli una sorta di comunità dove farlo stare... Mi pare di ricordare che non abbia vissuto a lungo fuori. Questo per dire che non è che ai tempi ci fossero i matti attaccati al cancello che urlavano “noi vogliamo uscire”, perché quello paradossalmente era un ambiente molto protetto dove le persone magari erano lì da sempre. Come dicevo anche per Angela; lei arrivava lì, mangiava un po’ perché magari passava qualche giorno in giro per Milano senza mangiare, e se ne andava. Era anche una Milano degli anni ’70 in cui la realtà fuori non è come quella di adesso. Io ai tempi ho visto solo un signore di colore nell’arco di tutta la mia esperienza, che era stato ricoverato perché aveva dato un po’ fuori di matto ma rimesso un attimo in sesto se ne era andato ed aveva continuato a fare quel che faceva, lavorare etc. Adesso credo che nelle odierne comunità terapeutiche ci siano molti più immigrati, piazzati ovunque senza esserci tante altre strutture per poterli ospitare...
L: Quindi lei crede che quello un tempo fosse un po’ un rifugio per gli emarginati sociali di allora...
R: Sicuramente... un’alternativa era il dormitorio di Viale Ortles. Perché una volta “liberati” dai manicomi questi soggetti non sapevano dove andare e andavano nei dormitori. Avevo avuto dei contatti con il direttore del dormitorio di viale Ortles anche per capire come cercare di fare questi passaggi perché non è che nei dormitori le persone poi potessero vivere: andavano là per dormire, stavano fino alla mattina alle 6, facevano la colazione ma poi dovevano andare fuori. Non c’era più quindi un luogo dove queste persone potevano stare 24 ore su 24. Il concetto di fondo però era quello del rispetto della persona, perché prima non era assolutamente così. Persona in quanto portatrice di un disagio, e quindi, nella sua storia come è nato, come si è evoluto questo disagio? Quindi, parlare e lavorare con queste persone.
L: Come prendeva l’opinione pubblica questo cambio di approccio in termini più relazionali di cui parlavamo poco prima?
R: L’opinione pubblica era arrabbiata! Comunque c’era ancora e credo ci sia tutt’ora una fetta più tradizionalista e in questo senso anche più assistenzialista, e le persone stesse arrivano da te con un’ottica di assistenzialismo. Riuscire a far cambiare alle persone questa ottica e renderli partecipi della terapeuticità della loro relazione non era facile. Persone che non ci stava anche ad assumersi la propria parte di responsabilità, volevano solo il farmaco e allora “va bene ti do il farmaco, però te lo do a modo mio”. Quando ad esempio venivano per fare le iniezioni depot[5] dei farmaci anti depressivi, questi nuovi infermieri erano capaci sì di fare l’iniezione ma anche di parlare con la persona, di cercare di sensibilizzarle in questo senso. Le famiglie spesso erano poco disposte a starci perché venivano messe in discussione, veniva messo in discussione il loro modo di relazionarsi con quello che doveva essere il paziente designato e magari le famiglie non avevano nessuna voglia di mettersi in gioco, era più comodo dire “lui è matto, è lui quello strambo, gli dia la medicina e a posto così”.
L: In Italia invece a livello di humus culturale, le persone erano spaventate da questo cambiamento?
R: Direi di no. Ma nemmeno gli importava così tanto anche perché le persone direttamente interessate non erano chissà quante e quindi si lavorava su quei numeri piccoli.
L: Siamo alla domanda finale, secondo lei, ad oggi c’è qualche aspetto che avrebbe bisogno di una nuova rivoluzione in ambito di salute mentale?
R: Sì. Ancora oggi fa molto più comodo somministrare quattro pillole piuttosto che tenere il paziente lì, una volta alla settimana, a parlare del suo male. Le cose sono cambiate ma fino ad un certo punto. Finché ho lavorato in consultorio sono sempre stata poco “ossequiosa” rispetto a quello che l’istituzione mi diceva di fare, ad esempio il pacchetto da dieci colloqui: io faccio i colloqui che mi servono, se il paziente ne vuole fare venti ne farà venti, se ne vuole fare cinque ne farà cinque ma lavoriamo insieme in quei venti o cinque che siano. Ho seguito ad esempio più pazienti per anni in consultorio, mandando su tutte le furie i responsabili. Adesso bisogna anche registrare tutte le prestazioni, c’è una sorta di controllo non tanto sui pazienti ma su noi operatori, ora. Per l’istituzione se tu fai più del tuo pacchetto standardizzato da dieci sedute con un paziente vuol dire che stai togliendo la possibilità ad un altro di utilizzarti e quindi tu devi fare dieci colloqui, punto. Finiti i dieci colloqui la persona che hai davanti speri si sia rimpannuncciata un po’ e se non si è rimpannuncciata pazienza e avanti il prossimo. Ora si cerca di lavorare sui comportamenti, così che la persona qualcosa modificherà, starà meno male in dieci appuntamenti e quindi vai, può arrivarne un altro che ha bisogno. Io questo non lo farò mai, faccio quello che ho imparato, lavorare con la relazione e quindi ho fatto così anche in consultorio.
L: Quindi se ci fosse una rivoluzione da fare ad oggi sarebbe quella di investire veramente sulla relazione?
R: Sì e anche di investire sugli operatori. Dare all’operatore la possibilità di lavorare un po’ più tranquillo rispetto alla registrazione della prestazione ad esempio. Io credo che questo approccio al disagio mentale ed emotivo non può passare attraverso una schematicità. Si sta tornando molto indietro ahimè...
***
Dovendo scrivere di Basaglia, dei suoi anni e di ciò che hanno rappresentato per la psichiatria italiana le sue intuizioni, ho pensato che potesse essere molto interessante parlarne con una persona che quegli anni li ha vissuti, permettendoci di rivivere la storia da un punto di vista privilegiato e originale in quanto legato al vissuto reale dei pazienti più ancora che alla teoria accademica.
Per chi scrive, giovane psicologa, alla luce di questa preziosa chiacchierata resta una sensazione di perdita. La sensazione è che oggi questo fermento di idee con al centro il benessere dei pazienti sia carente e si stia scivolando verso una standardizzazione di metodologie e un rigore operativo che lasciano poco spazio alla relazione.
Il sistema ha già riassorbito anche Basaglia e le idee di tutti i “rivoluzionari” di quegli anni?
NOTA BIOGRAFICA
Raffaella Bricchetti. Psicoterapeuta individuale e di coppia, laureata in Filosofia con indirizzo Psicologico e specializzata in Psicologia con indirizzo Sociale nel 1984, presso l’Università degli Studi di Milano. Dal 1974 collabora con la Scuola di Formazione Il Ruolo Terapeutico come docente clinica e teorica. Inoltre è redattrice della rivista “I Quaderni del Ruolo Terapeutico”.
NOTE
[1] Cesare Luigi Eugenio Musatti (Dolo, 21 settembre 1897 – Milano, 21 marzo 1989) è stato uno psicologo, psicoanalista, filosofo e politico italiano, tra i primi che posero le basi della psicoanalisi in Italia
[2] Sergio Erba psichiatria con formazione psicoanalitica. Dagli anni '60 sino all'85 ha lavorato per il servizio pubblico nella Clinica psichiatrica dell'Università di Milano, nell'Ospedale Psichiatrico P. Pini e al Centro psicosociale di zona 13. Fondatore della scuola "Il Ruolo Terapeutico" di Milano e dell’omonima rivista
[3] Benedetto Saraceno, Psichiatra ed esperto di sanità pubblica, ha lavorato a Trieste sotto la direzione di Franco Basaglia e a Milano come responsabile della Comunità per pazienti psicotici gravi prevista dalla legge Basaglia. Direttore del Laboratorio di epidemiologia e psichiatria sociale presso l’Istituto Mario Negri. È stato uno dei leader del movimento di Psichiatria antistituzionale e ha lavorato per molti anni in America latina, dove ha promosso modelli comunitari di assistenza psichiatrica ispirati alla difesa dei diritti umani dei pazienti. Dal 1999 al 2010 ha diretto il Dipartimento di salute mentale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità a Ginevra
[4] Leo Nahon, Psichiatra, è stato assistente di Franco Basaglia all’ospedale di Trieste. È stato poi Primario dei Servizi Psichiatrici di Vimercate e Carate e poi Direttore della Struttura Complessa di Psichiatria dell’Ospedale Niguarda a Milano.
[5] Letteralmente deriva dalla lingua francese e significa deposito. In medicina viene riferito a particolari formulazioni di farmaci che consentono l’accumulo nei tessuti ed il graduale rilascio nel tempo della sostanza terapeutica somministrata. Il farmaco quindi è disciolto in particolari veicoli oleosi che ne consentono lo stoccaggio nel tessuto muscolare (tramite iniezione intramuscolare profonda) o nelle mucose (mediante ovuli)
Rete psichiatrica sul territorio - Intervista a uno psichiatra che attuò la legge 180
Nell'ottica di raccontare la legge 180, descritta in altri articoli di questi speciale di Controversie, decido di cercare di farmi raccontare le pratiche di chi ha lavorato nel contesto sociale successivo alla promulgazione della legge. Così incontro Antonio Iraci, medico psichiatra. Mi invita gentilmente a casa sua una sera e fin dalle prime chiacchiere, i convenevoli, ci inoltriamo nel suo lavoro dei primi anni '90 nelle comunità della provincia di Como...
Antonio Iraci: A inizio anni ‘90 lavoravo per l’Unità Operativa di Psichiatria di Menaggio. Avevo l’area di Porlezza che all’epoca coincideva con tre vallate del profondo Nord: la Val Rezzo, la Val Cavargna e la Val Solda.
Ricordo queste case con un’unica stanza, la parte nera per il fumo del camino, un letto, un tavolo e le imprecazioni di chi vi abitava. Si andava anche solo per fare un’iniezione di farmaco depot, per garantire la continuità delle cure.
Racconto sempre di una paziente che si chiamava Nini. Le volevo molto bene e lei ne voleva a me. Non sempre il medico vuole bene al paziente! La Nini diceva di essere la moglie del sindaco dimessosi, ma che lei non si era affatto dimessa! La Nini manteneva il suo ruolo sociale interessandosi a tutto ciò che poteva essere di nocumento ai suoi concittadini. Faceva proclami per il paese e andava in chiesa a seguire ogni messa per poi salire sul pulpito alla fine dichiarando: “Adess parli mi”.
La Nini in una metropoli sarebbe stata rinchiusa. Lì, in effetti, si è riusciti a fare un grosso lavoro. In una riunione col sindaco e col prete spiegai loro che se le avessi dato un antipsicotico si sarebbe buttata dal balcone (era già successo): a volte i sintomi sono meccanismi di difesa e se io non sono più nessuno allora non ha senso vivere e mi butto.
Allora montammo una bacheca all’ingresso del paese dove lei poteva mettere tutti i suoi proclami. Aderì tutta la comunità e questo è l’esempio di un caso gestito tenendo conto di tutte le problematiche del momento. Dovevamo gestirla in termini sociali e ce l’abbiamo fatta. Perché quando i pazienti non sono più rinchiusi e rintanati in una struttura allora devi costruire processi di integrazione del paese.
Jacopo Gibertini: Raccontami per favore come arrivi a questo. Il tuo rapporto con l’antipsichiatria e la legge Basaglia.
AI: La comprensione di tutto parte, per me, verso la fine degli anni ‘70 dove mi arriva fra le mani un libro, che leggo, che si chiama L’io diviso di Laing (edizioni Einaudi, ancora oggi). Avevo 25/26 anni, stavo studiando medicina. Vado a capire chi è Laing, insieme a David Cooper mi intrigano. Erano parte di quella gente che veniva considerata l’antipsichiatria. Non quella di oggi che sono dei beceri ignoranti. Allora l’antipsichiatria era la base di quella che sarebbe diventata la psichiatria sociale.
Cosa diceva l'antipsichiatria? Che i folli non sono dentro al manicomio, ma fuori perché per aderire alle regole di questo modello sociale bisogna essere matti. Che è una posizione estrema, ma come tale riesce a farti vedere le cose in una certa nuova maniera.
Nel ‘78 poi viene approvata la legge 180. Legge Orsini, Basaglia ne fu il consulente. Allora c’era anche questa possibilità d’illuminazione da parte dei democristiani. Uno dei temi fondamentali della legge 180 era la decriminalizzazione del paziente psichiatrico. Banalmente si escluse dal TSO il criterio di pericolosità sociale, riducendolo a criteri esclusivamente clinici.
E questa mi è sembrato un elemento di civiltà, di grande civiltà. I manicomi poi resteranno aperti per altri 20 anni circa, nel ‘98 si arriva alla chiusura completa. Durante questo periodo, a esempio, a Como avvenne ancora qualche ricovero.
JG: A Como quindi c’era ancora la struttura e funzionante?
AI: Io entro nel servizio pubblico nel 1990. Il manicomio era ancora aperto e buona parte dei miei colleghi più anziani venivano dall’esperienza manicomiale. Così anche gli infermieri psichiatrici che dovevano essere forti fisicamente per poter gestire certe situazioni. Qualcuno di questi poi non aveva un grande afflato empatico e capitava che alcune zone del manicomio diventassero pericolose la sera. Per gli infermieri!
Declinare la legge 180 era un bel casino. Questi medici erano tutte persone di grande esperienza, come dicevano loro. Tu arrivavi ideologizzato, coi tuoi capelli lunghi e ti mandavano a cagare in tempo zero. Non ero da solo, ma abbiamo dovuto unirci e studiare. Capire, comprendere cosa volesse dire servizio territoriale.
Noi abbiamo voluto dare al servizio territoriale una logica di presa in carico totale del paziente. Tu sei sul territorio e lui avrà te come riferimento sempre e comunque, per qualsiasi cosa. Se il paziente necessità una visita, lo aiuti fino a prenotargliela tu. Così come si andava per le valli per le iniezioni quando stavo nel CPS di Menaggio. E territorio non è l’ambulatorio. Basaglia diceva che bisogna far entrare in qualche modo la città nel manicomio. Per questo mi piace raccontare l’esempio della Nini.
Abbiamo anche fondato una delle prime comunità della zona, a Montemezzo, nel 1991. Durante la costruzione della casa andavo a prendere 6/7 pazienti con un furgone che aveva ancora il clacson a pedale. Li portavo a Montemezzo durante la costruzione della casa. La logica era quella di una cooperativa orto-floreale, produzione in proprio e altre attività che oggi consociamo perché si sono diffuse. Si trattava di un luogo dove le persone potevano convivere condividendo un quotidiano supportato. Abbiamo anche scritto articoli e fatto un convegno su questo.
JG: Mi piace il fatto che avete dovuto studiare. C’era una teoria e un modo diverso di spiegare la psichiatria a cui avevate accesso, eravate ideologizzati come hai detto tu. Però era una teoria del fare psichiatria irriducibilmente legata alle persone e al territorio. Come lo applichi allora?
AI: L’aspetto di vivacità di quell’epoca è che ognuno diceva “qual è il senso del CPS? (Centro Psico Sociale)”, “qual è il senso di una comunità?”. Dovevamo costruire senso su queste cose. Il reparto psichiatrico - il Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura (SPDC) - aveva una sola funzione. Ci ricoveri una persona, fai i colloqui per arrivare a una diagnosi, imposti la terapia e rinvii la persona al servizio territoriale per la continuità delle cure. Lo SPDC poteva e può essere una stazione del percorso terapeutico. La sua funzione è che la persona recuperi delle competenze dopo la fase acuta e di scompenso.
Poi però devi avere una lettura del servizio psichiatrico come rete. In questa rete ci sono dei nodi che sono l’ambulatorio, l’attività domiciliare sul territorio, il CRA (Comunità Riabilitativa ad Alta Assistenza) e le comunità dove fare percorsi più lunghi di risocializzazione. Ognuna di queste realtà doveva produrre un pensiero. Partecipare alla costruzione di una cultura di riferimento che era il modello complessivo. E l’area del territorio era il fulcro della progettualità. Il progetto lo costruivi sulla base di ogni paziente che incontravi, delle sue esigenze, dei suoi bisogni, delle sue criticità e pensando alle strutture a disposizione del territorio.
Nel 1993 entro in reparto a Menaggio. Avevo passato 6 mesi lì in precedenza e mi era piaciuto perché vedevo che si potevano fare delle cose. Al tempo il reparto era gestito da un anziano che aveva una buona filosofia, ma trovavo che l’applicazione fosse carente. Quando lui se n’è andato dopo un anno, il sostituto non c’era e il primario di allora propose a me di prendere la direzione. Io ho detto “sì, se posso fare”. Lui era un illuminato e - a patto che gli parlassi dei miei progetti - mi ha lasciato fare.
Ho recuperato un gruppo di giovani infermieri senza esperienze e abbiamo iniziato a fare riunioni e formazione tra di noi. “Vediamo qual è il modo migliore per poter lavorare qui dentro” ci siamo detti, sulla base delle fantasie che avevamo e del lavoro che volevamo fare. È molto identitaria come cosa. Nel senso che concerne l’identità che ognuno di noi esprime facendo riferimento a sé e al mondo. Come voglio pensarmi lì dentro, come voglio che quel posto venga pensato. Tutti i nodi contribuivano, mi sono venuti dietro in modo esplosivo. Tutti avevano voce in capitolo.
Un giorno ho chiesto al primario illuminato di coinvolgere i familiari. Io stavo facendo la scuola sistemica di terapia della famiglia che prevede un setting di colloquio specifico: lo specchio unidirezionale. In questo modo hai due setting, quello della conduzione del colloquio e quello degli operatori che osservano. Io facevo i colloqui con i pazienti e dietro lo specchio gli infermieri e i familiari si formavano. Registravamo tutto con il loro consenso e quello del paziente e poi lavoravamo tutti insieme su quel materiale. Più teste sono meglio di una si diceva, abbiamo fatto dei lavori bellissimi.
Per avere lo specchio poi avevo avuto qualche difficoltà perché nessuno veniva inviato a costruire la stanza. Così un giorno, con il primario, ci siamo messi a tirare giù la parete! A quel punto l’ospedale ha mandato delle persone a fare il lavoro e abbiamo iniziato.
JG: E i parenti si prestavano volentieri a questo lavoro?
AI: Assolutamente. Eravamo diventati attrattivi, arrivavano pazienti anche da fuori provincia e ci mandavano i casi più impestati. E a noi piaceva perché cercavamo di capire come, in effetti, stessero funzionando le cose lì, in quella persona e in quel contesto familiare.
Noi puntavamo sempre a ridurre il più possibile l’istituzione, a dare un grande supporto ai familiari tirando fuori la persona dal reparto il prima possibile. Il reparto non è che un momento di sgancio in cui ci sistemiamo. Non ha senso se stai bene dentro il reparto. Devi star bene fuori dove c’è il casino. Ci arrivavano tutte le forme di psicosi e dovevi cercare di far sì che il paziente tornasse almeno a galleggiare nel migliore modo possibile, ma nella sua vita quotidiana.
Ti racconto un caso emblematico del lavoro fatto. Arrivano due genitori che avevano ricoverato la propria figlia per mesi in una clinica privata in Svizzera. Volevano valutare come fosse il reparto di Menaggio perché ormai raschiavano il fondo. Menaggio era bellissimo: luminoso, senza il tipico puzzo dolciastro da psichiatria, avevamo camere con vista lago! Se tu sei in un posto dignitoso stai dando dignità alle persone. Avevo anche scritto un articolo, Le mura terapeutiche…
Bene, questa paziente aveva un disturbo ossessivo compulsivo gravissimo. Il suo problema era che qualunque tipo di movimento lei facesse lasciava indietro pezzi di sé. Quindi lei doveva tornare indietro a riprenderli, rifacendo lo stesso movimento, più e più volte.
Abbiamo iniziato a lavorare con l’accordo dei genitori. Anche insieme a loro abbiamo parlato moltissimo con lei cercando di comprenderla. Abbiamo valutato una terapia, modificandola e sistemandola mano mano.
In un mese è passata da non muoversi dal letto – la sua isola – a muoversi e infine tornare a casa con un piano terapeutico e un progetto di psicoterapia, che in quel caso segui direttamente io. Dopo 5 mesi giocava a tennis! Successone! Certo, lei donna intelligente e laureata ha abbassato le sue aspettative professionali. Però si è impegnata, ha fatto del suo meglio riuscendo a vivere una vita più serena.
JG: Un’opinione diffusa e contraria alla legge 180 è quella per cui si è scaricato tutto sulle famiglie. Pensi che questo sia differente dove l’istituzione si adopera verso le famiglie? Non le lascia sole?
AI: Certo, dove questo succede. Sono stato anche responsabile del Servizio territoriale di Como dal 2005. Quando sono arrivato lì ho scoperto che l’ovvio è rivoluzionario.
Ricordo la Presidente dell’associazione delle famiglie dei pazienti psichiatrici arrivare da me entrando adagio con il cappello in mano dicendo “noi siamo i parenti e noi siamo i colpevoli del resto, perché abbiamo prodotto noi il paziente psichiatrico”. Io ho detto “no, voi adesso vi sedete e parliamo perché io ho bisogno di voi!”, “dobbiamo costruire progetti insieme”. Era un contesto che si dimostrava arretrato culturalmente perché abituato al modello ospedaliero, manicomiale.
Dico così ma ho lavorato molti anni in ospedale. Sempre però rimanendo nell’ottica della rete. Io ero un nodo della rete e ogni nodo deve funzionare come si deve. Se anche solo vuoi dare una terapia devi spiegare bene al paziente cosa sta prendendo e perché, devi prenderti il tempo e sapere che ha capito. Come dicono gli analisti con il farmaco si assume anche il medico. E se il medico è un oggetto buono, io assumo un oggetto buono. La famiglia è parte fondamentale di tutto questo, della rete.
JG: In questo rapporto tra istituzione e famiglia mi viene in mente una cosa che ho sentito spesso, cioè che nonostante – anzi contro – Basaglia ci fosse una fetta importante dell’accademia, conservatrice…
AI: La scuola milanese non ha mai amato il modello territoriale. Anche perché nel modello territoriale hai meno potere. Se stai nell’ospedale mantieni potenti i reparti di pischiatria. Era, secondo me, una politica della scuola di Milano quella di favorire il reparto tralasciando il territorio.
Del resto se andavi a Trieste, a Udine o Arezzo trovavi reparti con numeri ridotti di posti letto. A Trieste poi facevano persino la gestione della fase acuta a domicilio. Loro grazie al fatto che lì c’era stato Basaglia riuscivano a fare tutto.
Tu non ti relazioni solo con il paziente. Hai un rapporto con le istituzioni, con i colleghi, con le famiglie e con le città. Se non leggi questa complessità rischi di fare un lavoro come stanno facendo in questo momento.
Nell’anno 2000 eravamo 35 psichiatri in tutta la provincia di Como. Oggi ce ne sono 9 forse 10. È stato chiuso il reparto di Menaggio (nel 2022), stanno chiudendo quello di Cantù. Como avrà 28 posti letto. Pensare ad Arezzo che ne ha 8, Trieste che ne ha una decina ti dice quale livello di arretramento c’è stato. Ed è doloroso perché cosa vuoi fare con 10 colleghi? Arriveranno dei giovani psichiatri, ma qual è la cultura che hanno? C’è un progetto di riproporre una cultura territorialista? Chi la porta avanti? Qualcuno al governo arriva a dire di riaprire i manicomi… io mi incateno.
JG: Pensi che non sia comunque possibile un passaggio culturale tra chi è rimasto e i giovani che arrivano?
AI: In questo momento faccio fatica a pensarlo. Anche perché c’è una fatica generale di chi sta lavorando. L’unica cosa che devi fare adesso è gestire l’emergenza, urgenza per urgenza, non hai tempo di fare altro.
JG: Non pensi che potrebbero essere comunque in atto, in chi si sta specializzando ora, dei nuovi modelli positivi?
AI: Si stanno attivando dei modelli. Devi in ogni caso seguire una scuola di pensiero. Devi comunque approcciarti all’ambito psicoterapico. I milanesi portano avanti però la scuola cognitivo comportamentale. Perché si ritiene sia quella misurabile! Binswanger diceva che la scientificità all’interno della psicologia è il cancro della psicologia. Come puoi pensare di standardizzare l’umano?
Secondo il metodo scientifico quello che io riesco a fare qui, con te, dovrebbe riuscire a farlo un signore negli Stati Uniti con un altro. Non è standardizzabile! È un disastro così come i protocolli di intervento… e i tirocinanti vengono da me dicendo con orgoglio di essere cognitivo-comportamentali.
Va bene, mi dico sempre che son partito sistemico e non so cosa sono ora. Forse è giusto comunque partire da qualcosa, un qualcosa che ti struttura per poi andare oltre.
JG: Quindi in un certo modo i modelli sono utili. Far passare il senso in cui sono nati quei modelli è più difficile?
AI: Devi anche considerare che anche i modelli di patologia psichiatrica si sono evoluti nel tempo. È rarissimo oggi vedere una paziente con una manifestazione isterica di tipo charcotiano. Adesso sono esplosi gli attacchi di panico. Depressioni in quantità notevoli (e c’è da dire che le terapie farmacologiche aiutano molto). Le psicosi sono molto ridotte mentre si ha un aumento vertiginoso delle nevrosi e dei disturbi della condotta alimentare così come delle tossicofilie in comorbilità con le patologie psichiatriche. Un aumento di circa il 30% della casistica, limitandosi a quella misurabile, quindi è una stima per difetto.
Inoltre, è cambiata anche la qualità dei pazienti e in mancanza di una cultura di riferimento anche i modelli organizzativi sono inutili. L’espansione delle sostanze psicoattive, a esempio, l’aumento delle persone intossicate e il relativo aumento delle aggressioni fuori e dentro l’ospedale ne sono un esempio. Il paziente psichiatrico è solitamente dentro a un mondo tale che è difficile riesca a far del male a qualcuno. Al contrario l’intossicato da cocaina o crack può esser molto pericoloso.
Senza un’organizzazione basata sul territorio di riferimento, si cerca poi di scaricare i pazienti socialmente pericolosi sui reparti di psichiatria o sulle CRA (Comunità Riabilitative ad Alta Assistenza). Questo è uno degli effetti del non aver pensato strutture adeguate dopo la chiusura degli Ospedali giudiziari. Quando lavoravo in ospedale c’era una lista di attesa di 70 pazienti per le REMS. Il reparto era diventato l’anticamera delle REMS, ma questo è pericolosissimo e io mi sono sempre opposto.
Torno alla tua domanda. Far passare il modello è una questione più delicata. Sono stato richiamato in servizio per sostenere l'ambulatorio per i disturbi della condotta alimentare, ma credo che a dicembre di quest’anno mi fermerò, in fondo sono un pensionato. Poi credo anche che probabilmente, se arriva il nuovo psichiatra, continuerò a lavorare per affiancarlo nel passaggio. Se mi sta simpatico. Nel frattempo passerò le prossime settimane a costruire un modello per i disturbi del comportamento alimentare. Mi aiuterà la dottoressa Floris, psicoterapeuta con cui lavoro da tempo. Sarà un modello territoriale perché è a casa che ci sono i problemi.
Franco Basaglia e la legge 180: frammenti dello scenario sociale e politico
Franco Basaglia nasce a Venezia nel 1924, un anno e mezzo dopo la presa di potere fascista.
Cresce e studia tra regime fascista e Seconda guerra mondiale. Consegue la maturità classica nel 1943; poi, si iscrive a medicina a Padova, dove svolge anche attività antifascista, che lo porta all’arresto, nel dicembre del 1944. Resta in carcere fino ad aprile del 1945, alla fine della guerra.
Nel 1949 si laurea in medicina e inizia la pratica clinica nel dipartimento per le malattie nervose e mentali di Padova, studia con Roberto Belloni, pioniere della neurofisiologia clinica, della neurochimica applicata e della neuroradiologia, base diagnostica delle neuroscienze cliniche padovane.
Negli anni dell’Università e della pratica clinica si dedica anche allo studio filosofico, all’esistenzialismo di Sartre, alla psichiatria fenomenologia di L. Binswanger.
Nel 1953 si specializza in malattie nervose e mentali e sposa Franca Ongaro, che – a differenza di quanto spesso si pensa – non era medica, né psicologa, ma letterata. Con lei lavora per tutta la vita.
Dal 1953 al 1961, assistente di Belloni a Padova, si dedica alla ricerca e alla pratica clinica, come; nel 1958 ottiene la libera docenza in psichiatria.
Il 1961 è l’anno della svolta: Franco Basaglia inizia il rivoluzionario lavoro di direzione dell’ospedale psichiatrico di Gorizia.
Tra il 1961 e il 1970 visita una comunità terapeutica di Maxwell Jones in Scozia e le esperienze di apertura francesi. Nel 1967 cura il volume Che cos'è la psichiatria? e nel 1968 L'istituzione negata. Rapporto da un ospedale psichiatrico, che racconta l'esperienza di Gorizia.
Tra il 1970 e il 1971, dirige – per poco tempo – la struttura psichiatrica di Colorno, vicino a Parma e, nel 1971, accetta la direzione dell’ospedale psichiatrico di Trieste, enorme struttura che sorge sul colle di San Giovanni e ospita 1182 malati di cui 840 sottoposti a regime coatto.
Trieste è il luogo in cui mette in pratica, in modo ampio e completo, il suo approccio di normalizzazione della malattia mentale e di apertura dell’ospedale psichiatrico alla città e della città all’ospedale psichiatrico.
Nel 1973 fonda la Società Italiana di Psichiatria Democratica; nello stesso anno l’Organizzazione Mondiale della Sanità riconosce Trieste come zona pilota per la ricerca sui servizi per la salute mentale.
Il 1978 è l’anno in cui il suo approccio prende forma in termini istituzionali con l’approvazione della legge 13 maggio 1978, n. 180 - la Legge Orsini, chiamata quasi sempre Legge Basaglia – che abroga quasi completamente la legge del 14 febbraio 1904, n.36 e che impone la chiusura dei manicomi, regolamenta il trattamento sanitario obbligatorio e istituisce i servizi di igiene mentale pubblici.
Franco Basaglia nel 1980 prende servizio come coordinatore dei servizi psichiatrici della Regione Lazio – dove potrebbe mettere in pratica il modello di psichiatria aperta e territoriale ma, colpito da un tumore, muore nel mese di agosto, a 56 anni.
FRAMMENTI DI CONTESTO SOCIALE ED ECONOMICO
Per comprendere “dove e come” nascono ed evolvono il pensiero e l’opera di Franco Basaglia e dei suoi colleghi, abbiamo provato a isolare alcuni frammenti di contesto che esemplificano quale fosse lo stile di pensiero che ha accompagnato questa evoluzione.
FRAMMENTO #1– IL REGIME FASCISTA
Franco Basaglia studia tra fascismo e Seconda guerra mondiale e viene incarcerato per alcuni mesi tra 1944 e 1945, per attività antifascista. È il periodo in cui, gli eccessi fascisti e nazisti, le leggi razziali e la repressione politica stimolano il desiderio di libertà. Durante il regime fascista le libertà fondamentali, di parole, di movimento, di educazione e di professione sono negate e il manicomio – più che nel passato -è usato come strumento politico, di contenimento, non solo della cosiddetta devianza sociale e mentale, ma anche della opposizione politica.
Un caso emblematico è quello di «Giuseppe Massarenti, leader del movimento bracciantile emiliano e poi sindaco socialista di Molinella – ricordato come il Santo del Socialismo italiano – fu mandato al confino nel 1926 e da lì seguirà un doloroso processo di impoverimento e di caduta nella marginalità che si concluse con il trasferimento alla Clinica delle malattie nervose e mentali di Roma prima e al celebre ospedale psichiatrico della capitale – il Santa Maria della Pietà – poi. Delirio paranoico la prognosi. Un classico» (Petracci M., I matti del duce. Manicomi e repressione politica nell’Italia fascista, 2014, Donzelli, XVIII, p. 238).
Durante il regime di Mussolini il numero di reclusi psichiatrici quasi raddoppia rispetto ai decenni precedenti, i manicomi italiani passano ad ospitare da 55 mila (dati del 1920) a 95 mila persone (dati del 1941)[1]
FRAMMENTO #2 – L’IMMEDIATO DOPOGUERRA
Il periodo della laurea e degli studi per la specializzazione scorre tra la fine della guerra e i primi anni ’60. Sono gli anni del boom economico, della scoperta del benessere, in Italia, per (quasi) tutti, della condanna delle miserie come quelle dei Sassi di Matera (la visita di P. Togliatti a Matera è del 1948), dell’affermazione di una nuova economia industriale – della Fiat che “importa” manodopera dal sud del Paese, della “fabbrica aperta” di Adriano Olivetti; sono anni in cui – sollevata dall’oppressione del regime, dalle disgrazie della guerra e dalla miseria delle difficoltà economiche - la società italiana può pensare anche a cose marginali: i matti e la malattia mentale, per esempio, le modalità coercitive in cui vengono trattati.
Nel 1957 Sergio Zavoli realizza il documentario radiofonico Clausura all’interno di un monastero di clausura delle Carmelitane scalze e – intervistando Padre Rotondi, cita Pio XII che, nell’enciclica Sponsa Christi aveva definito non più tollerabili certi disagi in cui vivono le monache di clausura.
Questo atteggiamento – però - non sembra toccare la facoltà di medicina di Padova e – in particolare – l’istituto di malattie nervose e mentali, diretto da Belloni, che era «intriso di positivismo scientista e lombrosiano […] fedele alla tesi organicistica che vede la malattia mentale come la conseguenza di tare biologiche congenite».
In quegli stessi anni, la fenomenologia e l’esistenzialismo dominano la scena filosofica e si spingono all’interno del perimetro della psicologia, della medicina, della psichiatria.
FRAMMENTO #3: GLI ANNI ’60, FINO AL 1968
Il periodo in cui Basaglia dirige l’ospedale psichiatrico di Trieste, tra il 1961 e il 1970, è quello in cui maturano le istanze che sfoceranno nella “rivoluzione” del 1968.
È un vero e proprio tentativo di rovesciamento del paradigma sociale, in cui la tradizione e la conservazione dei valori borghesi della fine del XIX secolo e anche del primo dopoguerra – gli stessi valori di ricerca del benessere economico che hanno favorito l’attenzione ai marginali – vengono messi in crisi.
Sono gli anni in cui si parla, si scrive, si canta e si urla – nelle manifestazioni e nei momenti di lotta - di immaginazione al potere, di libertà da ogni costrizione – culturale, sociale, sessuale.
È nel 1968 che il Ministro della Sanità Luigi Mariotti firma la Legge di riforma psichiatrica che porta il suo nome e che abolisce l’obbligo di iscrizione nel Casellario giudiziale e prevede la possibilità del ricovero volontario e i Centri di Igiene Mentale con equipe multi professionali composte da psichiatri, psicologi, infermieri, assistenti sociali [2]
Sono gli anni in cui inizia la fine del boom economico e – sulla scia del libertarismo del ’68 – si affermano le istanze di rivendicazione economica e sociale dei lavoratori delle fabbriche, sostenuti da ampie schiere di studenti liceali e universitari.
Nel 1968, ancora Zavoli, “entra” nel manicomio di Gorizia con le telecamere di TV7 a documentare
FRAMMENTO #4: DAL 1968 AL 1978
Negli anni tra il 1968 e la promulgazione della Legge 180 accadono fatti che possono essere ricordati come elementi rilevanti per la formazione del pensiero di Basaglia e del suo gruppo di co-pensatori, per il favore che questo pensiero può trovare tra società e contesto politico.
Si tratta – ad esempio - della crescita di consenso del Partito Comunista Italiano, che nel 1976 raggiunge il 34% delle preferenze, guadagnando quasi 10 punti percentuali e 5 milioni di voti rispetto al 1963, a solo 4 punti dalla Democrazia Cristiana.
Si tratta anche del tentativo di rovesciare il paradigma di contrapposizione partitica tra DC e PCI, che aveva dominato fino ad allora, attraverso la formula del compromesso storico che si sostanziò prima nel governo di solidarietà nazionale (1976), a guida Andreotti, e nell’ipotesi di entrata del Partito Comunista nella compagine del successivo governo, studiata da Enrico Berlinguer e da Aldo Moro e sostenuta da Zaccagnini. Il compromesso storico naufragò proprio nel 1978 con il rapimento e la successiva uccisione di Aldo Moro.
Sono anche gli anni del sindacalismo, della promulgazione della Legge 20 maggio 1970, n. 300 nota come Statuto dei lavoratori, che riconosce formalmente e in maniera organica una serie di diritti ai lavoratori di tutti i comparti, diritti fino ad allora spesso negati o ignorati, a partire dal Diritto all’opinione (Art. 1 della Legge Cit.) e del diritto all’Assemblea Sindacale, considerata in molti casi un atto di sedizione.
E del contro-sindacalismo: nel 1969 vengono ufficialmente riconosciuti i consigli di fabbrica; Alla fine del 1970 i CdF sono già 1.374 con 22.609 delegati: nel 1971, 2.566 con 30.493 delegati, nel 1972 un totale di 83.000 delegati; non mancano - però – le forme di opposizione da parte di alcune frange sindacali, che vedono nel Consiglio di Fabbrica un sistema per ingabbiare la protesta e suggeriscono mezzi di espressione con base più ampia e – in alcuni casi – modi più aggressivi.
Le assemblee sono un elemento chiave dei due decenni che seguono il 1960: note solo come momenti di aggregazione partitica o di movimento – molto spesso clandestine - diventano in breve tempo uno degli strumenti teoricamente portatori di democrazia più diffusi nelle fabbriche, nelle aziende, nelle scuole e nelle università; tutto si discute in assemblea, tutto si decide in assemblea, tutti i leader vengono nominato o acclamati in assemblea.
Le assemblee sono un modo per fare sentire la propria voce, per fare partecipare, per sentirsi liberi; Libertà è partecipazione, canta Giorgio Gaber nel 1972.
Far sentire la voce di chi non l’ha mai avuta in pubblico è anche uno dei momenti – chiave delle prime radio libere “impegnate”[3], che fanno intervenire gli ascoltatori al telefono in diretta.
Tra le voci che conquistano il diritto ad essere – finalmente – ascoltate ci sono quelle delle donne che, ad esempio, nonostante dure opposizioni interne, conquistano una propria progressiva rilevanza all’interno dei movimenti sindacali verso la metà degli anni ’70; e lo fanno con assemblee e comitati femminili, non contrapposti ma paralleli a quelli sindacali ufficiali.
E, a Verona, nel 1976, si svolge il primo processo per stupro in cui la vittima rifiuta di interpretare il ruolo passivo di “oggetto” della violenza sessuale per diventare “soggetto” di un’accusa che trascende i suoi stupratori, spiegando quanto la sua vicenda “personale” sia in realtà “politica”. In aula la ragazza è sostenuta dalla presenza di un coordinamento di gruppi femministi e la sua voce – non più silenziata come nei casi analoghi – si fa sentire in una dimensione pubblica, grazie alla copertura dei media più tradizionali e della televisione, che ne fa un documentario trasmesso in prima serata alla fine di ottobre dello stesso anno.
-----------
È in questo scenario o, meglio, questo susseguirsi di scenari sociali e politici – delineato in pochi tratti a cui manca sicuramente molta “storia” – che si forma l’esperienza e la rivoluzione di Franco Basaglia, di Franca Ongaro, di Giovanni Jervis e dei loro colleghi.
Idee ed esperienze che attingono anche a quella che fu chiamata da Pasolini – e non a torto - «ubriacatura di astrazione teorica» ma che ha sicuramente segnato la trasformazione della società italiana dal dopoguerra alla fine degli anni ’70.
NOTE
[1] Cfr. Petracci M., Cit.
[2] Reggio Emilia è in prima fila nell’avvio dell’esperienza territoriale e nel 1968 la Provincia apre i primi Centri di Igiene Mentale, affidati dal 1969 a Giovanni Jervis, psichiatra che aveva lavorato con Basaglia a Gorizia.
[3] Cfr. F. Monteleone, Storia della radio e della televisione in Italia, Feltrinelli, 2021
Epistemologia e clinica (oltre la politica) in Franco Basaglia
“Basaglia” è il nome di una rivoluzione quasi universalmente riconosciuta, anche se poco o nulla applicata fuori dall’Italia. I dibattiti sulla legge 180, sulle sue luci impossibili da spegnere, ma anche sui suoi limiti attuali, si susseguono ciclicamente. Spesso il Basaglia clinico tende a essere offuscato dalla, giustamente celebre, portata politica della sua battaglia e del suo gesto. Eppure, clinica e politica, in lui, sono legati.
Figlio della tradizione della psichiatria fenomenologica, esistenziale, dasein-analitica, in lui sono costanti i riferimenti a pensatori ritenuti fondamentali fino agli anni 60’-70’, e oggi un po’ in ombra, come Sartre, Heidegger, Merlau-Ponty, Husserl, Biswanger. Autori politici, ognuno a suo modo, da cui Basaglia trarrà i propri echi; correnti di pensiero appunto, non solo strettamente filosofiche, tali da investire tutti i campi delle scienze cosiddette “umane”.
La psichiatria è chiaramente una scienza limite, avendo come oggetto qualcosa di eternamente sfuggente come l’umano, rimanendo con un piede o entrambi, all’interno di un’altra scienza limite, cioè la medicina.
Medicina: sapere, tecnica, che unisce arte, nel senso ippocratico, e scienza transitata nella cornice del moderno. E sullo psi della iatreia (cura), su cosa sia o come sia quella psyché a salire fino alla nostra “psiche” o “mente” la risposta non è definitiva.
Tantomeno sulle sue malattie e le sue cure. Ne consegue che teoria e prassi, epistemologia e azione sono indissociabili; di qui, il problema storico, sociologico e infine politico non cesserà mai di ripresentarsi.
In Un problema di psichiatria istituzionale e testi vicini (L’ideologia del corpo, Corpo, sguardo e silenzio, ecc), l’originalità dell’intreccio che presenta Basaglia è evidente: emerge una teoria della clinica come specchio di una teoria politico-critica.
Il sottotitolo è eloquente: L’esclusione come categoria socio-psichiatrica. Da un punto di vista di filosofia politica, o anche socio-antropologico, la categoria dell’escluso è inerente a ogni società, e in particolare in quelle dove siano presenti divisioni gerarchiche.
Il capro espiatorio è quel “dispositivo” (politico, sociologico, antropologico) in cui le contraddizioni di una società vanno a concretizzarsi, scaricando l’aggressività che esse comportano.
Ma il malato mentale ha una sua peculiarità: egli è posto fuori dalla dialettica. Quelli che oggi chiameremmo “gruppi marginalizzati” hanno sempre avuto un potenziale attivo di rivolta. Il malato mentale è una figura più enigmatica: se Foucault voleva dare parola alla follia, è perché essa non parla mai in modo univoco, e dunque è al confine col silenzio; ma se il malato mentale è ridotto all’espressione della propria malattia, confine sempre aperto, la sua stessa parola sarà puro silenzio.
Così funziona la realtà di quest’esclusione peculiare: ogni parola di risposta, di tentativo di dialettica, è nuovo rinforzo, motivo per prolungare l’esclusione.
Il tutto comporta per Basaglia, che egli è all’interno della sua stessa epistemologia, cioè nel dispositivo per dire e poi curare, trattare, la follia come malattia mentale. Comporta che la psichiatria può trovare le leve per dialettizzare il malato. Le parole quasi d’ordine dell’impianto degli autori sopracitati sono imperniate intorno alla soggettività, alla libertà, al corpo, alla scelta.
Il problema centrale per quest’approccio è la questione della scelta, scelta di sé come libertà e dell’angoscia che questa comporta, eco esistenzialista, la cui difesa primigenia è l’esclusione. Ma non solo: l’altro da sé è anche la propria “fattità”.
Fattità che si è come corpo, “corpo oggettuale”, opacità, passività, nonché soggetto delle percezioni, corporeità con cui si è nel mondo (Merleau-Ponty), di cui ci si deve appropriare per essere soggetti di scelta propria, cioè per soggettivarsi.
L’opacità è anche, specularmente, quella dell’altro. Dunque, incorporare la propria estraneità è parte dello stesso processo del riconoscere l’altro come altro da sé. Non solo come oggetto, come “concretizzazione” dell’estraneità che si rifiuta, ma come a sua volta luogo di una soggettività. Corpo oggettuale, ma anche – husserlianamente – centro di un “io fungente”.
Al contrario, la mancata appropriazione della propria opacità corporea – della vulnerabilità, della materialità – dell’essere corpo-oggetto sia di se stessi sia dello sguardo altrui porterà alla sua esclusione nell’altro divenuto “osceno”. Altro incomprensibile e dunque riducibile soltanto a oggetto, così come a oggetto dell’altro si è sempre ricondotti in questa dinamica.
La genialità di Basaglia, nell’intrecciare clinica e politica, sta qui nel proporre una diagnosi strutturale tra nevrosi e psicosi, capisaldi freudiani, come due modi di essere-nel-mondo con connotazione politica: esclusione ideologica e utopia psicotica. Se per Freud il conflitto centrale della prima è tra Io ed Es, per accettazione del mondo esterno, quello della seconda tra Io e mondo esterno, per lo strabordare dell’Es, qui il conflitto è frutto di un’esclusione del reale.
Per il nevrotico tale esclusione è ideologica, nel senso che non v’è rinuncia a un rapporto con l’altro, ma comunque rifiuto della propria contingenza, dell’ansia derivante dalla scelta di sé e dell’appropriazione del proprio corpo.
Come risposta – o difesa – edificherà un’ideologia, un’immagine “ideale” del corpo, con cui controllarne l’opacità, potendosi per lo meno relazionare con l’altro per il quale avrà comunque una certa oblatività.
È sull’altro e nel desiderio di essere accettato, che egli la edificherà. Pagando questo al prezzo di un’angoscia che produce inibizione, indeterminazione, restringimento.
L’altro è dunque mantenuto nella sua soggettività, sempre nel filtro di un’ideologia che lo conduce alla malafede sartriana.
Per lo psicotico, invece, il rifiuto è ben più radicale. Il risultato di questo processo non è la costruzione di un’ideologia, ma di un’utopia.
La contestazione che il reale continua a far irrompere, reale come opacità, viene a tal punto mal tollerata che è solo nel delirio – cioè in una costruzione sganciata dall’altro, dal “co-mondano” – che uno psicotico potrà trovare una sorta di stabilizzazione e controllo.
Ma proprio lì è un mondo senza limiti, sotto la costante minaccia di quell’angoscia che non cesserà di tormentarlo, divenendo sempre più schiacciante e distruttiva con conseguenti difese estreme.
Se la terminologia politica è qui esplicita, diviene evidente il problema politico dei manicomi: alla regressione psicotica viene aggiunta, intrecciata, una regressione istituzionale. All’esclusione che il malato opera si aggiunge l’esclusione che la società opera su di lui attraverso le mura del manicomio, difesa non del malato, ma dei sani.
L’opacità, l’incomprensibilità del malato di mente, è ridotta a pericolosità sociale. Egli rimane quell’“osceno” (fuori-scena) privo di qualunque soggettività. Alla malattia si sovrappone dunque una malattia indotta direttamente dall’istituzione, in un circolo vizioso in cui le due diventano indistinguibili, fortificandosi a vicenda e giustificando quindi l’apparato manicomiale.
Il restringimento dell’Io – il rimpicciolimento, il rinchiudersi della soggettività, a cui già fa fronte il malato – è speculare al risultato di quella “carriera morale” a cui è sottoposto dall’istituzione disciplinare. L’Io è ridotto a spettro, uomo privato di tutto, homo sacer o musulmano di Auschiwtz, seguendo la concettualizzazione successiva di Giorgio Agamben: non a caso c’è riferimento esplicito a Primo Levi.
È qui che si innesta una specifica teoria del potere: rifiuto dell’autorità o dell’autoritarismo, ma non rifiuto del potere tout court. Perché il potere contiene in sé anche lo spazio di una dialettica, che non si riduca a quella servo-signore hegeliana.
Da questo breve excursus si può notare come epistemologia, clinica e politica non siano dissociabili. Al netto dell’impossibilità di liberarsi della contingenza, in particolare storica, quando si tratta della prassi, Basaglia offre un originale e si spera non dimenticato esempio di questo gesto di annodamento.
La morale della storI.A. - Corpus documentali, training e decisioni
GENTE DI TROPPA FEDE
Nel libro Paura della scienza Enrico Pedemonte racconta che nel Kentucky, a Petersburg, il pastore australiano Ken Ham ha investito 27 milioni di dollari per costruire un parco tematico in cui la storia della Terra viene esposta secondo il punto di vista della Bibbia. Dalla sua fondazione, nel 2007, il Creation Museum ha accolto oltre 3 milioni e mezzo di visitatori, che hanno potuto vedere con i loro occhi come il nostro pianeta non conti più di 6.000 anni di vita, e come i dinosauri esistessero ancora durante il Medioevo – quando San Giorgio e gli altri cavalieri li hanno sterminati, scambiandoli per draghi. Ai tempi di Dante il WWF avrebbe raffigurato la minaccia di estinzione con un povero tirannosauro, bullizzato da giovanotti di buona famiglia in armatura rilucente – altro che panda.
Una porzione molto ampia dell’opinione pubblica coltiva un rapporto con l’intelligenza artificiale paragonabile a quello che gli abitanti della «Bible Belt» americana nutrono nei confronti della storia: una fede che libera da ogni fatica di studio e approfondimento. Solo che gli imbonitori delle fantasticherie tecnologiche non hanno nemmeno bisogno di cimentarsi nella fatica di costruire parchi a tema per persuadere i loro spettatori: non mancherebbero i mezzi, visto che tra le loro fila si schierano personaggi come Elon Musk e Sam Altman. Nel film fantasy di portata universale che propone l’AGI come un evento imminente, i ruoli sembrano invertiti: il computer che raggiungerà l’intelligenza artificiale generale viene descritto come un vero drago di talento e raziocinio, con personalità propria, autonomia di giudizio, memoria illimitata, conoscenze smisurate, lucidità strategica, sottigliezza logica, e (perché no?) cinismo teso al dominio sull’uomo e sull’universo. Cosa potrà fare un San Giorgio moderno, negli abiti di un programmatore nerd, o di un eroico poeta in carne e ossa, o di un chirurgo che si prodiga per la salute dei suoi pazienti, o di un giudice che brama difendere la giustizia quanto Giobbe davanti a Dio – cosa potranno questi santi laici di fronte a un mostro simile?
Nick Bostrom ha avvisato più di dieci anni fa che se dovesse comparire questa forma di intelligenza, per tutti noi e i nostri santi sarebbe già troppo tardi, perché la macchina che raggiungesse le prestazioni dell’AGI non si fermerebbe al nostro livello di razionalità, ma crescerebbe a intensità esponenziale, conquistando gradi di perspicacia tali da impedire la scoperta delle sue manovre, e da inibire l’interruttore di spegnimento.
TOSTAPANI CON TALENTO PER LA STATISTICA
Ma è davvero così?
L’AGI è grande, e ChatGPT è il suo profeta: molti lo considerano tale. Il software di OpenAI è stimato l’avanguardia nel settore dell’intelligenza artificiale, grazie al marketing che gli ex e gli attuali soci fondatori hanno animato intorno alle sue prestazioni: il licenziamento di Sam Altman da CEO nel novembre 2023, rientrato dopo meno di una settimana, e le polemiche con Elon Musk, hanno contribuito ad amplificare il clamore intorno ai prodotti dell’azienda californiana. Ma se proviamo ad aprire l’armatura che protegge la macchina, ed esaminiamo l’euristica del suo funzionamento, troviamo un dispositivo che calcola quale dovrà essere la prossima parola da stampare nella sequenza sintattica della frase, sulla base del grado maggiore di probabilità che il lemma possiede nel campo semantico in cui compare il suo predecessore. I campi semantici sono strutture matematiche in cui ogni parola è convertita in un vettore che misura la frequenza delle sue occorrenze accanto alle altre parole, nel corpus di testi che compongono il database di training. Per esempio, il lemma finestra compare con maggiore frequenza vicino a casa, strada, balcone; la sua presenza è meno probabile dopo transustaziazione o eucaristia.
Naturalmente ChatGPT è un prodigio di ingegneria, perché calcola (al momento) 1.500 miliardi di parametri ad ogni parola che viene aggiunta nella sequenza proposizionale; ma in ogni caso non ha la minima idea di cosa stia dicendo, non sa nemmeno di stare parlando, non ha alcuna percezione di cosa sia un interlocutore e che esista un mondo su cui vertono i suoi discorsi. Lo provano i «pappagalli stocastici» che ricorrono nelle sue composizioni: gli errori che possono apparire nelle sue dichiarazioni non violano solo le verità fattuali (quali possono essere inesattezze di datazione, citazioni false, e simili), ma aggrediscono la struttura delle «conoscenze di Sfondo», la logica trascendentale che rende possibile l’esperienza stessa. Per i testi redatti da ChatGPT un libro pubblicato nel 1995 può citare saggi usciti nel 2003 o descrivere una partita di Go avvenuta nel 2017: l’eloquio del software è infestato da allucinazioni che provano l’assenza di comprensione, in qualunque senso del termine intelligente, di ciò che significa la sequenza dei significanti allineati dal suo chiacchiericcio. Un dispositivo che non mostra alcun intendimento dell’esistenza del mondo, e delle sue configurazioni più stabili, non è nemmeno in grado di perseguire obiettivi autonomi, di giudicare, stimare, volere, decidere. ChatGPT è un software con l’intelligenza di un tostapane, e uno smisurato talento per il calcolo della probabilità nella successione delle parole.
COSA DICE L’I.A. SUGLI UMANI
Come se la passano i fratelli, i cugini e i parenti vicini e lontani di ChatGPT?
Consideriamo il caso esemplare, descritto da Gerd Gigerenzer, del software COMPAS adottato dai tribunali americani per collaborare con i giudici nella valutazione della libertà sulla parola. Ogni anno la polizia degli Stati Uniti arresta circa dieci milioni di persone, e il magistrato deve stabilire se convalidare l’imprigionamento o lasciare libero il cittadino, sulla base della convinzione che non reitererà il reato. COMPAS ha contribuito ad emanare circa un milione di sentenze, dopo essere stato formato sull’intera giurisprudenza depositata nei provvedimenti di ogni ordine e grado dei tribunali americani. L’analisi delle sue proposte ha evidenziato una serie di pregiudizi che discriminano per colore della pelle, genere, età e censo, sfavorendo gli uomini neri, giovani, che provengono da quartieri poveri. Tuttavia la penalizzazione a sfondo razziale che è implicita nelle decisioni del software non proviene dal carattere ghettizzante dell’intelligenza artificiale: la macchina non ha autonomia di giudizio, ma sintetizza le opinioni catalogate nell’archivio delle ordinanze dei magistrati in carne e ossa, che sono i reali agenti dei preconcetti e dell’intolleranza di cui il dispositivo digitale è solo il portavoce. La convinzione che la sospensione del ricorso all’IA, in favore dell’autonomia di delibera da parte dei giudici umani, possa mettere a tacere l’intolleranza che serpeggia tra le valutazioni del software, è un’illusione come l’Eden del Creation Museum: gli autori dei testi da cui COMPAS ha appreso il funzionamento del suo mestiere continueranno ad applicare i principi – più o meno inconsapevoli – del razzismo che innerva la società americana e l’upper class giuridica.
Al pregiudizio concettuale i magistrati umani aggiungono anche le deviazioni dettate dalla loro fisiologia. Uno studio congiunto della Columbia Business School e della Ben-Gurion University pubblicato nel 2011 ha dimostrato che i giudici scelgono con la pancia – e lo fanno in senso letterale, poiché i verdetti diventano sempre più severi quanto più ci si allontana dall’orario dei pasti. Almeno i software non sono sensibili ai morsi della fame.
Nemmeno vale la pena di coltivare illusioni sul miglioramento del trattamento dei candidati per le selezioni dei posti di lavoro: gli uffici del personale che abbandonano la lettura dei curricula ai dispositivi di IA (che a loro volta hanno imparato a discriminare nel training sul database delle assunzioni precedenti) non sarebbero pronti a compiere valutazioni migliori – con ogni probabilità si limiterebbero a non leggere i CV.
RATING UNIVERSALE E ALTRI ANIMALI FANTASTICI
Gigerenzer invita a verificare con cura i numeri divulgati dagli uffici marketing e dai giornalisti affamati di sensazionalismo: ne abbiamo già parlato in un altro articolo su Controversie.
La convinzione che qualche nazione sia in grado di gestire un calcolo del rating sociale di ciascuno dei suoi cittadini appartiene al repertorio degli effetti dei mass media per la generazione del panico. L’opinione che la Cina sia in grado di praticarlo, con quasi 1,4 miliardi di abitanti, è ancora meno credibile. Per allestire un processo di portata così vasta occorre una potenza di calcolo che al momento non può essere gestita da alcuna infrastruttura tecnologica. La realtà di questo progetto è assimilabile a qualcuno degli animali del bestiario del Creation Museum, qui a beneficio della propaganda del regime di Pechino e della sua aspirazione a gonfiare muscoli informatici inesistenti. Il governo cinese razzia dati sui cittadini anche dalle imprese che rilasciano servizi di comunicazione e di ecommerce, con l’obiettivo di armare sistemi di controllo di larga scala, che l’Unione Europea ha già vietato con l’AI Act entrato in vigore lo scorso luglio. Senza dubbio è una giusta preoccupazione prevenire simili tentazioni di amministrazione della distribuzione delle utilità sociali; ma il focus su questa minaccia sembra al momento meno urgente della normativa che obblighi i produttori di software a pubblicare le euristiche con cui funzionano i dispositivi di intelligenza artificiale. La consapevolezza che l’euristica alla base di ChatGPT è il calcolo della parola con maggiore probabilità di trovarsi subito dopo quella appena stampata, avrebbe liberato il pubblico dall’ansia e dall’euforia di marciare sulla soglia di un’AGI pronta a rubare il lavoro e a giudicare gli imputati, imminente al prossimo cambio di stagione. Avrebbe anche sterminato le occasioni per Musk e Altman di favoleggiare risultati miracolosi nel marketing dei loro prodotti – più spietatamente di quanto San Giorgio massacrasse dinosauri.
I rischi più realistici riconducibili all’intelligenza artificiale riguardano proprio la trasparenza delle euristiche, la bolla finanziaria indotta da società prive di un modello di business (come OpenAI), le attese senza fondamento alimentate da società di consulenza e da formatori improvvisati, il monopolio sui modelli fondamentali già conquistato da pochi giganti della Silicon Valley, il tentativo di accaparrarsi lo sviluppo dell’intero settore da parte di personaggi con finalità politiche ed economiche come Musk e Altman.
Chi costruisce Creation Museum di ogni tipo non ha mai come scopo la divulgazione; dovrebbe essere compito degli intellettuali tornare a smascherare i draghi di questi impostori, come coraggiosi San Giorgio della ragione.
BIBLIOGRAFIA
Bostrom, Nick, Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies, Oxford University Press, Oxford 2014.
Bottazzini, Paolo, La fine del futuro - I.A. e potere di predizione, «Controversie», 10 settembre 2024.
ChatGPT-4, Imito dunque sono?, Bietti Edizioni, Milano 2023.
Danziger, Shai; Levav, Jonathan; Avnaim-Pesso, Liora, Extraneous factors in judicial decisions, «Proceedings of the National Academy of Sciences», vol. 108, n.17, 2011.
Gigerenzer, Gerd, How to Stay Smart in a Smart World Why Human Intelligence Still Beats Algorithms, Penguin, New York 2022.
Pedemonte, Enrico, Paura della scienza, Treccani Editore, Torino 2022.
La medicina è dei medici ma la salute è di tutti
Dopo la recente inflazione di mediche[1] sui mass media, si è fatta strada l’idea che le esperte di salute siano loro. Tant’è che capita frequentemente che qualche personaggio televisivo, molto aggressivo e arrogante, di formazione medica (me ne vengono in mente almeno un paio, uomini) dica alle sue interlocutrici che lo criticano: “lei prima si prenda una laurea in medicina, e poi ne parliamo”. Nessuna però risponde a lui, che parla di comportamenti a rischio o di come ragionano i pazienti: “lei prima si prenda una laurea in sociologia o psicologia, e poi ne parliamo”. Ma, si sa, la simmetria non è un’attività molto praticata da superbi e prepotenti.
Come la fisica è delle fisiche, ma la natura o l’ambiente è di tutte (ne parleremo in un prossimo post), così la salute è un tema a cui possono dare un contributo molti tipi di esperte; non solo le mediche.
Facciamo un paio di esempi [2]:
IL CASO DELL’AIDS
All’inizio degli anni Novanta, durante i drammatici dibattiti sulla sperimentazione di medicinali contro l’AIDS e l’HIV, il sociologo Steven Epstein notò come alcuni movimenti di attiviste, per lo più composti dalle stesse pazienti, erano riusciti a trasformare la loro posizione marginale in un contributo attivo e autorevole. Epstein (1995) si concentrò su come questi gruppi di attiviste fossero riuscite a ottenere una certa credibilità e farsi riconoscere come “esperte non professioniste” (lay experts), creando una breccia nella divisione tra esperte e non esperte. A quel tempo, la difficoltà di gestione della malattia da un punto di vista farmacologico, il suo veloce diffondersi soprattutto nelle fasce di popolazione in giovane età e la mancanza di risposte ritenute adeguate da parte della medicina convenzionale, avevano creato da un lato una certa sfiducia nel riguardo della sperimentazione dei nuovi farmaci, e dall’altro un terreno fertile per le attiviste che erano così riuscite a far ascoltare la loro voce all’interno del dibattito. Il contesto storico, culturale ed economico delle sperimentazioni farmacologiche, come spesso avviene, era caratterizzato da una moltitudine di attori sociali: mediche e scienziate di varia formazione (immunologhe, epidemiologhe, mediche di famiglia ecc.), autorità sanitarie locali, federali e nazionali, compagnie farmaceutiche ecc. Ma dove collocare le pazienti e i loro parenti? Secondo Epstein, mediante una serie di strategie — come per esempio l’acquisizione di alcune conoscenze particolari che le rendessero capaci di discutere con competenza di questioni mediche e legali, la creazione di una rappresentazione politica, la presa di posizione in dibattiti metodologici preesistenti e la fusione di richieste di ordine etico con quelle di ordine epistemologico — questi gruppi di attiviste creati dalle pazienti e loro familiari riuscirono a farsi accreditare come lay expert. In questo modo, esse riuscirono a mettere in discussione alcuni assunti impliciti delle sperimentazioni, che troppo spesso emarginavano (e ancora emarginano) dal processo decisionale proprio le dirette interessate.
GLI EFFETTI DEL DISASTRO NUCLEARE DI CHERNOBYL
A partire dagli anni Novanta, l’“information deficit model” (ovvero l’idea paternalista secondo cui ogni resistenza nei confronti dell’innovazione, e della scienza in generale, deriva da una sua mancata comprensione da parte dell’opinione pubblica. Di conseguenza, quest’ultima dev’essere educata e fornita di tutte le informazioni necessarie) è stato criticato su più fronti anche grazie a studi come quello del sociologo inglese Brian Wynne (1992) a proposito della crisi della pastorizia in Cumbria (UK) a seguito del disastro nucleare di Chernobyl. In un primo momento, il governo Britannico aveva minimizzato il rischio di contaminazione, incontrando tuttavia la resistenza delle allevatrici che invece si erano immediatamente allertate. Le “esperte” degli enti governativi avevano screditato queste proteste come “irrazionali” e frutto di una mancata comprensione della valutazione scientifica delle esperte. Fu solo in un secondo momento, e dopo un lungo dibattito, che le scienziate si videro costrette a rivedere la propria valutazione. Nel frattempo, però, la sottovalutazione del fenomeno aveva già creato ingenti danni economici alla pastorizia locale. Le interviste condotte da Wynne con le allevatrici rivelarono che la loro non era una semplice mancanza di comprensione. Al contrario, esse confrontavano le informazioni fornite dagli enti governativi alla luce della loro esperienza quotidiana degli eventi atmosferici, delle acque e delle caratteristiche del terreno di quella particolare regione. Le nozioni scientifiche riguardanti il rischio e le prescrizioni su come comportarsi, venivano certamente recepite e comprese da parte delle allevatrici; ma anche attivamente trascurate per la scarsa fiducia che esse riponevano nelle istituzioni. La fiducia, infatti, non riguardava le singole informazioni o indicazioni, ma l’intero “pacchetto sociale” fatto di relazioni, interazioni e interessi all’interno del quale i vari attori sociali di muovono.
UN NUOVO MODELLO DI COMPETENZA
Grazie a questi studi, Epstein e Wynne mostrarono sia che la scienza non è una sfera autonoma sia che anche coloro che vengono considerate semplicemente pazienti e allevatrici potevano, e volevano, avere un ruolo attivo. Questo non è un caso isolato e molti sono gli esempi che potrebbero essere menzionati: i gruppi femministi nella ricerca medica contro il cancro al seno, i gruppi ambientalisti, i movimenti delle agricoltrici e molti altri ancora. In tutti questi casi, la competenza si estende ben al di là dei limiti della comunità scientifica. Proprio perché la scienza non garantisce un accesso privilegiato alla “verità”, esistono altri tipi di sapere che possono tornare utili, altre competenze e priorità da prendere in considerazione. Attribuire competenza solamente alle scienziate impedisce all’intero processo decisionale di maturare una consapevolezza della complessità degli obiettivi da porsi e delle molte possibili strade per raggiungerli.
NOTE
[1] Uso il femminile sovraesteso.
[2] Cfr. Gobo, G. e Marcheselli, V. (2021), Sociologia della scienza e della tecnologia, Roma: Carocci.
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
Epstein, Steven. 1995. “The Construction of Lay Expertise: AIDS Activism and the Forging of Credibility in the Reform of Clinical Trials”. Science, Technology, & Human Values 20(4): 408-437.
Irwin, Alan e Brian Wynne (1996), Misunderstanding science? The public reconstruction of science and technology. Cambridge: Cambridge University Press.
Wynne, B. (1992), Misunderstood Misunderstanding: Social Identities and Public Uptake of Science, in “Public Understanding of Science”, 1, 3, pp. 281-304.