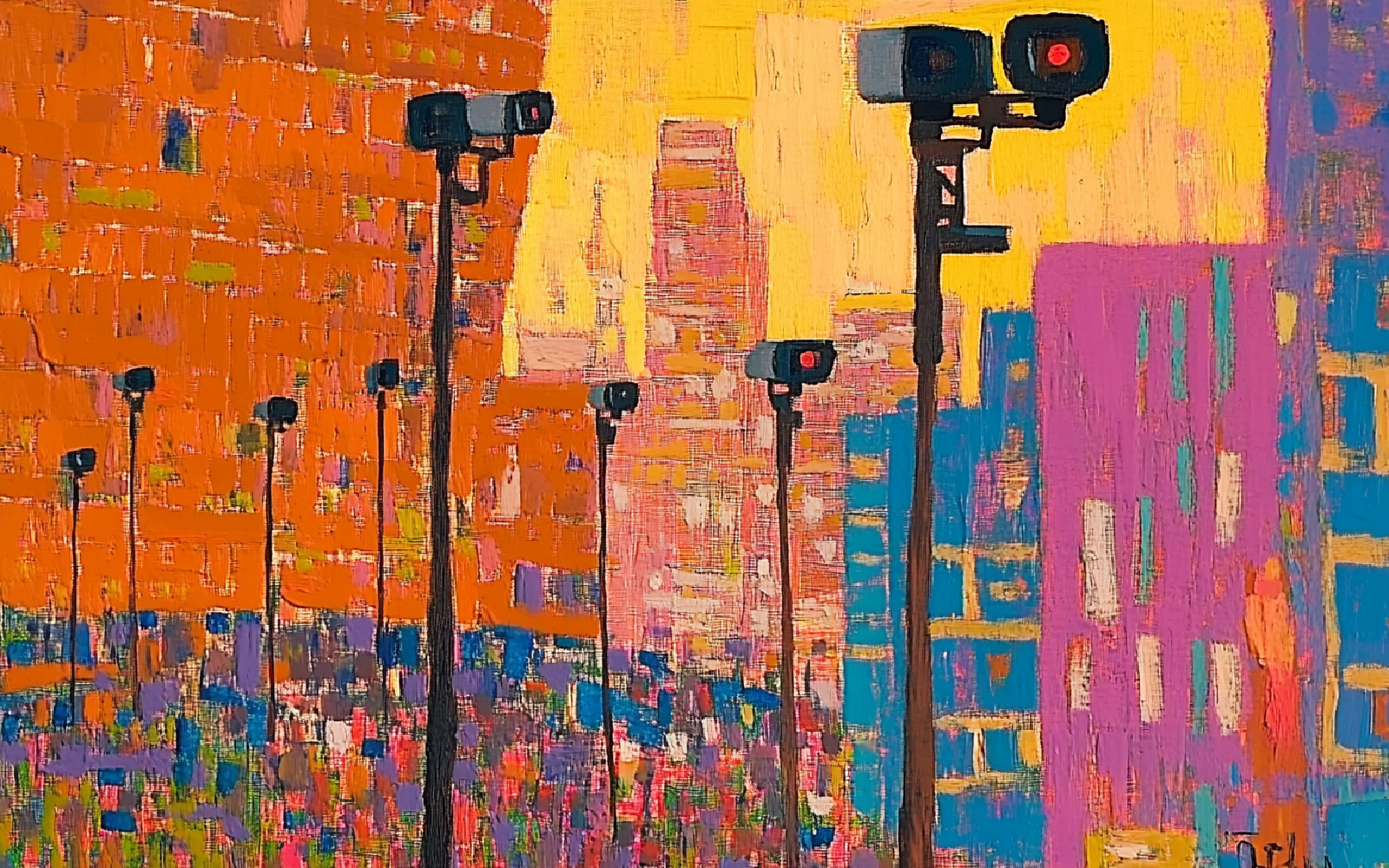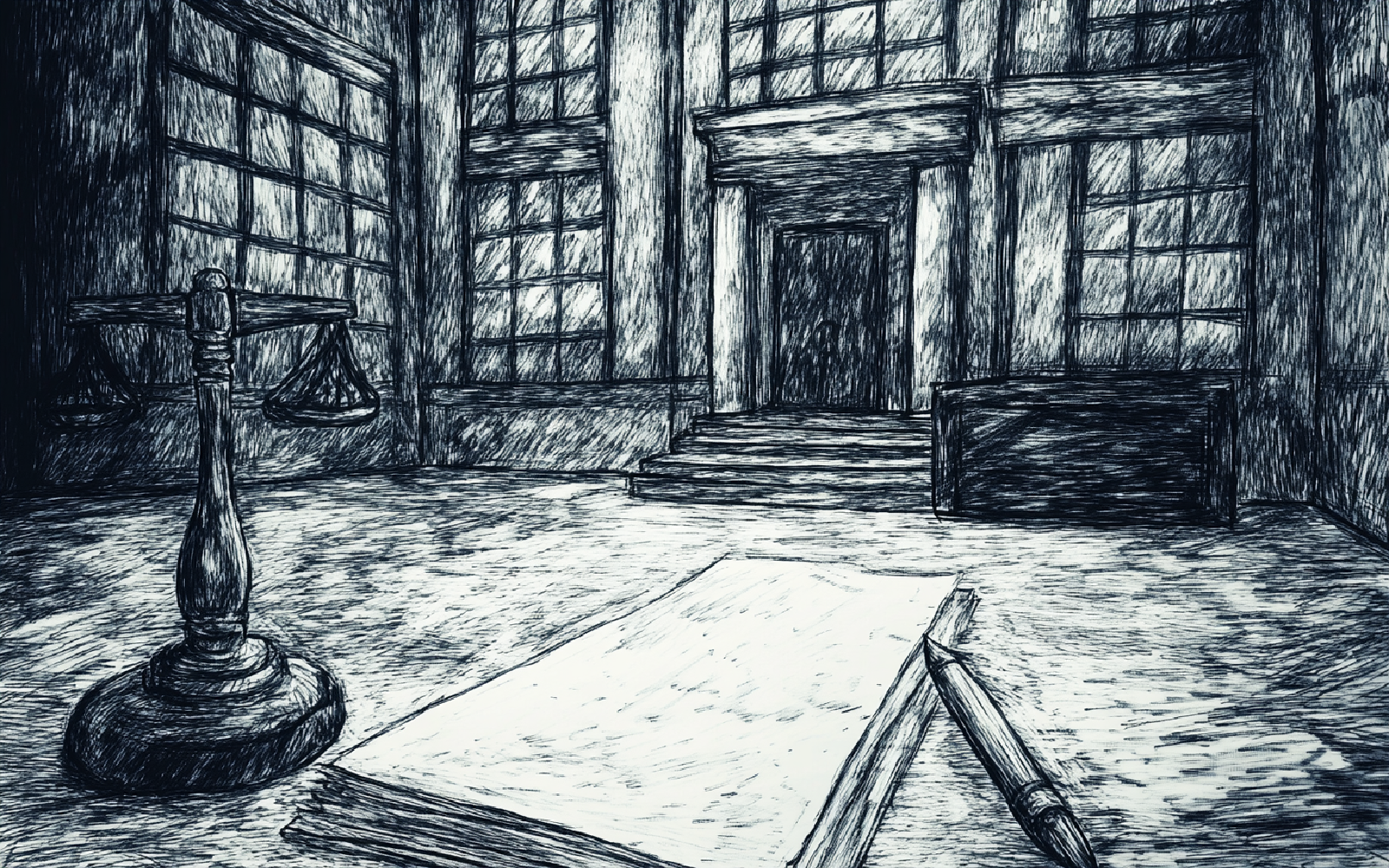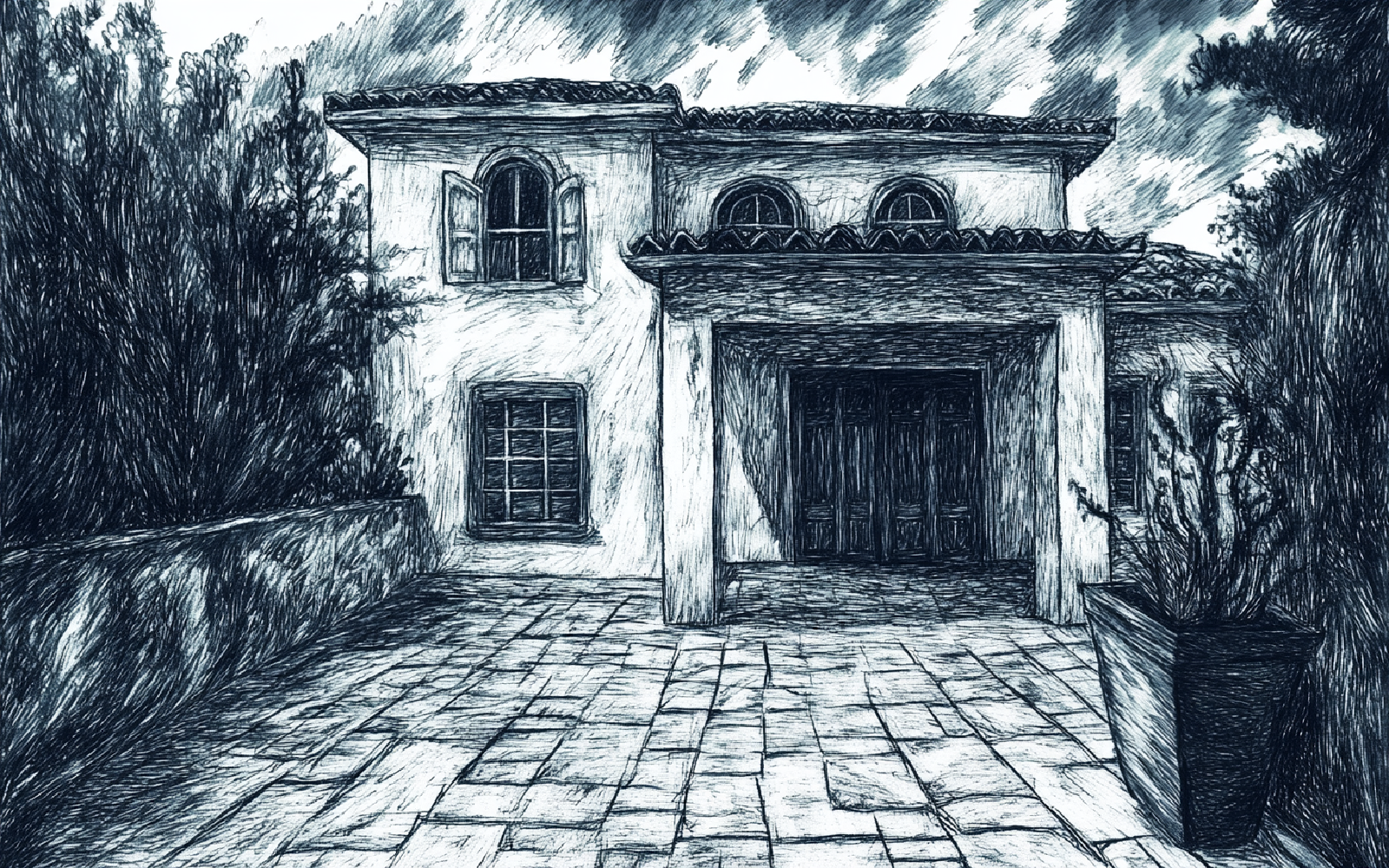Le mani sulla montagna - “Consumismo sciistico” o sviluppo sostenibile?
Questo articolo è pubblicato in contemporanea
dal Gruppo di divulgazione e discussione online
“Ideeinformazione”
Nelle aree alpine – si è notato più volte in questi anni – il fenomeno del cambiamento climatico si sta facendo sentire con particolare acutezza. Ma a farsi sentire sembra anche una scarsa volontà di cambiare stili di vita e atteggiamenti culturali, in particolare l’idea di sviluppo del territorio. Come del resto nelle grandi pianure. Fortunatamente, però, crescenti sono anche le reazioni delle popolazioni locali, sempre più consapevoli della necessità di “cambiare rotta” dal punto di vista economico-sociale, orientandosi verso un modello di sviluppo meno consumistico e “quantitativo”. Qualcosa che può insegnare molto (e – perché no – dare anche un po’ di speranza) a chi nelle aree montane non vive.
Nelle prealpi lombarde ci sono ameno due casi di scuola, che illustrano bene questa situazione.
IL COMPRENSORIO SCIISTICO VILMINORE-LIZZOLA (BG)
Vilminore e Lizzola sono due comprensori sciistici nella Bergamasca: il primo in valle di Scalve, sopra il comune di Vilmonore, e il secondo nella parallela Val Seriana, sopra Valbondione (di cui Lizzola è frazione). In mezzo c’è il Pizzo di Petto (mt.2.227) che può essere valicato a piedi attraverso il Passo di Manina. Ebbene, da qualche tempo sta prendendo forma un progetto per la “valorizzazione” turistica e sciistica dell’area attraverso la realizzazione di un tunnel che colleghi i due comprensori. Bucando evidentemente la montagna. Grazie a questa grande opera sciistica (potremmo forse coniare al proposito un nuovo acronimo: GOS), dunque lo sciatore potrebbe godere senza scendere dagli sci né perdere quota delle due aree di divertimento. Peccato che su questi tracciati, in gran parte tra i 1.800 e i 2.200 mt., cade sempre meno neve negli ultimi anni, anche durante le stagioni buone, e per periodi sempre più brevi…
Il progetto, il cui costo previsto è di 70 milioni di euro di cui 50 pubblici, sta muovendo solo i primi passi; sono comunque previsti, oltre agli estremamente invasivi lavori di perforazione per il tunnel di collegamento, sbancamenti, vasche di accumulo dell’acqua per l’innevamento artificiale, infrastrutture viarie, la dismissione delle funivie esistenti per sostituirle con una nuova.
Quello che però va qui segnalato è che appena la notizia ha fatto il giro dei paesi della valle la popolazione è insorta decisamente contro l’insensatezza di questo ipotetico mega-progetto, e così sul finire del 2024 la petizione lanciata dal locale collettivo Terre Alt(r)e[1] ha raggiunto rapidamente le 25.000 firme (!), mentre il 3 gennaio di quest’anno una prima assemblea pubblica, a Vilminore, ha raccolto oltre trecento persone che per quattro ore hanno seguito attentissime e preoccupate i relatori convocati da una rete di associazioni, tra e quali il CAI locale.[2]
I NUOVI IMPIANTI SUL MONTE SAN PRIMO (CO)
Il progetto denominato “Oltre Lario” è, se possibile, ancora più folle. Qui parliamo del monte San Primo, il rilievo più elevato del cosiddetto “Triangolo lariano”, ovvero di quel “triangolo” avente come vertici ideali Como, Lecco e Bellagio. Il massiccio montuoso supera di poco i 1.600 mt. e non ci ha mai nevicato troppo (oltretutto si tenga presente che quella zona risente dell’effetto mitigazione esercitato dal lago). In passato, comunque vi erano state costruite delle piste da sci con relativi impianti, da molto tempo abbandonati, secondo il destino comune a gran parte degli impianti a media altezza delle aree prealpine[3] (in verità non solo per ragioni climatiche, ma anche per cambiamenti degli stili di vita e delle pratiche turistiche).
Dal 2022, dunque, un progetto finanziato da Ministero dell’Interno, Regione Lombardia e Comunità montana del Triangolo lariano, e fortemente sostenuto dal Comune di Bellagio, prevede tra le altre cose la costruzione di un nuovo impianto sciistico sul Monte San Primo con ovviamente creazione di piste, cannoni sparaneve e un laghetto di accumulo per l’innevamento artificiale, tapis-roulants e una serie di parcheggi. Da subito una grande mobilitazione ha attraversato i paesi dell’area, dando vita al Coordinamento “Salviamo il Monte San Primo” (che riunisce decine di associazioni locali)[4] e che ha per ora ottenuto, se non altro, un “ripensamento” del progetto. Che però – denunciano di recente i sostenitori del coordinamento – non è cambiato in modo significativo e continua a impegnare oltre due milioni di euro dei cinque previsti per le opere legate, appunto, a questi nuovi, surreali, impianti sciistici.
Le associazioni temono che un simile progetto trasformi «la montagna lariana in un dispendioso luna-park, sperperando ingenti soldi pubblici per depauperare un territorio di grande pregio naturale e culturale». Tra le maggiori preoccupazioni, oltre al danno per un’area che è di grandissimo pregio naturalistico e inevitabilmente vocata a un turismo “dolce” (è il caso del percorso escursionistico noto come “Dorsale del Triangolo lariano” da Como a Bellagio), quella relativa agli impianti per il prelievo di acqua funzionali alla produzione della neve artificiale (la zona presenta carsismi e difficoltà nel prelievo di acqua per gli usi civili nelle lunghe estati siccitose di questi ultimi anni – ci manca questo prelievo extra del tutto insensato!).
Passando da vicende di portata locale a questioni più ampie, è evidente che queste tendenze si trovano nella concezione che sta alla base della progettazione delle future Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, i cui lavori nei prossimi mesi conosceranno una forte accelerazione (il 6 febbraio scorso è stato infatti il “One year to Go”, la cerimonia ufficiale a un anno dall’inizio dei giochi). Anche in questo caso, dietro qualche rapida frase di facciata “green” (il sindaco di Milano Sala ha assicurato che i Giochi saranno molto «sostenibili» e che alla fine come ai tempi di Expo 2015 «saranno tutti contenti»[5] – ma tutti chi?), c’è una micidiale operazione di opere «essenziali» sparse a pioggia tra Lombardia e Veneto, che non faranno che lasciare i territori più sfigurati e cementificati. O meglio, i segni si vedono già.[6]
RIPENSARE LO SVILUPPO E I TERRITORI. A PARTIRE DALLE AREE MONTANE
Le due vicende che abbiamo richiamato – ma molte altre si potrebbero rintracciare – ci mostrano in definitiva come forti siano le tenenze conservative nel modo di pensare l’impresa, lo sviluppo e il turismo (è difficile uscire dal mito della crescita illimitata), ma come anche in questi ultimi decenni tante popolazioni, imprese, amministrazioni locali, intellettualità diffusa abbiano maturato una visione nuova, capace di pensare strade inedite e inaspettate per coniugare vita moderna e tutela dell’ambiente.
Le vicende e i luoghi che abbiamo visto parlano, tra l’altro, di quelle aree che sono state definite «montagne di mezzo», cioè quella media montagna che non presenta i caratteri della “eccellenza turistica” per come è comunemente intesa. È una «dimensione intermedia» – ha osservato in un libro intelligente il geografo Mauro Varotto – tra le montagne per antonomasia, specializzate «in direzione della modernizzazione turistico-industriale» e della «compensazione naturalistica»,[7] e le aree urbane industrializzate (anzi, “post-industrializzate”, se mi consente lo scherzo terminologico), caotiche affollate e inquinate. Aree dunque destinate, in questo modello di (mal)sviluppo ad abbandono e “regressione”, a invecchiamento e spopolamento. Contro questo “destino”, che in realtà è solo l’effetto di un ben preciso orientamento dello sviluppo territoriale basato sugli imperativi del profitto, è necessario ripensare ai modelli di telefrequentazione di una montagna panoramica a disposizione del tempo libero della popolazione urbana: serve una rivoluzione copernicana che non intenda più la montagna al servizio del turista o escursionista, ma l’escursionista e il turista al servizio della montagna.[8]
Vi è oggi in Italia, per fortuna, un vasto movimento, di pensiero, di opinione, ma anche di “pratiche di vita”) che si oppone fermamente a queste visioni incentrate su un mito della crescita economica che, applicato alle aree montane, appare perfino ridicolo. Un movimento che, peraltro, non può essere derubricato a “politica del no”, ma che al contrario intende dare un “altro futuro”, di economia alternativa, al mondo delle montagne che peraltro rappresenta oltre un terzo del territorio italiano. Tra i punti alti di questa riflessione troviamo, infatti, il Manifesto di Camaldoli, un documento elaborato al termine di un convegno nazionale svoltosi appunto a Camaldoli nel 2019,[9] dove si legge tra l’altro: L’idea che la montana lasciata alle forze della natura ritrovi da sola un equilibrio stabile – la cosiddetta ri-naturazione – è del tutto infondata. Come tutti i manufatti la montagna richiede manutenzione. In netto contrasto con i comportamenti odierni di tipo distruttivo e predatorio va riscoperta la tradizionale cultura del limite, che dovrà anche presiedere all’uso produttivo della terra, ai consumi di suolo e agli altri usi del territorio. (…)
Occorre dunque lavorare a uno scenario alternativo a quello della città che invade la montagna, della proliferazione delle seconde case, delle piste da sci sempre più dipendenti dall’innevamento artificiale e dal prelievo idrico. Nuovi modelli di vita, di socialità e di compresenza culturale richiedono un’alleanza fra anziani restanti, depositari di saperi contestuali, e “nuovi montanari” innovativi. Vi concorrono iniziative e nuovi strumenti come cooperative di comunità, ecomusei che attivano coscienza di luogo, osservatori del paesaggio, comunità del cibo, feste paesane “sagge”, forme attive e inclusive di valorizzazione delle minoranze linguistiche e di integrazione dei migranti.[10]
Un pensiero altro sulla e della montagna, da cui ci sarebbe molto da imparare. Anche qui in pianura.
NOTE
[1] https://terrealtre.noblogs.org/
[2] Si veda la puntuale cronaca di Radio Onda d’Urto: https://www.radiondadurto.org/2025/01/27/nuovo-comprensorio-sciistico-colere-lizzola-prosegue-la-raccolta-di-firme-contraria-e-in-preparazione-nuove-iniziative/. E qui il video dell’incontro del 3 gennaio a Vilminore, intitolato “Comprensorio sciistico Colere-Lizzola. Patrimonio di tutti o parco divertimenti per pochi?”: https://terrealtre.noblogs.org/post/2025/01/10/video-dellincontro-pubblico-comprensorio-sciistico-colere-lizzola-patrimonio-di-tutti-o-parco-divertimenti-per-pochi-organizzato-a-vilminore-il-03-01-2025/
[3] Nell’Appennino le cose vanno anche peggio, per ovvie ragioni climatiche: dei cento impianti esistenti la metà sono chiusi. E nonostante questo – ha osservato Giuliano Bonomi, naturalista dell’Università di Napoli che ha condotto su questa realtà un’ampia ricerca – «negli ultimi anni stiamo assistendo a un paradosso: sono proliferati i progetti volti a costruire nuovi impianti di risalita in tutto l’Appennino, grazie anche a finanziamenti in parte o totalmente pubblici» (cfr. Alessandro Pirovano, La montagna che non si arrende a “grandi eventi” e impianti sciistici senza futuro, “Altreconomia”, 5 febbraio 2025, https://altreconomia.it/la-montagna-che-non-si-arrende-a-grandi-eventi-e-impianti-sciistici-senza-futuro/).
[4] https://bellagiosanprimo.com/
[5] https://stream24.ilsole24ore.com/video/economia/milano-cortinasala-fascino-cinque-cerchi-dara-grande-visibilita/AGQg6qkC
[6] Per una presentazione d’insieme degli scempi che porteranno con sé le Olimpiadi invernali 2026, si veda Luigi Casanova, Ombre sulla neve. Milano-Cortina 2026. Il “libro banco” delle Olimpiadi invernali, Milano, Altreconomia, 2022. Qui il video della presentazione del libro alla Casa della Cultura di Milano, il 15 dicembre 2022: https://www.youtube.com/watch?v=RoMk-HK9s9c&t=10s. E per un aggiornamento, l’articolo di Duccio Facchini, “L’impronta olimpica”: le opere di Milano Cortina 2026 dall’alto,“Altreconomia”, n. 278 / febbraio 2025, p. 21-25, che documenta, foto satellitari alla mano, gli effetti tutt’altro che “sostenibili” sui territori interessati dalle opere olimpiche.
[7] Mauro Varotto, Montagne di mezzo. Una nuova geografia, Torino, Einaudi, 2020, p. 165.
[8] Ivi, p. 167-68.
[9] Il manifesto è stato approvato al termine del convegno nazionale “La nuova centralità della montagna” (Camaldoli, 8-9 novembre 2019), e si trova in Luigi Casanova, Avere cura della montagna. L’Italia si salva dalla cima, Milano, Altreconomia, 2020, p. 29-36.
[10] Ivi, p. 32-33.
Le teorie del complotto, prima parte - Tra populismo, scientizzazione della politica e disincanto del mondo
Quella che segue è la prima di cinque puntate di un testo sul complottismo, indagato al crocevia tra populismo, scientizzazione della politica e disincanto del mondo. Il testo originale è stato pubblicato come prefazione al volume di Matthieu Amiech, "L'industria del complottismo. Social network, menzogne di stato e distruzione del vivente" (Edizioni Malamente, 2024). Elisa Lello
--------
Scrivo queste pagine durante un soggiorno a Coimbra come pesquisadora (ricercatrice) visitante presso un Centro universitario che deve molto del suo prestigio a una importante tradizione di studi che ha avuto il merito di fare luce sul ruolo cruciale della dimensione epistemologica nei rapporti di dominio. In particolare, nel mettere sotto esame critico il ruolo che la scienza occidentale ha avuto nel legittimare e implementare le forme della dominazione coloniale storica – e che continua a esercitare attraverso la colonialità (Quijano 2005) – alla luce del fatto che il modo in cui vediamo e descriviamo il mondo determina anche i modi in cui pensiamo sia possibile, o non possibile, agire su di esso per trasformarlo. Una tradizione che si è dunque concentrata sull’epistemologia come strumento di potere, che spoglia la scienza della sua pretesa neutralità mostrando come questa risponda ai rapporti di forza in campo e questi contribuisca a consolidare, marginalizzando, invisibilizzando o ridicolizzando modi altri di stare al mondo, di conoscerlo e rappresentarlo (Chalmers 2017; Nunes e Louvison 2020; Santos et al. 2022).
Eppure, anche in un contesto come questo, quando mi capita di raccontare a colleghe/i i temi intorno cui gravitano i miei studi durante questi ultimi anni – essenzialmente: movimenti sociali e tecnoscienze, i rapporti tra politica e scienza, tra critica sociale e complottismo, tra epistemologia e populismo – quasi sempre mi imbatto in reazioni a cui sono fin troppo abituata. Dopo sorrisi e attestazioni di quanto tutto questo sia interessante, quella che mi si cerca (senza successo) di proporre è una complicità fondata sull’indignazione, e sullo scherno, a partire da qualche aneddoto che invariabilmente vorrebbe dimostrare quanto ci sia gente, là fuori – e, ça va sans dire, soprattutto tra chi ha orientamenti conservatori – così irrimediabilmente ignorante e anti-scientifica che ha completamente perso il lume della ragione, che crede in teorie strampalate, risibili e complottiste, e come è possibile che costoro abbiano diritto di parola e, quel che è peggio, pure di voto.
La mia perplessità, ma a volte è quasi scoramento, nasce non solo dal constatare la mancanza di qualunque cautela nel trattare del rapporto tra scienza, “ignoranza” e politica – ancor di più qui, appunto. Ma anche dal vedere come si tratti quasi sempre di ricercatrici/tori che si autodefiniscono militanti, di sinistra, che rivendicano un’attenzione estrema all’inclusività nelle pratiche e nel linguaggio quando si parla di identità di genere, orientamenti sessuali o body-shaming, eppure tutta questa inclusività, sensibilità e attenzione letteralmente svaniscono quando si è di fronte a opinioni non del tutto allineate, per esempio, sulla crisi eco-climatica o, a maggior ragione, quando si tratta di scelte sanitarie. Non solo svaniscono: peggio, troppo spesso si trasformano in un disprezzo profondo, antropologico, che apre la porta a battute feroci, che rivolte ad altre categorie desterebbero, giustamente, scandalo e reazioni ben sicure di sé. Il tutto senza poi indugiare troppo sulla eterogeneità delle critiche né sulle ragioni che vengono mosse, appunto, dai non allineati; senza interrogarsi sulla complessità delle questioni che pongono e che tutti ci dovremmo porre. Ci si accontenta invece, troppo spesso, di alzare steccati identitari per frapporre una distanza netta tra sé e gli “altri”: anti-vax, antiscientifici, trumpiani, complottisti, negazionisti, terrapiattisti. Un po’ tutti in odore di estrema destra e fascismo.
Sollevando, con ciò, contraddizioni che gridano giustizia, ma che raramente vengono affrontate. Per iniziare col piede giusto, prendiamo la sineddoche per eccellenza del vasto panorama del complottismo: gli odiatissimi “anti-vax”, categoria che finisce per catalizzare indignazioni, ironie e disprezzo, nonché solitamente inclusiva di chiunque per qualunque ragione abbia dubbi sulle politiche pandemiche. Bene, l’avere (più di) qualcosa da ridire sul fatto che le linee politiche essenziali che hanno guidato la gestione globale del Covid-19 siano state scritte da CEPI (Coalition for Epidemic Preparedness) – Fondazione B. & M. Gates, DARPA (NATO) e Wellcome Trust – è una posizione in perfetta continuità con ciò che denunciava il “movimento dei movimenti” tra Seattle e Genova al volgere del millennio e con ciò che qualunque movimento di sinistra variamente intesa dovrebbe ancora combattere oggi: com’è possibile che questa posizione non solo non sia più (percepita come) coerente con ideali di sinistra ed emancipativi, ma sia addirittura diventata patologica e pure fascista?
Poi, però, in questi stessi ambienti accademici (come in molti della militanza di sinistra) ci si straccia le vesti di fronte all’“onda nera” che travolge Europa e Stati Uniti, spesso, ancora una volta, con studi che, se finalmente prendono in considerazione il ruolo delle “emozioni”, il più delle volte lo fanno per dare una spiegazione tendenzialmente psico-patologica del voto a destra, che lascia a intendere quanto sia invece “razionale” quello progressista.
Sono convinta che ci sia un nodo da affrontare, qui. E che questo nodo abbia a che fare con ciò che impedisce un dialogo tra sinistra e classi popolari, dove la prima non fa nulla per dissimulare il suo disprezzo verso i valori e i modi di vita delle seconde proprio mentre si dispera perché queste non le tributano più i loro consensi e preferiscono cercare e inseguire altre narrative.
Ma è un nodo che riguarda anche l’accademia. La quale, muovendosi lungo percorsi in fondo molto simili, denuncia con tanta veemenza quanta superficialità i pericoli delle fake news e del complottismo, malattie che ovviamente contagerebbero di preferenza il “popolino”, e nel contempo si allarma di fronte alla perdita di credibilità delle “autorità epistemiche consolidate”, cioè università e istituzioni scientifiche, agli occhi (di parti rilevanti) del popolo stesso. Tendendo però a liquidare ogni problema, come vedremo, attraverso le interpretazioni auto-assolutorie del populismo, politico ed epistemologico, e della post-verità.
Per questi motivi credo sia importante affrontare in modo serio, finalmente, un tema come quello del complottismo, di ciò che lo produce, delle dinamiche storiche in cui si inserisce, e di ciò che esso stesso alimenta. E, in questo senso, il libro di Matthieu Amiech, come cercherò di evidenziare nelle prossime pagine, fornisce parecchi elementi preziosi, illuminanti. Quello che invece farò io, in queste pagine, sarà provare a introdurre il tema partendo dall’individuare aporie e contraddizioni nelle sue interpretazioni oggi largamente prevalenti (da parte del giornalismo, ma anche della sinistra e del sapere accademico), per poi contestualizzarlo all’interno del più ampio problema del rapporto tra scienza e politica, rintracciandone alcune connessioni con la scientizzazione della politica e con il disincanto del mondo.
In questo percorso, seguirò principalmente il filo argomentativo del libro; cercherò però anche di intessere un dialogo tra questo e alcune ricerche e pubblicazioni che ho portato avanti negli ultimi anni, con amici/he e colleghi/e, su temi affini o contigui; e con varie altre letture recenti. Tra queste, in particolare, si potranno riconoscere le impronte significative del Manifeste conspirationniste (Seuil 2022), di The divide: how fanatical certitude is destroying democracy (di Taylor Dotson, MIT Press 2021) e di Favole del reincanto: molteplicità, immaginario, rivoluzione (di Stefania Consigliere, Derive Approdi 2020).
INIZIAMO A SFATARE QUALCHE LUOGO COMUNE
Cosa c’è dunque che non va in quelle reazioni così frequenti e automatiche? Cosa non funziona in quelle diagnosi che in modo così lineare, e semplice, individuano quasi tutti i problemi dell’oggi nell’ignoranza e nell’“analfabetismo funzionale” che rende il popolo (o comunque sempre “gli altri”) facile preda di fake news e complottismo?
Proviamo a sollevare qualche velo. Un primo problema è dato dal focalizzarsi su una fotografia istantanea senza tenere in considerazione come siamo arrivati a questo punto. Quando invece occorrerebbe partire dalla presa di consapevolezza, suggerita da Frédérique Lordon e ripresa da M. Amiech, della colpevole confisca del dibattito pubblico che ha sistematicamente privato la cittadinanza della possibilità e dei mezzi per capire le forze storiche che la dominano e per partecipare ai processi decisionali che disegnano gli scenari in cui dovrà vivere. Il complottismo, in questa prospettiva, appare piuttosto come sintomo di un’espropriazione, e come rifiuto, al tempo stesso e nonostante tutto, ad abdicare alla volontà di capire, di darsi una spiegazione.
Ci imbattiamo, continuando a sollevare qualche velo, nell’inadeguatezza e nella parzialità dell’informazione offerta dalle testate del mainstream, che in maniera crescente e accelerata negli ultimi anni si è intrecciata con dinamiche di militarizzazione del confronto, conformismo, censura e autocensura, dove su troppi temi i punti di vista dissonanti vengono immediatamente respinti come fake news, in un dibattito chiuso prima ancora di averlo aperto. Il complottismo, dunque – o meglio, l’etichettamento di posizioni critiche come complottiste – usato come arma politica per screditare il dissenso. Ma questa stigmatizzazione di posizioni minoritarie non si limita al piano verbale: come nel caso dei vaccini (per ora), ha legittimato soluzioni autoritarie nel segno dell’esclusione, della privazione di diritti essenziali, della separazione della cittadinanza tra meritevoli e non, sulla base dell’adesione e dell’obbedienza. È chiaro, e pure un’abbondante letteratura scientifica lo dimostra, che questo tipo di scelte – sia comunicative che politiche e legislative – determina un effetto boomerang (Attwell e Smith 2017; Goldenberg 2021), provocando la rottura della sfera pubblica come luogo di confronto di habermasiana memoria e, quindi, radicalizzazione delle posizioni (da entrambe le parti però, anche se si tende a dimenticarlo). Ma, tra chi viene escluso, si tratta di molto di più: di un senso di crescente estraniazione dal sistema di valori dominante e dalle sue categorie di lettura della realtà, di vissuti di lacerazione profonda e sofferta di legami e appartenenze, di «continenti percettivi che si allontanano, di forme di vita che diventano inconciliabili» (Manifeste, p. 31). Da qui occorre partire per capire come mai, a volte, si possa anche passare da una salutare diffidenza verso le narrazioni del potere alla convinzione, più problematica, che “tutto ciò che ci è stato insegnato è falso”.
Se solleviamo un altro velo, ci imbattiamo questa volta nella superficialità che conduce a un classismo evidentemente ignaro di sé. Quando parliamo di persone, e magari studiose/i, di sinistra, colpisce lo sbrigativo appiattimento sulle categorie ipersemplificanti e stigmatizzanti introdotte dal giornalismo mainstream (anti-vax, complottista e tutte le altre richiamate sopra). Soprattutto perché sono diversi gli studi che hanno invitato a uno sguardo più attento e cauto quando si parla di “complottismo”. Sottolineando, innanzitutto, come questo tenda a proliferare dove lo scostamento tra la realtà esperita dalle persone e la sua rappresentazione da parte di media e istituzioni supera una soglia critica. Il complottismo – o quello che molti definiscono con questa categoria, comunque problematica – prospera, insomma, sulle bugie delle élite. E ancor prima, sul non detto: prospera, cioè, laddove questioni che hanno un peso cruciale sulle nostre vite non diventano oggetto di un dibattito pubblico, aperto e capace di dare cittadinanza e legittimità ai diversi punti di vista.[1] Che è come dire, rovesciando la prospettiva, che sempre più spesso i presunti “complottisti” sono (lasciati) i soli a trattare, con mezzi e risorse eterogenei, questioni assolutamente vitali: dalle tecnologie 5(6)G all’impatto della più generale digitalizzazione della società, dal transumanesimo alle politiche sanitarie emergenziali.
E poi, soprattutto: chi decide quali teorie sono complottiste? Cosa distingue una teoria sociale critica da una conspiracy theory? Puntando l’attenzione sulle traiettorie seguite delle teorie sociali, Pelkmans e Machold (2011) mostrano come siano quelle promosse e sostenute dalle classi subalterne quelle che, con maggiore probabilità, finiranno per essere etichettate come complottiste. Non è insomma questione di fondatezza o razionalità, poiché non è agevole né forse possibile individuare criteri di distinzione su un mero piano epistemologico. Alla fine, la differenza la fanno i rapporti di potere. Tanto che una teoria del complotto, se sostenuta da attori in posizioni di potere, difficilmente sarà riconosciuta e ricordata come tale, anche qualora ne venga chiaramente dimostrata l’infondatezza, la strumentalità, talvolta la portata nefasta dei risultati (classico l’esempio delle “armi di distruzione di massa” suppostamente detenute da Saddam Hussein).
Del resto, a proposito di classismo, non ha destato le reazioni che avrebbe meritato la presa fortissima che ha recentemente acquisito, sugli scambi comunicativi di tutti i giorni, l’idea per cui solo chi ha un titolo di studio specifico sia titolato a parlare. Frutto avvelenato (uno dei tanti) del burionismo. Eppure, una tale idea è stata accolta e fatta propria, anche, o forse soprattutto, a sinistra. Senza la minima preoccupazione di quanto ciò significasse legittimare il silenziamento di quanti non hanno un titolo di studio elevato, il che poi sottende evidenti implicazioni di classe e giustizia sociale; né di quanto, in questo modo, si alimenti acriticamente la logica pericolosa per cui tanto si riserva il potere di decidere agli “esperti”, quanto inevitabilmente si spinge verso la depoliticizzazione delle questioni, restringendo lo spazio del dissenso e del confronto (ci tornerò più avanti).
Ma continuiamo a scavare. Siamo sicuri che sia (solo) il complottismo il problema? Non sarebbe urgente problematizzare anche, o forse soprattutto, quello che alcuni hanno battezzato il “dispositivo anti-complottista” e le sue implicazioni politiche?[2] Un’operazione, questa, che svolge il Manifeste conspirationniste, mostrando le vicende storiche che legano strettamente le origini della retorica anti-complottista – quindi fin da Karl Popper – con la genesi del neoliberalismo e del suo There Is No Alternative. Se tentare di produrre una intelligibilità storica del corso degli eventi è una presunzione fatale; se chiunque tenti di dire qualcosa su questo mondo che questo non dica già da sé oltrepassa i suoi diritti epistemologici: allora, non resta che adattarvisi. La funzione del dispositivo anti-complottista è fin dalle sue origini, questa la tesi degli autori, quella di legittimare l’ordine sociale esistente, ambendo a riservare per sé la facoltà di cospirare.
NOTE
[1] Cfr. Pelkmans e Machold (2011), Lagalisse (2020); sul tema del prosperare del complottismo sulle bugie dei potenti si può vedere anche la mia intervista a Erica Lagalisse, Teorie della cospirazione e critica sociale. Come il complottismo prospera, non sempre a torto, sulle bugie delle élite, “Malamente”, n. 20, gennaio 2021, p. 47-62, <https://rivista.edizionimalamente.it>.
[2] In Italia se ne è occupato per es. Lolli (2023)
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
Anonimo (2022), Manifeste conspirationniste, Parigi, Seuil.
Attwell K., Smith D.T. (2017), Parenting as politics: social identity theory and vaccine hesitant communities, “International Journal of Health Governance”, 22(3): 183-98.
Bazzoli, N., Lello, E. (2022), The neo-populist surge in Italy between territorial and traditional cleavages, “Rural Sociology”, 87(1): 662-691.
Bordignon, F. (2023), Alternative science, alternative experts, alternative politics. The roots of pseudoscientific beliefs in Western Europe, “Journal of Contemporary European Studies”, 31(4): 1469-1488.
Bucchi, M., Neresini, F. (2002), Biotech remains unloved by the more informed, “Nature”, 416: 261.
Chalmers J. (2017), The transformation of academic knowledges: understanding the relationship between decolonizing and indigenous research methodologies, “Socialist Studies”, 12(1): 97-116.
Coniglione, F., eds. (2010), Through the mirrors of science. New challenges for knowledge-based societies, Heusenstamm, Ontos Verlag.
Consigliere, S. (2020), Favole del reincanto: molteplicità, immaginario, rivoluzione, Roma, DeriveApprodi.
de Sousa Santos, B., Nunes, J. A., Meneses, M.P. (2022), Opening up the canon of knowledge and recognizing difference, “Participations”, 32(1): 51-91.
Dentico, N., Missoni, E. (2021), Geopolitica della salute: Covid-19, OMS e la sfida pandemica, Soveria Mannelli, Rubbettino.
Dotson, T. (2021). The divide: how fanatical certitude is destroying democracy, Cambridge, MIT Press.
Foucart, S., Horel, S., Laurens, S. (2020), Les gardiens de la raison: enquête sur la désinformation scientifique, Parigi, La Découverte.
Gigerenzer, G. (2015), Imparare a rischiare: come prendere decisioni giuste, Milano, Cortina.
Goldenberg, M. (2016), Public misunderstanding of science? Reframing the problem of vaccine hesitancy, “Perspectives on Science”, 24(5): 552-81.
Goldenberg, M.J. (2021), Vaccine hesitancy: public trust, expertise, and the war on science, Pittsburgh, University of Pittsburgh Press.
Grignolio, A. (2016), Chi ha paura dei vaccini?, Torino, Codice.
Harambam, J. (2021), Against modernist illusions: why we need more democratic and constructivist alternatives to debunking conspiracy theories, “Journal for Cultural Research”, 25(1): 104-122.
Harambam, J., Aupers, S. (2015), Contesting epistemic authority: conspiracy theories on the boundaries of science, “Public Understanding of Science”, 24(4): 466-480.
Jasanoff, S. (2021), Knowledge for a just climate, “Climatic Change”, 169(3): 1-8.
Kahneman, D. (2012), Pensieri lenti e veloci, Milano, Mondadori.
Keren, A. (2018), The public understanding of what? Laypersons’ epistemic needs, the division of cognitive labor, and the demarcation of science, “Philosophy of Science”, 85(5): 781-792.
Lello, E. (2020), Populismo anti-scientifico o nodi irrisolti della biomedicina? Prospettive a confronto intorno al movimento free vax, “Rassegna Italiana di Sociologia”, 3: 479-507.
Lello, E., Raffini, L. (2023), Science, pseudo-science, and populism in the context of post-truth. The deep roots of an emerging dimension of political conflict, “Rassegna Italiana di Sociologia”, 4: 705-732.
Lello, E., Saltelli, A. (2022), Lobbismo scientifico e dirottamento dello spazio pubblico, in E. Lello, N. Bertuzzi (eds.), Dissenso informato. Pandemia: il dibattito mancato e le alternative possibili, Roma, Castelvecchi, 187-203.
Lolli, A. (2023), Il complottismo non esiste o Miseria dell’anticomplottismo, in M.A. Polesana, E. Risi (eds.), (S)comunicazioni e pandemia. Ricategorizzazioni e contrapposizioni di un’emergenza infinita, Milano-Udine, Mimesis, 239-271.
Nunes, J. A., Louvison, M. (2020), Epistemologies of the South and decolonization of health: for an ecology of care in collective health, “Saude e Sociedade”, 29(3): e200563.
Osimani, B., Ilardo, M.L. (2022), “Nessuna correlazione”. Gli strumenti per la valutazione del nesso causale tra vaccinazione ed evento avverso, in E. Lello, N. Bertuzzi (eds.), Dissenso Informato. Pandemia: il dibattito mancato e le alternative possibili, Roma, Castelvecchi, 167-186.
Pielke, R.A.J. (2005), Scienza e politica, Roma-Bari, Laterza.
Quijano, A. (2005), Colonialidade do poder, eurocentrismo e América Latina, in A colonialidade do saber: etnocentrismo e ciências sociais. Perspectivas latino-americanas, Buenos Aires, Clacso, 117-142.
Reich, J.A. (2014), Neoliberal mothering and vaccine refusal: imagined gated communities and the privilege of choice, in “Gender and Society”, 28(5): 679-704.
Sarewitz, D. (1996), Frontiers of illusion: science, technology, and the politics of progress, Philadelphia, Temple University Press.
Saurette, P., Gunster S. (2011), Ears wide shut: epistemological populism, argutainment and Canadian conservative talk radio, “Canadian Journal of Political Science”, 44(1): 195-218.
Schadee, H.M.A., Segatti, P., Vezzoni C. (2019), L’apocalisse della democrazia italiana: alle origini di due terremoti elettorali, Bologna, Il Mulino.
Smith, P.J., Chu, S.Y., Barker, L.E. (2004), Children who have received no vaccines: who are they and where do they live?, “Pediatrics”, 114(1): 187-95.
Steinberg, T. (2006), Acts of God: the unnatural history of natural disaster in America, Oxford, Oxford University Press.
Taussig, M.T. (1986), Shamanism, colonialism, and the wild man: a study in terror and healing, Chicago, University of Chicago Press.
Wei, F., Mullooly, J.P., Goodman, M., McCarty, M.C., Hanson, A.M., Crane, B., Nordin, J.D. (2009), Identification and characteristics of vaccine refusers, “BMC Pediatrics”, 9(18): 1-9.
Wu Ming 1 (2021), La Q di Qomplotto. QAnon e dintorni. Come le fantasie di complotto difendono il sistema, Roma, Alegre.
Ylä-Anttila, T. (2018), Populist knowledge: post-truth repertoires contesting epistemic authorities, “European Journal of Cultural and Political Sociology”, 5(4): 356-388.
Zagzebski, L.T. (2012), Epistemic authority: a theory of trust, authority, and autonomy in belief, Oxford, Oxford University Press.
Zografos, C., Robbins, P. (2020), Green sacrifice zones, or why a green new deal cannot ignore the cost shifts of just transitions, “One Earth”, 3(5): 543-546.
Il puzzle del sesso biologico - Il proposito di Trump e un possibile diverso atteggiamento
Il 20 gennaio 2025, Donald J. Trump ha pronunciato il suo discorso presidenziale durante la cerimonia di insediamento come 47esimo presidente degli Stati Uniti. Fra i tanti propositi espressi, c’è quello di mettere fine alla «alla politica governativa di manipolare socialmente genere e razza. Da oggi, la politica ufficiale del governo degli Stati Uniti sarà che ci sono solo due generi: maschi e femmine» . Si è dimenticato che esistono gli intersex e che la materia è molto più complessa. Ma si sa, politici e giornalisti sono noti per banalizzare questioni serie e stravolgere la realtà.
In alcuni post precedenti (La costruzione di una identità, prima parte - Sesso (biologico), genere (sociale) e orientamento sessuale: 3 concetti non sovrapponibili, Seconda parte – Il sesso nell’antichità, Individuare il sesso, una storia infinita, e Cosa succede quando si nasce intersessual*?), abbiamo analizzato come nel campo biomedico si è costruito (nel tempo) il sesso biologico e diversi casi controversi nell’attribuzione dell’identità sessuale. L’antropologia, poi, è un campo privilegiato per conoscere come (in molte culture) l’identità sessuale sia uno “spettro” (nel senso di un fascio policromatico, un raggio d'azione, un range) più che un’ontologia dicotomica o binaria. Siamo quindi giunti alla conclusione che il sesso biologico è un puzzle costituito da molteplici tessere: cromosomi, marcatori genetici molecolari, dotti riproduttivi, gonadi, ormoni, organi riproduttivi per la loro funzione, genitali per la forma e funzione, pubertà (intesa come flusso ormonale secondario) e funzioni riproduttive incluse (ma non unicamente), produzione del seme, inseminazione, gestazione e caratteristiche sessuali secondarie quali sporgenza della cartilagine tiroidea che circonda la laringe (o pomo d’Adamo), crescita dei capelli, rapporto tra massa grassa e muscolare, crescita mammaria, voce, sesso psicologico, educazione ecc. L’intersessualità, nella larga maggioranza dei casi, non incide in modo significativo sulla salute della persona. E i genitali sono, quindi, soltanto una parte del corpo, che varia da persona a persona, come i nasi o le orecchie o altre parti del corpo. L’aspetto e loro dimensioni non sono determinanti per l’attribuzione sessuale.
LA MANIA DELLE CLASSIFICAZIONI
Al di là delle varie (controversie) metodiche per attribuire il sesso a una persona, forse vale la pena chiedersi: ma perché è così importante stabile se quello davanti a me è un maschio o una femmina (ammesso che lo si possa determinarlo così facilmente)? Qual è lo scopo di una classificazione?
Il sociologo Harold Garfinkel, il padre dell’etnometodologia , sosteneva che qualsiasi categorizzazione (o il collocamento di un oggetto/pianta/animale/persona in un tipo) è una costrizione, sempre relativa perché stabilita in relazione agli scopi pratici (“for all practical purposes”) di coloro che classificano[1]. In altre parole, non c’è nulla nella referente osservata che indichi a quale categoria essa debba necessariamente appartenere. Una posizione anti-essenzialista, che condivide con la filosofia taoista dove non esistono valori assoluti, enti fissi o immobili, esseri o cose a sé stanti, come invece le categorie vorrebbero.
Per cui, ogni volontà di classificazione risponde a una necessità pratica. Nello sport, dove in tempi recenti sono stati sollevati i casi dell’ostacolista spagnola Maria José Martínez-Patiño, della mezzo-fondista sudafricana Caster Semenya, della calciatrice zambiana Barbra Banda e (pochi mesi fa) della pugile algerina Imane Khelif (vedi Individuare il sesso, una storia infinita), lo scopo sarebbe di porre tutte e tutti nelle medesime condizioni di partenza. Che è un’assurdità, perché non siamo tutti e tutte uguali, neanche… alla partenza. Giancarlo Antonioni (grande n. 10 della Fiorentina) non era uguale a Pelè (n. 10 del Santos). Lo scontro, se fosse stato un duello individuale, sarebbe stato impari. Come lo fu, nel 1970 e 1971, tra Carlos Monzon e Nino Benvenuti. Eppure stavano nella stessa categoria (pesi medi).
Inoltre, se la differenza tra uomini e donne fosse così netta, come mai certe tenniste (ma l’esempio lo si può fare per tutti gli sport) possono benissimo battere certi tennisti? Non ci sono solo il testosterone o 1 coppia cromosomica a fare la differenza, ma una molteplicità di altre variabili. Che sfuggono alle categorizzazioni, che le categorie non riescono a gestire. Il pugile Primo Carnera combatteva con quelli del suo peso, eppure forse aveva un vantaggio datogli da una presunta malattia genetica (l’acromegalia), in cui l'eccessiva produzione di ormone della crescita (Growth Hormone, GH) indotto spesso da un adenoma dell'ipofisi produce una serie di modificazioni degli arti e dei tratti facciali (anche il campione statunitense di wrestling André The Giant sembra esserne affetto). Attorno alle atlete sopra ricordate nacquero molte polemiche (che produssero anche squalifiche). Eppure loro erano nate così. Invece il velocista sudafricano Oscar Pistorius non era nato con le protesi in fibra di carbonio; eppure dal 2008 fu ammesso a gareggiare con i (cosiddetti) normodotati.
 Ma non perdiamo la domanda di partenza: qual è la necessità pratica che presiede questa particolare necessità di classificazione binaria (maschi e femmine) nello sport? La competizione. Stabilire chi è il migliore, chi è il primo, chi è il più bravo. Lo scopo (eminentemente pratico) è solo questo. Non ci sono altre ragioni. Togliamo questa ragione (eminentemente pratica) e tutto crolla. Infatti, sono certo che se le pugili Imane Khelif (accusata di essere un uomo) e Angela Carini lavorassero nella stessa azienda, nessun politico chiederebbe (perché contrattualmente, purtroppo, le cose stanno ancora così in molte professioni) per Khelif uno stipendio maggiore perché ha una coppia di cromosomi XY. Perché se lo facesse, arriveremmo al paradosso che, lei sarebbe un maschio per lo sport e una femmina per il lavoro.
Ma non perdiamo la domanda di partenza: qual è la necessità pratica che presiede questa particolare necessità di classificazione binaria (maschi e femmine) nello sport? La competizione. Stabilire chi è il migliore, chi è il primo, chi è il più bravo. Lo scopo (eminentemente pratico) è solo questo. Non ci sono altre ragioni. Togliamo questa ragione (eminentemente pratica) e tutto crolla. Infatti, sono certo che se le pugili Imane Khelif (accusata di essere un uomo) e Angela Carini lavorassero nella stessa azienda, nessun politico chiederebbe (perché contrattualmente, purtroppo, le cose stanno ancora così in molte professioni) per Khelif uno stipendio maggiore perché ha una coppia di cromosomi XY. Perché se lo facesse, arriveremmo al paradosso che, lei sarebbe un maschio per lo sport e una femmina per il lavoro.
UNA PROPOSTA DI SOLUZIONE PER GLI SPORT DI SQUADRA
In attesa di trovare delle soluzioni per gli sport individuali, qualcosa invece si potrebbe già fare, almeno per quelli collettivi. Unico settore dove ancora esiste una rigida divisione tra maschi e femmine (con tutti i controlli necessari per incasellare le persone in una delle due categorie) ormai scomparsa a scuola, nei collegi, nella polizia e perfino nell’esercito, un tempo autentica palestra machista. Perché mantenere questo apartheid sportivo, anziché dissolverlo in squadre miste e intersex?
NOTE
[1] Ad esempio i censimenti e le classificazioni anagrafiche sono nate per scopi pratici: il controllo sociale della popolazione, la quantificazione dei beni, il reclutamento di militari ecc. Infatti, le prime informazioni riguardo a indagini sulla popolazione risalgono addirittura al 3800 a.C. dove i Sumeri affrontavano vere e proprie indagini per misurare la quantità di uomini e beni di cui si poteva disporre. Le informazioni acquisite erano utili soprattutto in caso di guerra o di carestie. Nella Bibbia si fa riferimento al censimento effettuato da Mosè nel Sinai: il Signore parlò a Mosè, (…), e disse: ‹‹Fate il censimento di tutta la comunità degli Israeliti, secondo le loro famiglie, secondo il casato dei loro padri, contando i nomi di tutti i maschi, testa per testa, dall'età di venti anni in su, quanti in Israele possono andare in guerra (…)››. (Numeri 1, 1-3. Vedi anche Esodo 30,11-16): https://it.wikipedia.org/wiki/Censimento. Il controllo sociale è anche il principale motivo per cui è nata la statistica sociale.
Internet ci rende transumani - La fattoria degli umani di Enrico Pedemonte
1. QUELLO CHE L’UTOPIA NON SA
«Il male che gli uomini fanno sopravvive loro; il bene è spesso sepolto con le loro ossa». Il rammarico dell’Antonio di Shakespeare potrebbe essere rivolto alle utopie che hanno accompagnato la nascita di Internet e dei dispositivi digitali, e i nomi di di Vannevar Bush o di Douglas Engelbart potrebbero sostituirsi a quello di Cesare. Nel 2008 Nicholas Carr si domandava se Google ci rende stupidi, e di sicuro oggi molti analisti concordano sul fatto che non siamo qui a lodare la convinzione che le macchine possano contribuire ad aumentare l’intelletto umano – ma a seppellirla. Dalla presentazione del 9 dicembre 1968, con cui Engelbart ha mostrato per la prima volta l’interazione con un computer tramite mouse e interfaccia grafica, siamo passati attraverso la commercializzazione massiva della Rete, la formazione dei monopoli delle Big Tech, il saccheggio dei dati personali, lo sviluppo della società del controllo, la dipendenza patologica dalle piattaforme, la filter bubble, la polarizzazione delle opinioni e il dibattito sulla disinformazione. Di sicuro si è persa l’innocenza delle origini, la promessa di un nuovo mondo della comunicazione, la speranza di una libertà che il principio di realtà aveva negato nel mondo offline, la fiducia in comunità virtuali, senza confini, dove raggiungere una piena espressione del sé di ognuno.
Enrico Pedemonte ripercorre la storia che porta da Vannevar Bush fino ai nostri giorni in La fattoria degli umani, cercando di capire cos’è successo all’utopia degli spazi digitali, cosa si è inoculato nel sogno di un’umanità più perspicace e più emancipata precipitandolo in un incubo, nel terrore che tutto possa concludersi con lo sterminio della nostra specie da parte di un’AI superintelligente. L’ipotesi che un giorno o l’altro una macchina assuma l’aspetto di Terminator e compia una strage, come in un film di fantascienza, non è una preoccupazione realistica; ma è significativo che la retorica da cui viene accompagnato lo sviluppo delle nuove tecnologie abbia dismesso l’entusiasmo per l’intelligenza connettiva di Pierre Lévy, e abbia abbracciato il timore di scenari catastrofici. Pedemonte sospetta che un vizio sia presente fin dall’origine, e che i suoi effetti si siano amplificati con l’espansione della forza economica e del potere politico dei giganti della Silicon Valley.
2. IMMUNITÀ LEGALE
Anzi, i difetti sono almeno due, e si sono rafforzati l’un l’altro, o sono forse due sintomi di una stessa crisi, ancora più profonda. Il primo ha origine fuori dall’ambiente culturale della Silicon Valley, e si sviluppa nel cammino tormentato con cui il parlamento americando ha raggiunto la versione definitiva del Communications Decenct Act. La legge stabilisce che le piattaforme online non devono essere equiparate agli editori tradizionali, e le tutela da ogni intervento del governo nei loro confronti: in questo modo attori del nascente mercato digitale, come Google, Facebook, Twitter, sono stati messi al riparo da qualunque regolamentazione sia sul controllo dei contenuti, sia sulla ripartizione della distribuzione pubblicitaria – e più in generale sulla valutazione delle loro posizioni monopolistiche nei settori della ricerca, dei social media, dell’intelligenza artificiale. La supervisione che viene applicata ai giornali, alle radio e alle reti televisive, non agisce sugli algoritmi che gestiscono il ranking dei listati di risposte, la selezione dei post e la composizione delle bacheche personali, la profilazione dell’advertising: eppure tra il 2004 e il 2021 il numero di giornali nel mondo è quasi dimezzato (-47%), mentre l’accesso alle notizie tramite i social media è diventato una consuetudine tra gli utenti del Web.
Ma l’obiettivo delle piattaforme tecnologiche non è quello di consolidare la fiducia dei lettori nella verità dei contenuti divulgati, bensì quello di trattenerli il più possibile nella compulsione delle bacheche, e nell’incentivare il più possibile l’interazione con like, commenti, condivisioni. Mentre la verità si sta ancora allacciando le scarpe, una bugia ha già fatto il giro del mondo: così chiosava Mark Twain. Il controllo delle informazioni richiede tempo, e il più delle volte una storia esposta in buona fede è affetta da lacune, passaggi critici, contraddizioni; l’artefazione, o (quando serve) l’invenzione completa dei fatti, possono invece adattarsi all’ecosistema ideologico degli interlocutori, e sfrecciare da una mente all’altra senza ostacoli. La fatica che è richiesta all’utente nella ricognizione della complessità del reale, gli viene del tutto risparmiata quando la notizia è costruita attorno all’effetto emotivo, che suscita scandalo, orrore, sdegno o pietà. Le notizie a tinte forti attraggono i clic, coinvolgono i lettori, accendono il dibattito – spingono verso la radicalizzazione dei pregiudizi, a detrimento della riflessione e della mediazione. Gli esiti sono tossici per lo stato di salute delle democrazie e per la coesione sociale; per i bilanci delle società che amministrano le piattaforme sono invece un toccasana, perché assicurano il buon funzionamento della loro attività produttiva principale, l’estrazione dei dati.
3. DATI
Shoshana Zuboff ha sottolineato l’affinità tra il modello di business di imprese come Google e Facebook da un lato, e l’industria mineraria o petrolifera dall’altro lato. Le informazioni che le Big Tech estraggono dal comportamento degli utenti permettono loro di conoscere le caratteristiche sociodemografiche, gli interessi, le opinioni, le abitudini, le relazioni personali, le disponibilità di spesa, le paure di ognuno e di tutti – e naturalmente anche di controllarli, manipolarli, sfruttarli. Nessun settore imprenditoriale si è mai rivelato tanto promettente dal punto di vista dei profitti, e nessuno è stato così agevolato nella crescita, e messo al riparo dalle difficoltà minacciate dalle istituzioni a tutela della privacy e della libera concorrenza, nonché dalle interferenze di attivisti e giornalisti troppo curiosi. Motori di ricerca e social media serbano una biografia di ciascuno di noi più ampia, più ricca e obiettiva, di quella che noi stessi sapremmo confessare nel segreto del nostro foro interiore: nella registrazione di tutte le nostre domande, dei nostri like e dei nostri post, protratta per anni, si deposita una traccia delle aspirazioni, degli interessi e delle paure di cui spesso non conserviamo una memoria cosciente, ma che i database di Google e di Facebook mettono a disposizione degli inserzionisti. Inconscio, abitudini e passioni, individuate nel momento in cui emergono da pulsioni interne o da opportunità sociali, diventano la leva ideale per vendere prodotti e servizi – ma anche candidati elettorali, ideologie, priorità e strategie politiche.
Le piattaformi digitali tendono al monopolio: le persone frequentano i posti dove si trovano già tutti i loro amici, o cercano le informazioni che sono condivise dai loro clienti e dagli interlocutori in generale. In questo modo chi ha accumulato più dati è in grado di offrire esperienze più divertenti e informazioni più personalizzate, intercettando quindi nuovi utenti e appropriandosi ancora di più dati. Chi vince piglia tutto, come accade a Google che detiene circa il 90% delle quote del mercato della ricerca online mondiale. La tensione che ha alimentato questa forma di capitalismo trova la sua ispirazione e giustificazione ideologica nella letteratura di Ayn Rand e della fantascienza che ha nutrito imprenditori, tecnici, guru, profeti e visionari nerd della Silicon Valley: è questo il secondo vizio – questa volta del tutto interno alla cultura tech – che ha segnato dalle origini il percorso delle utopie della Rete. L’umanità deve essere salvata da se stessa, dalla sua imperfezione e dalla sua mortalità, e questo compito può essere assunto solo da un eroe che trascende qualunque limite gli venga opposto dalla società, dalla legge, dalle tradizioni e persino dal buon senso (anzi, da questo prima di tutto). L’individualismo senza rimorsi, la tensione a diventare l’eletto che porterà gli altri uomini oltre se stessi, anche a costo della loro libertà – sono il codice in cui è scritto il programma utopistico della Rete, come sede della vita che vale la pena di essere vissuta. Chi non ce la fa, o chi cerca di resistere – o addirittura chi tenta di non essere d’accordo – è destinato a soccombere e a scivolare nell’oblio della storia. La violazione della privacy, il prelievo dei dati, la manipolazione delle intenzioni, non sono quindi attività illegali, ma sono i doni che l’eroe riversa sull’umanità, per liberarla dalle sue limitazioni, dalle sue paure irrazionali, dalla sua mortalità.
4. L’UOMO (?) CHE VERRÀ
Pedemonte elenca sette movimenti in cui si possono classificare le mitologie principali da cui è guidato il capitalismo della Silicon Valley: Transumanesimo, Estropianesimo, Singolarismo, Cosmismo, Razionalismo, Altruismo Efficace, Lungotermismo. Le categorie non sono esclusive, si può aderire a più parrocchie nello stesso tempo, o transitare nel corso del tempo da una all’altra. In comune queste prospettive coltivano il culto dell’accelerazione nello sviluppo di nuove tecnologie, l’ambizione di realizzare simbionti tra uomo e macchina, dilatando le capacità cognitive degli individui, riprogrammando la vita e la natura, eliminando imprevisti, patologie e – ove possibile – anche la morte.
Le aspirazioni appartengono alla fantascienza, le intenzioni utopistiche sono sepolte e dimenticate, ma lo sviluppo di metodi di controllo, l’accentramento monopolistico, la violazione della proprietà intellettuale, l’abbattimento progressivo dello stato sociale e la privatizzazione dei suoi servizi, sono ormai la realtà del capitalismo dei nostri giorni – che ha trovato nelle tecnologie digitali, e nell’etica hacker che ne sostiene la progettazione, la piattaforma su cui reinventarsi dopo la crisi degli ultimi decenni del XX secolo. La realtà che è sopravvissuta alle utopie novecentesche è un mercato che ha assorbito la politica e la cultura, dove l’unico individuo che può esprimersi liberamente è quello transumanistico, che pone la macchina come obiettivo, e l’autismo del nerd come modello di vita.
BIBLIOGRAFIA
Carr, Nicholas, Is Google Making Us Stupid?, «The Atlantic», vol. 301, n.6, luglio 2008.
Engelbart, Douglas, Augmenting human intellect: A conceptual framework, SRI Project 3578 Stanford Research Institute, Menlo Park California October 1962.
Lévy, Pierre, L'Intelligence collective. Pour une anthropologie du cyberespace, La Découverte, Parigi 1994.
Pedemonte, Enrico, La fattoria degli umani, Treccani, Milano 2024.
Zuboff, Shoshana, The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power, Profile Books, Londra 2019.
Covid, tecnocrazia e "vera" politica - Due progetti paralleli
Dalle prime due parti (qui, la prima parte e qui, la seconda parte) dell’analisi degli algoritmi di valutazione dell'andamento della pandemia, ad aprile 2020, è emerso che questi algoritmi sono un caso solo apparente di tecnocrazia.
In realtà, abbiamo visto che:
- il tentativo di rendere gli algoritmi completi ha generato un eccesso di complessità che ha reso questi strumenti praticamente inservibili ai fini della decisione sulla Fase 2
- la decisione di passare alla Fase 2 è stata principalmente politica, seppur basata su un set minimale di dati scientifici, limitato ai trend di contagi, decessi e di saturazione delle terapie intensive.
Ora, questo non toglie che la relazione tra scienziati e governo abbia effettivamente avuto un carattere tecnocratico già nel primo periodo della pandemia[1], tra febbraio e maggio 2020.
Per comprendere la reale portata ed estensione di questo carattere tecnocratico faremo alcune brevi considerazioni su:
- il CTS e la rilevanza del valore della salute nella gestione della crisi
- il ruolo che ha giocato il CTS nei processi di decisione del governo
Vedremo che il governo ha preso le sue decisioni in modo principalmente politico ma, invece, ha lasciato ampio spazio a scienziati e tecnici sul come metterle in atto.
COS’ERA E COME FUNZIONAVA IL COMITATO MEDICO SCIENTIFICO
La presenza del CTS nel processo di decisione del Governo ha, certamente, amplificato il ruolo dei valori di salute e di sopravvivenza come condizioni di possibilità del bene comune e, quindi, ha condizionato le azioni del governo nella direzione di “prima la salute”.
Infatti:
- il ruolo del CTS era di dare consulenza al Capo del Dipartimento della Protezione Civile – e più tardi direttamente al Governo – su come fronteggiare la diffusione del contagio;
- i componenti del CTS erano “esperti e qualificati rappresentati degli Enti e Amministrazioni dello Stato”, di fatto 8 componenti su 12 erano medici: i tre presidenti del Consiglio superiore di sanità, dell'Istituto superiore di sanità e dell’AIFA, un professore di patologia clinica e di comunità, un esperto di medicina delle catastrofi, un infettivologo e un epidemiologico.
- Il CTS era sempre – ogni giorno, al mattino molto presto – l’iniziatore del processo di decisione. Era il CTS a effettuare la sintesi e il vaglio delle informazioni raccolte dal fronte del contagio e a prepararsi, sulla base dei dati, a dare consiglio al Capo della Protezione civile e ai rappresentanti del Governo, in primis al Ministro della Salute;
- spesso, il CTS agiva in coda al processo, assumendo la funzione di supporto e di legittimazione delle decisioni prese: i membri del CTS partecipavano e parlavano alle conferenze stampa e ai talk show fornendo elementi di spiegazione e di sostegno alle misure restrittive o meno del Governo.
Ora, per disciplina, per etica procedurale, la salute è il faro guida del medico, soprattutto in termini di assenza di malattia, di normale funzionamento del corpo, «Dovere del medico è la tutela della vita, della salute fisica e psichica dell'Uomo e il sollievo dalla sofferenza» (Codice di Deontologia Medica, all’Art. 3 – Doveri del Medico).
Ne risulta abbastanza ovvio che il CTS - un consesso di medici - si sia concentrato sui pilastri deontologici, guarire chi si è ammalato, garantire il funzionamento delle strutture di cura e, in caso di infettività, prevenire e controllare la diffusione della malattia.
Altrettanto ovvio appare il fatto che il Governo, consigliato e sostenuto dal CTS abbia posto i valori della salute e della sopravvivenza biologica al primo posto della propria scala assiologica nell’affrontare la crisi.
È interessante, peraltro, vedere che paesi iper-liberisti come Inghilterra e Brasile, in cui non c’era nulla di simile al nostro CTS, si siano, invece, orientati più nettamente sui valori della sussistenza economica delle imprese, del paese in generale e di conseguenza dei cittadini, mettendo in conto «un numero evitabile di persone contagiate e di morti» (Habermas J., Proteggere la vita, tr. It. D’Aniello F., Società editrice Il Mulino, 2022, p. 51); è famosa l’infelice frase di Boris Johnson: «many more families are going to lose loved ones before their time».
TECNOCRAZIA O NO?
Si ripropone quindi la domanda: Il Governo ha davvero preso delle decisioni, ha fatto delle scelte morali[2], oppure chi le ha fatte è stato il CTS?
Prima di provare a dare una risposta va ricordato che la più grande partita di decisioni si è giocata sul campo dell’economia, quello degli aiuti e dei sostegni economici.
Su questo campo il governo ha preso delle posizioni, ha compiuto delle vere e proprie scelte morali, basate su dei criteri e su una assiologia chiari; una assiologia che ha determinato la destinazione e i tempi dei sostegni economici, a chi prima e a chi dopo, a chi di più e a chi di meno. La scala di priorità è stata inizialmente concentrata sui lavoratori dipendenti delle imprese medio-grandi, quelle in grado di accedere alla cassa integrazione guadagni, per intenderci ed è poi cambiata, per rispettare le istanze di giustizia sociale portate avanti dalle opposizioni: occhio ai dimenticati dei primi momenti – tra cui liberi professionisti, lavoratori autonomi e microimprese.
Fatta questa premessa, proviamo a focalizzare quale sia stato il rapporto tra CTS e Governo nei primi mesi; l’analisi[3] di documenti video, di verbali e di decreti mostra che:
- è fuori di dubbio che il Governo abbia fatto delle scelte morali sul tema della salvaguardia della salute e della sopravvivenza. Il Governo ha delineato una scala di valori e questi valori li ha contestualizzati nel particolare della situazione che andava affrontando.
- È altrettanto fuori di dubbio che, nel costruire questa priorità di valori che vede salute e sopravvivenza in alto, il governo sia stato influenzato dal CTS – soprattutto dalla componente medica. Però, è emerso anche che la storia personale dei leader di governo, la tradizione di partito, le esperienze fatte, abbiano avuto un ruolo determinante
- Dove, invece, il Governo è stato molto più influenzato dal CTS sembra essere stato nel COME realizzare la tutela della salute e della vita. In questo, la vera scelta del governo è stata di affidarsi a tecnici, ai medici, agli epidemiologi. Lo dice Conte in passaggio chiarissimo il 25 di febbraio.[4]
- È evidente che la scelta di affidarsi a scienziati e tecnici è stata fatta sulla base del criterio delle competenze mediche e tecniche del CTS.
Quindi, sul come gestire la crisi, come salvaguardare la salute, il governo ha scelto di affidarsi, consapevolmente, a quelli che riteneva competenti e questo delinea palesemente una forma di tecnocrazia indiretta. Il processo analisi – sintesi – decisione – legittimazione in cui il CTS è dominante in tre passaggi su quattro ne è conferma.
Ma, ricordiamolo, all’inizio nessuno sapeva cosa stesse accadendo, né capiva cosa potesse accadere e, in quel momento di emergenza, il fattore tempo sembrava essere determinante[5].
Così come – in un momento successivo - ha fatto affidando a un militare la logistica della distribuzione dei vaccini. In Italia solo i militari hanno competenze logistico-operative e piani già pronti di quel tipo. Nessun altro. Non avrebbe potuto farlo un tecnico degli acquisti come Arcuri (bravo a reperire materiali con contratti emergenziali a prova di bomba).
Che poi il CTS abbia seguito delle linee super consolidate e tradizionali come l’ospedalizzazione sempre e comunque, la rinuncia alle cure domiciliari, linee che trovano una impressionante analogia nel Diario della Peste di Defoe – parliamo del 1665 – è altra cosa, su cui non credo di poter dare giudizi. Mi tengo dei sospetti.
Quindi, in conclusione, siamo stati di fronte ad una forma di solo parziale tecnocrazia, in cui il governo ha mantenuto per sé la prerogativa delle decisioni politiche sul cosa fare per gestire la crisi sanitaria ed economica, in termini di priorità, quantità, destinazioni, inclusioni ed esclusioni, ma ha ceduto sovranità alla scienza e alla tecnica sul come perseguire a questi obiettivi.
NOTE
[1] Non considero quello che è successo nei mesi successivi, con le due seconde ondate, quella di riaperture e quella di contagi dell’autunno 2020, del secondo lockdown, dei vaccini, del green pass e delle varie misure interdittive.
[2] Scelta morale: decisione su come orientare la propria condotta pratica basata su una scala di priorità tra principi o valori, appunto, morali.
[3] Le fonti sono i discorsi pubblici del Presidente de Consiglio e dei diversi Ministri – reperibili facilmente su YouTube o sul sito della Presidenza del Consiglio, i testi dei Decreti del presidente del Consiglio, i Decreti Ministeriali, le circolari della Protezione Civile, ecc.. Chi volesse avere un’ampia bibliografia e sitografia può chiederla alla Redazione di Controversie.
[4] Le parole di G. Conte: «io non ho competenza scientifica in questo campo, non ho alcuna competenza, e sarebbe presuntuoso […] sopravanzare e sovrapporsi a […] quelle che sono le valutazioni tecnico-scientifiche […] loro hanno articolato quelli che sono tutti i comportamenti e sono raccomandazioni indicazioni rivolte al personale sanitario e ovviamente a tutti i cittadini» (Conferenza stampa del Presidente Conte dalla Protezione civile, YouTube - Palazzo Chigi, Canale ufficiale del Governo italiano, 25 febbraio 2020 (https://www.youtube.com/watch?v=gWJoo8O6mZ8))
[5] Il problema del confronto con una situazione in cui «i fatti sono incerti, la posta in gioco alta, i valori in conflitto, e le decisioni urgenti» è affrontato dalle raccomandazioni della Scienza Post Normale; rimandiamo a Saltelli, A., 2024, SCIENZA POST-NORMALE, XI Appendice dell’Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettere ed Arti, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma - https://www.researchgate.net/publication/387296164
Gli algoritmi del Covid-19. Un caso di tecnocrazia? - Seconda parte
Nella prima parte di questo percorso abbiamo esaminato i meccanismi algoritmici che avrebbero dovuto guidare il Governo Conte nelle decisioni sull’allentamento delle misure restrittive e di contenimento del contagio da SARS-CO-V-2.
Ora possiamo fare un passo in avanti nell’analisi critica degli strumenti di valutazione e sul loro ruolo nelle decisioni del Governo.
CONSISTENZA DEGLI INDICATORI
Nell’intenzione del Ministero della Salute e del Governo – e del Comitato Tecnico Scientifico che ha messo a punto i criteri e gli algoritmi – questi strumenti di valutazione del contagio e delle possibilità di contrastarlo dovrebbero essere il più possibile esatti, coerenti, oggettivi e indipendenti dalle interferenze politiche, e guidare il governo in modo sicuro e incontrovertibile verso la decisione “scientificamente” più corretta.
Di fatto, invece, il sistema di valutazione presenta delle aree di criticabilità metodologica, dei punti di debolezza e di incoerenza – soprattutto considerando il particolare momento in cui deve essere utilizzato - e risente di alcune evidenti influenze di tipo storico, sociale e politico che ne minano le attese di esattezza, oggettività e indipendenza.
Tra queste criticità, spicca che alcuni degli indicatori della capacità di monitoraggio[1] sono statisticamente poco indicativi in un momento in cui la capacità diagnostica è fortemente sottodimensionata. In questo particolare periodo la propensione italiana alla diagnosi con tampone è tra le più basse d’Europa (pur con una percentuale di positivi molto più alta degli altri paesi). Parliamo di una media di soli 88 tamponi per 100.000 abitanti al giorno.[2] Ne viene particolarmente inficiato il riferimento alla percentuale di casi segnalati con indicata la data di inizio dei sintomi e/o il comune di domicilio del caso stesso. Quello che questo indicatore misura effettivamente è un sottoinsieme non rappresentativo della situazione reale.
Un discorso simile vale per gli indicatori sulla capacità di accertamento diagnostico., in particolar modo per quelli relativi ai tempi tra inizio dei sintomi, diagnosi e isolamento. Per le ragioni appena viste di scarsa propensione “al tampone”, il numero di diagnosi effettuate e segnalate è sicuramente molto inferiore ai casi realmente presenti sul territorio; d’altro canto, l’indicatore – in questo periodo - non può che essere “fuori soglia”, a causa del meccanismo per lo più carente di prescrizione, prenotazione ed esecuzione del test diagnostico, che dilata enormemente i tempi tra inizio dei sintomi e diagnosi.
Un altro punto di caduta è rappresentato dagli indicatori sull’impegno di personale dedicato al tracciamento e al monitoraggio dei contatti oltre che alle operazioni di prelievo e invio dei test ai laboratori Un impegno che dovrebbe essere in linea con raccomandazioni Europee relative agli standard su numero, tipologia e ore di lavoro.
Un indicatore metodologicamente confuso, poiché mette insieme “mele con pere” (le mele sono l’impegno di contact-tracing, le pere l’impegno di gestione del processo di invio ai laboratori), con contorni poco chiari: il termine tipologia figure professionali è di difficile interpretazione in assenza di un elenco chiuso e condiviso di tipologie; il valore di riferimento per l’impegno pari a 1 operatore equivalente ogni 10.000 abitanti[3] (verbalizzato al CTS il 29 di maggio) cioè almeno 750 operatori per la sola area del milanese, ma, di nuovo, senza indicazioni su che tipologie di figure professionali debbano essere impiegate.
Inutile parlare della percentuale di casi confermati di infezione nella regione per cui sia stata effettuata una regolare indagine epidemiologica con ricerca dei contatti stretti: è un indicatore importante ma decisamente fuori contesto nella situazione di aprile – maggio 2020, in cui il Sistema Sanitario rincorre a distanza con i pochi mezzi disponibili l’evolversi del contagio. Lo stesso vale per i parametri di trasmissione che implicano l’analisi dei focolai e delle catene di trasmissione. Entrambi gli indicatori risultano incongrui nella situazione di aprile e maggio 2020.
Gli indicatori sulla stabilità della trasmissione sembrano essere più consistenti e aderenti al contesto: in linea generale, il trend dei casi segnalati alla Protezione Civile e al sistema integrato di sorveglianza sono sicuramente rappresentativi dell’andamento del contagio, anche se probabilmente sottostimano il fenomeno e risentono – nella componente di temporalità – dei difetti procedurali già visti. L’indicatore dei casi segnalati alla Sentinella COVID-Net è opzionale e – di fatto – non attuato, come non sembra essere mai stata attuata la rete-sentinella.
Un discorso a parte andrebbe fatto – ma non è questa la sede - per il parametro Rt, uno strumento che sembra essere metodologicamente valido solo se i significati di alcuni suoi parametri[4] vengono usati con cautela.
UNA QUESTIONE DI POLITICA SANITARIA: GLI INDICATORI DI OSPEDALIZZAZIONE
Nel terzo gruppo di indicatori – quello dei parametri di trasmissione e di tenuta dei servizi sanitari, troviamo il Tasso di occupazione della Terapia Intensiva, con la soglia accettabile del 30%, e il Tasso di occupazione dei posti letto in Area Medica per pazienti COVID-19, con una soglia di accettabilità del 40%. Questi due parametri sono sintomatici dell’approccio di ospedalizzazione che caratterizza la gestione del contagio in Italia: quello che preoccupa il CTS e il Ministero è se gli ospedali sono in grado di sostenere il flusso di malati da ricoverare, ignorando completamente – anche negli indicatori oltre che nella pratica – il ruolo della medicina territoriale, della terapia domiciliare (attuata solo sporadicamente in poche regioni) e della relativa sorveglianza. Di fatto, chi è malato e ha sintomi preoccupanti deve andare in ospedale; chi, invece, è malato e non va in ospedale è sostanzialmente lasciato a sé stesso; non è interessante – per la valutazione dell’andamento della pandemia – avere dati sulla consistenza del presidio medico territoriale e domiciliare: il focus è l’ospedale.
INCOERENZE INTERNE DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE E DI ALLERTA?
È curioso notare che l’algoritmo di valutazione del rischio è contenuto nello stesso documento dei 21 indicatori puntuali e di trend, ma – in realtà – fa riferimento solo al terzo gruppo di indicatori, quelli sulla trasmissione del contagio e sulla tenuta della risposta sanitaria (ospedaliera, s’intende) e include dei criteri di valutazione che esulano dai 21 indicatori - ad esempio, la gestibilità o meno della diffusione con “zone rosse” localizzate, oppure l’età (oltre i 50 anni) dei soggetti contagiati.
Lo sviluppo dell’algoritmo di calcolo del livello di rischio – nonostante sia un sistema di allarme per la “marcia indietro” verso misure di controllo più rigorose - sembra essere slegato da due terzi degli indicatori e assai riduttivo rispetto a quello per valutare la possibilità di transizione alla Fase 2.
Sembra che l’allerta e la marcia indietro tengano conto della sola misura dei fenomeni e non della loro misurabilità; come dire: non importa se i dati non sono affidabili, si decide su quelli.
D’altra parte, è pur vero che il sistema di calcolo prevede che – in caso di difficoltà o scarsa affidabilità delle misurazioni – ci si attesti su una condizione di rischio elevato e si imponga la “marcia indietro”.
In conclusione, dall’esame di dettaglio, si evidenziano numerosi punti deboli, in sintesi:
- scarsa indicatività statistica di una buona parte degli indicatori relativi alla capacità di monitoraggio e di accertamento diagnostico
- incongruenza di altri indicatori rispetto al contesto in cui sono applicati e, quindi alla loro effettiva utilizzabilità
- visione focalizzata sulle procedure di ospedalizzazione dei parametri di tenuta dei servizi sanitari e assistenziali
- incoerenza di alcuni passi dell’algoritmo di valutazione del rischio rispetto all’insieme di indicatori di processo e di risultato e la scarsa integrazione tra i due algoritmi
SIAMO DI FRONTE AD UN CASO DI SCIENTIFIZZAZIONE DELLA POLITICA?
Lo strumento di valutazione del tasso di rischio e delle condizioni di possibilità della transizione alla Fase 2, che il Comitato Tecnico Scientifico fornisce al Ministero della Salute e al Governo, composto dal set di 21 indicatori e dai due algoritmi, è molto articolato, apparente non troppo complesso da maneggiare e sembra cogliere un range ampio e abbastanza completo di punti di attenzione per la valutazione dello stato del contagio. La sua struttura rispecchia gli obiettivi di esattezza, coerenza, oggettività e indipendenza dalle interferenze politiche e sociali, per guidare l’azione politica in modo sicuro verso decisioni “scientificamente” corrette.
È chiaro che si tratta di un caso di tentata scientifizzazione della politica:
- le decisioni – se viene usato lo strumento per come è costruito – possono essere appaltate alla “scienza” e non tenere conto di variabili socialmente rilevanti quali, per fare un esempio, le esigenze di continuità del reddito o di socializzazione
- le indicazioni dello strumento sono basate su indicatori molto generali, che non tengono conto della stratificazione di età, di condizioni di salute (fa eccezione il > 50 anni dell’algoritmo della probabilità) e sociali.
- La visione dell’intervento è ristretta alla dimensione di ospedalizzazione e ignora tutti fenomeni e le possibilità di intervento e di azione sul territorio
- La scarsissima condivisione pubblica della strumentazione di osservazione e algoritmica, disponibile solo a prezzo di una ricerca approfondita tra i Decreti e i relativi allegati, denuncia una scarsa propensione della “scienza ufficiale” alla discussione pubblica.
In questo quadro, la “scienza medica ed epidemiologica” apparentemente neutrale ed oggettiva ma, come abbiamo visto, orientata alla semplificazione dei fenomeni, cieca alle sue dimensioni sociali e storicamente focalizzata sull’ospedalizzazione, sembra “catturare e guidare” la politica, portando i decisori ad abdicare al loro ruolo guida.
Tuttavia,
- le debolezze del sistema di misurazione, che lo rendono una cattedrale teoretica nel deserto epistemologico della pandemia del primo semestre 2020, con utilizzabilità estremamente limitata, salvo accontentarsi dei pochi indicatori effettivamente misurabili,
- e la mancata applicazione della regola che avrebbe imposto lo stop alla transizione a causa della valutazione di rischio elevato in caso di non misurabilità degli indicatori
hanno favorito un maggiore grado di libertà e di movimento da parte dei decisori politici.
Il governo italiano e il Presidente del Consiglio Conte hanno, infatti, dimostrato – forse solo nel caso delle riaperture del 4 e 18 maggio 2020 – di riuscire ad essere svincolati[5] dalla scientifizzazione e hanno deciso, di fatto, sulla base di una aperta dialettica tra le istanze morali della salute da un lato e della sopravvivenza economica dall’altro.
Le riaperture “limitate” del DPCM del 26 aprile[6] e il relativo controllo dello stato dei contagi sono state, quindi, il risultato di compromesso tra le istanze normative della medicina e la sintesi tra le due posizioni di stampo decisamente politico del governo e delle opposizioni[7].
NOTE
[1] Ad esempio, la percentuale di casi segnalati con indicata la data di inizio dei sintomi e/o il comune di domicili
[2] Cfr. Analisi Gimbe dei tamponi effettuati dalle Regioni nel periodo 22 aprile – 6 maggio 2020, in Franco Pesaresi, Tamponi: quanti se ne fanno e quanti ne servono, Welforum, Osservatorio Nazionale sulle politiche sociali, 14 maggio 2020
[3] Fonte: Verbale n. 83, 29 maggio 2020, Riunione del Comitato Tecnico Scientifico, Dipartimento della Protezione Civile
[4] la relativa isteresi rispetto al fenomeno, i problemi di distorsione del ricordo dell’insorgenza dei sintomi, la sua dubbia significatività per dare atto della velocità di diffusione o della virulenza di un agente infettivo in contesti di densità di popolazione diversa
[5] Questa conclusione non tiene in considerazione le decisioni del periodo successivo, in particolare quelle relative alle campagne di vaccinazione e al green pass, capitoli molto delicati sul tema della subordinazione della politica alla scienza.
[6] Si veda qui il testo del DCPM 26 aprile 2020
[7] Ne parlo diffusamente nella mia Tesi Magistrale Le scelte morali del governo italiano durante la prima parte della crisi pandemica del 2020.
Gli algoritmi del Covid-19 – Un caso di tecnocrazia?
La gestione della pandemia SARS-CoV-2 è stata, molto probabilmente, un caso emblematico di tecnocrazia, in cui la politica ha abdicato al suo ruolo di decisione per il bene pubblico a favore delle competenze tecnoscientifiche, in particolare mediche ed epidemiologiche, e delle linee di comportamento dettate dal Comitato Tecnico Scientifico istituito dalla Protezione Civile[1] e, spesso, con scarsissima o nessuna trasparenza.
L’algoritmo studiato dal CTS, nell’aprile del 2020, per misurare l’andamento del contagio e valutare se procedere con la fase di riaperture sembra essere un esempio lampante di questa tecnocrazia: è uno strumento complesso e fortemente tecnico, “detta” - di fatto – al governo quali comportamenti tenere e, infine, è rimasto praticamente celato all’interno dei decreti, non ne è stata data alcuna pubblicità né è stato possibile discuterne democraticamente
Proverò, in questo articolo, a far conoscere e ad esaminare criticamente i contenuti di questo algoritmo, e in quello successivo (che sarà pubblicato da Controversie la prossima settimana) a mostrare quale sia stato il suo ruolo e se, in questo caso, la politica abbia effettivamente ceduto la mano alla tecnoscienza. Con, forse, qualche sorpresa.
INQUADRAMENTO STORICO
Siamo alla fine di aprile del 2020, a un mese e mezzo dalla dichiarazione di pandemia di Covid-19[2], la situazione pandemica – datata 26 aprile – nel mondo e in Italia è questa:
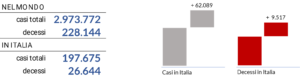
Il picco di contagi[3] è stato registrato da pochi giorni, il 20 aprile, e per la prima volta dall'inizio dell'epidemia, l'Italia registra una diminuzione nel numero degli “attualmente positivi”: 20 in meno del giorno precedente, per un totale di 108.237. Anche i ricoveri e le terapie intensive sono in calo; dalla prima settimana di aprile, infatti, i contagi giornalieri seguono una curva sensibilmente discendente, come si può vedere dal grafico del bollettino di “Aggiornamento nazionale, 28 aprile 2020”[4]
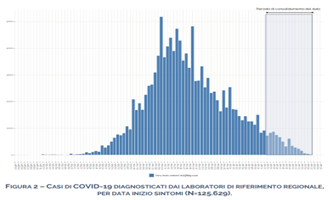 Lo stesso sembra valere – pur con tutte le cautele di attribuzione delle cause – per il numero di decessi. Sono segnali che suggeriscono che le misure contro la diffusione del virus prese dal Governo stiano funzionando, come dice Giuseppe Conte – Presidente del Consiglio dei Ministri del governo giallo-rosso[5] - nella conferenza stampa del 26 aprile: “stiamo riuscendo a contenere la diffusione della pandemia”.[6]
Lo stesso sembra valere – pur con tutte le cautele di attribuzione delle cause – per il numero di decessi. Sono segnali che suggeriscono che le misure contro la diffusione del virus prese dal Governo stiano funzionando, come dice Giuseppe Conte – Presidente del Consiglio dei Ministri del governo giallo-rosso[5] - nella conferenza stampa del 26 aprile: “stiamo riuscendo a contenere la diffusione della pandemia”.[6]
L’interpretazione di questo segnale orienta la prospettiva di attivazione della cosiddetta Fase 2, cioè della progressiva riapertura delle attività produttive, pur mantenendo ancora restrizioni rigorose per evitare una contestuale ripresa della diffusione del contagio.
Il Presidente del Consiglio Conte annuncia[7] che, a partire dal 4 maggio - posto che la curva dei contagi mantenga il trend decrescente – inizierà la Fase 2, caratterizzata, a grandi linee, dalla progressiva riapertura delle attività produttive e commerciali, dall’allentamento di alcune delle restrizioni e dallo sblocco dei cantieri[8].
Che si mantenga il trend decrescente è, quindi, la condizione per procedere con la fase di alleggerimento delle misure di contenimento del contagio.
UN ALGORITMO PER MISURARE L’ANDAMENTO DELLA PANDEMIA
Questa condizione di trend decrescente della curva dei contagi diventa, quindi, oggetto di un problema di misurazione il più possibile oggettiva, sulla base della quale il governo possa prendere delle decisioni, se è possibile passare alla Fase 2, se si può restare in Fase 2 una volta effettuata la transizione, oppure se è il caso di tornare al livello di massimo rigore, quello del lockdown (Fase 1).
Serve uno strumento di valutazione del contagio e delle possibilità di contrastarlo in termini puntuali e di andamento. Ossia momento per momento e potendo confrontare nel tempo dei valori puntuali.
Questo strumento di misurazione è contenuto in parte nell’Allegato 10 al DCPM 26 aprile 2020 “Principi per il monitoraggio del rischio sanitario” e in parte nell’allegato DM3042020 al Decreto 30 aprile 2020 del Ministero della Salute.
Si tratta di 21 indicatori di processo e di risultato, ossia criteri di valutazione puntuale[9] dello stato delle cose con delle soglie di allerta per singolo indicatore o per gruppi di indicatori. Sulla base dei valori degli indicatori sono predisposti inoltre due algoritmi. Il primo restituisce il livello di rischio puntuale, il secondo la Fase più opportuna per quelle condizioni di rischio. Fase da intendersi come il grado di rigore delle misure di contenimento, determinata in modo esplicito e apparentemente deterministico e oggettivo.
Il processo di valutazione prevede, quindi,
- la misurazione di almeno 16 indicatori con frequenza per lo più settimanale
- il confronto con i valori precedenti per comprendere se il trend è favorevole o meno per il passaggio alla fase meno rigorosa
- l’elaborazione di una parte questi andamenti in un primo sub-algoritmo che restituisce la probabilità della minaccia sanitaria, ossia quanto è probabile che si verifichi una «trasmissione non controllata e non gestibile di SARS-CoV-2» e di una altra parte degli andamenti in un secondo sub-algoritmo che restituisce l’impatto, «ovvero la gravità della patologia con particolare attenzione a quella osservata in soggetti con età superiore a 50 anni»
- la combinazione di probabilità (di trasmissione) e di impatto (gravità della diffusione) in una matrice a doppia entrata per determinare il livello di rischio;
- infine, l’elaborazione degli indicatori e degli andamenti nel secondo algoritmo, indica “cosa fare”, ossia se sia possibile passare alla Fase 2[10]
Per comprendere il funzionamento degli algoritmi, è opportuno fare tre approfondimenti: il primo sugli indicatori, il secondo sul senso attribuito dal Ministero della Salute al livello di rischio calcolato con il primo algoritmo e il terzo sul funzionamento dell’algoritmo che determina se sia possibile passare alla Fase 2.
INDICATORI DELL’ANDAMENTO DEL CONTAGIO E DEI PROCESSI DI CONTENIMENTO
Gli indicatori coinvolti nello strumento di misurazione sono raggruppati in tre gruppi, il primo, di 6 indicatori di processo sulla capacità di monitoraggio dei contagi:
- in particolare, della disponibilità delle date di inizio - dei casi sintomatici, dei ricoveri in ospedale e dei trasferimenti in terapia intensiva - e della presenza del dato del comune di residenza
Il secondo gruppo di 6 indicatori di processo sulla capacità di accertamento diagnostico, indagine e gestione dei contatti, che comprende:
- dati quali la percentuale di tamponi positivi (sul totale di tamponi effettuati), i tempi trascorsi tra inizio dei sintomi, diagnosi ed eventuale isolamento;
- e dati che riguardano la consistenza del personale dedicato al tracciamento dei contatti, al monitoraggio dei contatti stretti - idealmente allineati agli standard
raccomandati a livello europeo - e alla percentuale di indagini epidemiologiche sui casi tracciati.
Il terzo gruppo, infine, di 9 indicatori di risultato relativi alla stabilità di trasmissione e alla tenuta dei servizi sanitari che contano – il dettaglio qui sembra essere necessario:
- il numero di casi riportati alla Protezione Civile, alla sorveglianza sentinella COVID-net e alla sorveglianza integrata COVID-19 (per data diagnosi e per data inizio sintomi);
- il numero di nuovi focolai di trasmissione;
- il numero di nuovi casi di infezione per Regione non associati a catene di trasmissione note;
- due indicatori sull’Rt calcolato[11], per data inizio sintomi e per data di ospedalizzazione;
- il numero di accessi al PS con quadri sindromici riconducibili a COVID-19;
- il tasso di occupazione delle Terapie Intensive per pazienti COVID-19;
- il tasso di occupazione dei posti letto totali per pazienti COVID-19.
I primi 12 indicatori dovrebbero misurare quanto l’apparato sanitario è in grado di avere un quadro preciso del contagio, delle diagnosi, della gestione dei contatti; si potrebbero considerare, quindi, dei meta-indicatori della validità della misurazione.
Solo gli ultimi 9, invece, fanno riferimento alla dimensione effettiva del contagio, della trasmissione e della capacità delle strutture locali e regionali di farvi fronte.
SENSO DEL PRIMO ALGORITMO DI VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO
I due sub-algoritmi di determinazione della probabilità e dell’impatto della minaccia di trasmissione incontrollata sono molto semplici e ne riporto di seguito lo schema[12] del Comitato Tecnico Scientifico:
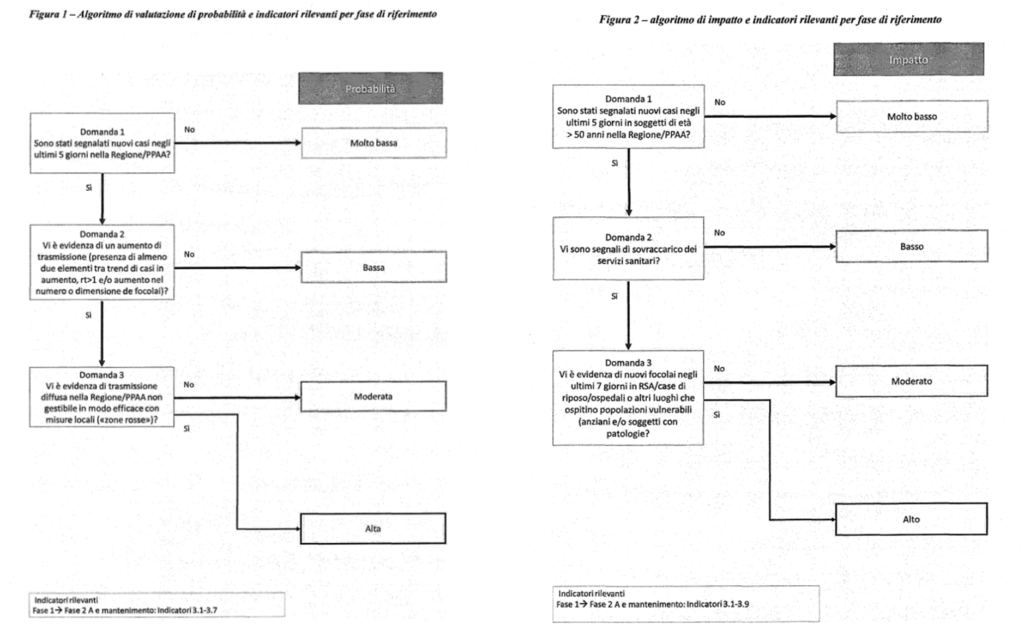
Lo stesso vale per la matrice di determinazione del rischio che combina i livelli di probabilità e di impatto[13]:
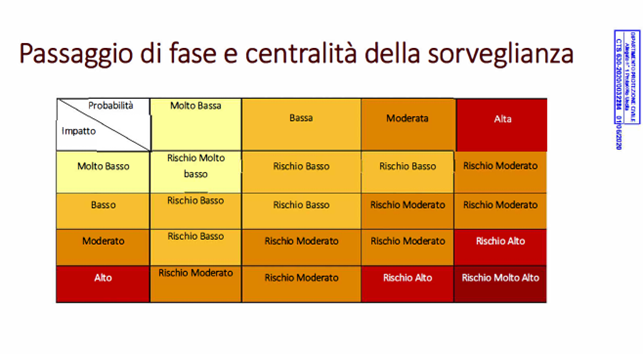 Questa valutazione del rischio non concorre direttamente alla determinazione della possibilità di passare alla Fase 2 (o di restarci, una volta effettuata la transizione) ma ha esclusivamente il senso di sistema di allerta, per attivare la “marcia indietro” dalla Fase 2 verso un inasprimento delle «misure restrittive necessarie e urgenti per le attività produttive» in caso di «rischio alto/molto alto» o di «rischio moderato ma non gestibile con le misure di contenimento in atto».
Questa valutazione del rischio non concorre direttamente alla determinazione della possibilità di passare alla Fase 2 (o di restarci, una volta effettuata la transizione) ma ha esclusivamente il senso di sistema di allerta, per attivare la “marcia indietro” dalla Fase 2 verso un inasprimento delle «misure restrittive necessarie e urgenti per le attività produttive» in caso di «rischio alto/molto alto» o di «rischio moderato ma non gestibile con le misure di contenimento in atto».
In questo quadro funzionale, il Decreto del 30 aprile sottolinea che. se non è possibile misurare gli indicatori alla base dell’algoritmo, la valutazione del livello di rischio va considerata elevata[14].
ALGORITMO DI VALUTAZIONE PER LA TRANSIZIONE ALLA FASE 2
Questo secondo algoritmo – allegato 10 al DCPM del 26 aprile 2020 e definito nel Decreto come strumento per individuare il rischio sanitario[15] – impone, perché sia possibile la transizione alla Fase 2, che:
- siano presenti gli standard minimi di qualità della sorveglianza epidemiologica nella Regione – ossia che almeno per il 50% dei casi segnalati siano disponibili la data di inizio dei sintomi o del ricovero (in terapia intensiva e non) e l’indirizzo di domicilio[16]
- la trasmissione di COVID-19 nella Regione (o zona) sia stabile o in decremento – ossia che gli indicatori del terzo gruppo siano in miglioramento o stabili (il numero di casi segnalati e il numero di focolai di trasmissione siamo in diminuzione, l’ Rt sia ≤ 1)
- siano soddisfatti «gli altri criteri» di valutazione, che comprendono il livello di saturazione delle strutture ospedaliere, standard e di terapia intensiva, la abilità di testare i casi sospetti, la prontezza operativa e la disponibilità di risorse per il tracciamento dei contatti (che possono essere ricondotti al secondo gruppo di indicatori)
Se tutti questi criteri sono soddisfatti, il Decreto dice che è possibile allentare le misure di contenimento dei contagi e iniziare un primo passo di normalizzazione, la Fase 2A (oppure mantenere le condizioni della Fase 2A e attendere più serenamente[17] l’arrivo dei vaccini sicuri e affidabili).
----------------
La transizione avvenne, per mano del Presidente del Consiglio Conte, con decisione di realizzare il piano di riaperture dal 4 maggio 2020 in poi.
Ma, come vedremo nel seguito, forse gli algoritmi di valutazione – vuoi per alcune aree di debolezza e di inconsistenza sia interna che contestuale - ebbero un ruolo meno importante del previsto in questa decisione.
NOTE
[1] «Con Decreto del Capo Dipartimento della Protezione civile n. 371 del 5 febbraio 2020, è stato istituito il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) con competenza di consulenza e supporto alle attività di coordinamento per il superamento dell’emergenza epidemiologica dovuta alla diffusione del Coronavirus. Il Comitato è composto da esperti e qualificati rappresentati degli Enti e Amministrazioni dello Stato.» Ministero della Salute, Portale Covid 19
[2] «Coronavirus disease (COVID-19) is an infectious disease caused by the SARS-CoV-2 virus», OMS, Health topics, Coronavirus disease (COVID-19)
[3] Dati Epicentro-ISS e grafiche da Cose che noi umani, Lab24, 2021 (https://lab24.ilsole24ore.com/storia-coronavirus/)
[4] Epidemia COVID-19 Aggiornamento nazionale, 28 aprile 2020 – ore 16:00, Epidemia COVID-19
Aggiornamento nazionale 28 aprile 2020 – ore 16:00 (https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/bollettino/Bollettino-sorveglianza-integrata-Covid-19_28-aprile-2020.pdf)
[5] Il governo cosiddetto Conte II è sostenuto da una coalizione di forze di centro-sinistra che comprende il Movimento 5 Stelle, il Partito Democratico, Liberi E Uguali (LEU) - lista elettorale nata dall'alleanza tra i partiti Articolo Uno, Sinistra Italiana e Possibile - e Italia Viva, più una serie di piccole entità politiche, sempre di centro-sinistra; Le altre forze che appoggiano il governo Conte II nel primo semestre del 2020 sono: il Movimento Associativo Italiani all'Estero e – in forma di appoggio esterno, il Partito Socialista Italiano, il Südtiroler Volkspartei, l’ Union Valdôtaine, il Partito Autonomista Trentino Tirolese, Centristi per l’Europa, Centro Democratico e Sicilia Futura
[6] Fase due, conferenza stampa del Presidente Conte, YouTube - Palazzo Chigi, Canale ufficiale del Governo italiano (26 aprile 2020, https://www.youtube.com/watch?v=tXxQBLNZZqA)
[7] Il discorso di Conte del 26 aprile ricorda che non si può abbassare la guardia e che l’attenzione alle misure di sicurezza deve essere ancora mantenuta: «evitare il rischio che il contagio si diffonda […] come lo puoi fare? non bisogna mai avvicinarsi, bisogna rispettare distanze in sicurezza almeno un metro, questo è fondamentale e, guardate, anche nelle relazioni familiari con i parenti bisogna stare attenti». Ibidem.
[8] La tematica delle attività produttive è lo snodo della tensione tra governo e opposizioni. Ne ho parlato diffusamente nella mia tesi magistrale.
[9] Puntuale va inteso come: in un determinato momento, tipicamente quello della misurazione
[10] La versione più generale dell’algoritmo contenuta nell’Allegato 10 al DPCM 26 aprile 2020 comprende anche i passaggi alla fase 2B o “Transizione avanzata”, sulla base dei medesimi criteri ma di cui non sono esplicitate le soglie obiettivo, e del passaggio alla Fase 3, di ripristino (si può pensare: delle condizioni di normalità), subordinata all’«accesso diffuso a trattamenti e/o ad un vaccino sicuro ed efficacie». Ma anche questa è un’altra storia.
[11] Numero di riproduzione netto, ossia numero medio di infezioni trasmesse da ogni individuo infetto nel tempo, cfr. R0, Rt: cosa sono, come si calcolano?, Istituto Superiore di Sanità. Sulla consistenza e validità del Rt come strumento di misura della trasmissione ci sono state ampie polemiche, cfr., ad esempio, Wired 5 maggio 2021, Corriere della Sera, 11 maggio 2021
[12] Fonte: Verbale n. 83, 29 maggio 2020, Riunione del Comitato Tecnico Scientifico, Dipartimento della Protezione Civile
[13] Cit.
[14] «Se non sarà possibile una valutazione [degli indicatori, NdA] secondo le modalità descritte, questa costituirà di per sé una valutazione di rischio elevata, in quanto descrittiva di una situazione non valutabile e di conseguenza potenzialmente non controllata e non gestibile», Decreto 30 aprile 2020 del Ministero della Salute
[15]«rischio sanitario, individuato secondo i principi per il monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10», DCPM del 26 aprile 2020
[16] La soglia del 50% vale per le prime tre settimane di maggio 2020; successivamente la soglia sarà innalzata al 60%.
[17] Il valore della “serenità” è uno di quelli che costituiscono la scala assiologica del governo Conte, cfr. Gianluca Fuser, Le scelte morali del governo italiano durante la prima parte della crisi pandemica del 2020, Tesi Magistrale, Scienze Filosofiche, Università degli Studi di Milano, 2024
Legge 13 maggio 1978, n. 180 – Testo integrale
Comunemente, la legge n. 180 viene chiamata “legge Basaglia”; in realtà il suo estensore fu lo psichiatra e politico democristiano Bruno Orsini e Franco Basaglia non ne fu particolarmente soddisfatto – anche se la difese come impianto teorico ed ideologico, come dichiarò in una intervista fatta da Maurizio Costanzo:
«Non è importante tanto il fatto che in futuro ci siano o meno manicomi e cliniche chiuse, è importante che noi adesso abbiamo provato che si può fare diversamente, ora sappiamo che c'è un altro modo di affrontare la questione; anche senza la costrizione.»
La legge n. 180 nacque con un iter frettoloso: il progetto iniziale – che recepiva le istanze e le proposte di Franco Basaglia, del movimento di Psichiatria Democratica e di un numero non indifferente di psichiatri – prevedeva che la precedente legge che regolava il trattamento “dei matti” (Legge 14 febbraio 1904, n. 36 - Disposizioni sui manicomi e sugli alienati. Custodia e cura degli alienati) fosse parzialmente abrogata attraverso un referendum e sostituita nell’ambito della legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale.
Tuttavia, il referendum rappresentava un rischio, perché il tema “dei matti” poteva essere sentito in modo controverso nella società, e la legge sul Sistema Sanitario avrebbe potuto avere tempi più lunghi del previsto. Il governo Andreotti optò, allora, per lo stralcio degli articoli che riguardavano i principali temi correlati ai manicomi e ne fece la legge n. 180, abrogando in buona parte (fatta esclusione per i temi economici e fiscali) la legge del 1904.
La “180” è una legge breve, molto sintetica, densa di contenuti e difficile da mettere in opera, soprattutto negli anni ’70.
Controversie ha ritenuto – per evitare che il dibattito viaggi sull’onda dei soli commenti e opinioni – di riportarla qui integralmente, insieme all’articolo 64 della legge n. 833/1978, istituiva del Sistema Sanitario Nazionale.
Legge 13 maggio 1978, n. 180
Sommario
Art. 1 Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori
Art. 2 Accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori per malattia mentale
Art. 4 Revoca e modifica del provvedimento di trattamento sanitario obbligatorio
Art. 7 Trasferimento alle regioni delle funzioni in materia di assistenza ospedaliera psichiatrica
Art. 8 Infermi già ricoverati negli ospedali psichiatrici
Art. 9 Attribuzioni del personale medico degli ospedali psichiatrici
Art. 10 Modifiche al codice penale
" Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori "
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 1978, n. 133.
Art. 1 Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori.
Gli accertamenti e i trattamenti sanitari sono volontari. Nei casi di cui alla presente legge e in quelli espressamente previsti da leggi dello Stato possono essere disposti dall'autorità sanitaria accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori nel rispetto della dignità della persona e dei diritti civili e politici garantiti dalla Costituzione, compreso per quanto possibile il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura. Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori a carico dello Stato e di enti o istituzioni pubbliche sono attuati dai presidi sanitari pubblici territoriali e, ove necessiti la degenza, nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate. Nel corso del trattamento sanitario obbligatorio chi vi è sottoposto ha diritto di comunicare con chi ritenga opportuno. Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori di cui ai precedenti commi devono essere accompagnati da iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi è obbligato. Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori sono disposti con provvedimento del sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria locale, su proposta motivata di un medico.
Art. 2 Accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori per malattia mentale.
Le misure di cui al secondo comma del precedente articolo possono essere disposte nei confronti delle persone affette da malattie mentali. Nei casi di cui al precedente comma la proposta di trattamento sanitario obbligatorio può prevedere che le cure vengano prestate in condizioni di degenza ospedaliera solo se esistano alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici, se gli stessi non vengano accettati dall'infermo e se non vi siano le condizioni e le circostanze che consentano di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extra ospedaliere. Il provvedimento che dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera deve essere preceduto dalla convalida della proposta di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 da parte di un medico della struttura sanitaria pubblica e deve essere motivato in relazione a quanto previsto nel precedente comma.
Art. 3 Procedimento relativo agli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera per malattia mentale.
Il provvedimento di cui all'articolo 2 con il quale il sindaco dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera, corredato dalla proposta medica motivata di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 e dalla convalida di cui all'ultimo comma dell'articolo 2, deve essere notificato, entro 48 ore dal ricovero, tramite messo comunale, al giudice tutelare nella cui circoscrizione rientra il comune. Il giudice tutelare, entro le successive 48 ore, assunte le informazioni e disposti gli eventuali accertamenti, provvede con decreto motivato a convalidare o non convalidare il provvedimento e ne dà comunicazione al sindaco. In caso di mancata convalida il sindaco dispone la cessazione del trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera. Se il provvedimento di cui al primo comma del presente articolo è disposto dal sindaco di un comune diverso da quello di residenza dell'infermo, ne va data comunicazione al sindaco di questo ultimo comune. Se il provvedimento di cui al primo comma del presente articolo è adottato nei confronti di cittadini stranieri o di apolidi, ne va data comunicazione al Ministero dell'interno e al consolato competente, tramite il prefetto. Nei casi in cui il trattamento sanitario obbligatorio debba protrarsi oltre il settimo giorno, ed in quelli di ulteriore prolungamento, il sanitario responsabile del servizio psichiatrico di cui all'articolo 6 è tenuto a formulare, in tempo utile, una proposta motivata al sindaco che ha disposto il ricovero, il quale ne dà comunicazione al giudice tutelare, con le modalità e per gli adempimenti di cui al primo e secondo comma del presente articolo, indicando la ulteriore durata presumibile del trattamento stesso. Il sanitario di cui al comma precedente è tenuto a comunicare al sindaco, sia in caso di dimissione del ricoverato che in continuità di degenza, la cessazione delle condizioni che richiedono l'obbligo del trattamento sanitario; comunica altresì la eventuale sopravvenuta impossibilità a proseguire il trattamento stesso. Il sindaco, entro 48 ore dal ricevimento della comunicazione del sanitario, ne dà notizia al giudice tutelare. Qualora ne sussista la necessità il giudice tutelare adotta i provvedimenti urgenti che possono occorrere per conservare e per amministrare il patrimonio dell'infermo. La omissione delle comunicazioni di cui al primo, quarto e quinto comma del presente articolo determina la cessazione di ogni effetto del provvedimento e configura, salvo che non sussistano gli estremi di un delitto più grave, il reato di omissione di atti di ufficio.
Art. 4 Revoca e modifica del provvedimento di trattamento sanitario obbligatorio.
Chiunque può rivolgere al sindaco richiesta di revoca o di modifica del provvedimento con il quale è stato disposto o prolungato il trattamento sanitario obbligatorio. Sulla richiesta di revoca o di modifica il sindaco decide entro dieci giorni. I provvedimenti di revoca o di modifica sono adottati con lo stesso procedimento del provvedimento revocato o modificato.
Art. 5 Tutela giurisdizionale.
Chi è sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio, e chiunque vi abbia interesse, può proporre al tribunale competente per territorio ricorso contro il provvedimento convalidato dal giudice tutelare. Entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla scadenza del termine di cui al secondo comma dell'articolo 3, il sindaco può proporre analogo ricorso avverso la mancata convalida del provvedimento che dispone il trattamento sanitario obbligatorio. Nel processo davanti al tribunale le parti possono stare in giudizio senza ministero di difensore e farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce al ricorso o in atto separato. Il ricorso può essere presentato al tribunale mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Il presidente del tribunale fissa l'udienza di comparizione delle parti con decreto in calce al ricorso che, a cura del cancelliere, è notificato alle parti nonché al pubblico ministero. Il presidente del tribunale, acquisito il provvedimento che ha disposto il trattamento sanitario obbligatorio e sentito il pubblico ministero, può sospendere il trattamento medesimo anche prima che sia tenuta l'udienza di comparizione. Sulla richiesta di sospensiva il presidente del tribunale provvede entro dieci giorni. Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, dopo aver assunto informazioni e raccolte le prove disposte di ufficio o richieste dalle parti. I ricorsi ed i successivi procedimenti sono esenti da imposta di bollo. La decisione del processo non è soggetta a registrazione.
Art. 6 Modalità relative agli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera per malattia mentale.
Gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione relativi alle malattie mentali sono attuati di norma dai servizi e presìdi psichiatrici extra ospedalieri. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge i trattamenti sanitari per malattie mentali che comportino la necessità di degenza ospedaliera e che siano a carico dello Stato o di enti e istituzioni pubbliche sono effettuati, salvo quanto disposto dal successivo articolo 8, nei servizi psichiatrici di cui ai successivi commi. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche con riferimento agli ambiti territoriali previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, individuano gli ospedali generali nei quali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, devono essere istituiti specifici servizi psichiatrici di diagnosi e cura. I servizi di cui al secondo e terzo comma del presente articolo - che sono ordinati secondo quanto è previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, per i servizi speciali obbligatori negli ospedali generali e che non devono essere dotati di un numero di posti letto superiore a 15 - al fine di garantire la continuità dell'intervento sanitario a tutela della salute mentale sono organicamente e funzionalmente collegati, in forma dipartimentale con gli altri servizi e presìdi psichiatrici esistenti nel territorio.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano le istituzioni private di ricovero e cura, in possesso dei requisiti prescritti, nelle quali possono essere attuati trattamenti sanitari obbligatori e volontari in regime di ricovero. In relazione alle esigenze assistenziali, le province possono stipulare con le istituzioni di cui al precedente comma convenzioni ai sensi del successivo articolo 7.
Art. 7 Trasferimento alle regioni delle funzioni in materia di assistenza ospedaliera psichiatrica.
A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge le funzioni amministrative concernenti la assistenza psichiatrica in condizioni di degenza ospedaliera, già esercitate dalle province, sono trasferite, per i territori di loro competenza, alle regioni ordinarie e a statuto speciale. Resta ferma l'attuale competenza delle province autonome di Trento e di Bolzano. L'assistenza ospedaliera disciplinata dagli articoli 12 e 13 del decreto-legge 8 luglio 1974, numero 264, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n. 386, comprende i ricoveri ospedalieri per alterazioni psichiche. Restano ferme fino al 31 dicembre 1978 le disposizioni vigenti in ordine alla competenza della spesa. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge le regioni esercitano anche nei confronti degli ospedali psichiatrici le funzioni che svolgono nei confronti degli altri ospedali. Sino alla data di entrata in vigore della riforma sanitaria, e comunque non oltre il 1° gennaio 1979, le province continuano ad esercitare le funzioni amministrative relative alla gestione degli ospedali psichiatrici e ogni altra funzione riguardante i servizi psichiatrici e di igiene mentale. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano programmano e coordinano l'organizzazione dei presìdi e dei servizi psichiatrici e di igiene mentale con le altre strutture sanitarie operanti nel territorio e attuano il graduale superamento degli ospedali psichiatrici e la diversa utilizzazione delle strutture esistenti e di quelle in via di completamento. Tali iniziative non possono comportare maggiori oneri per i bilanci delle amministrazioni provinciali. E' in ogni caso vietato costruire nuovi ospedali psichiatrici, utilizzare quelli attualmente esistenti come divisioni specialistiche psichiatriche di ospedali generali, istituire negli ospedali generali divisioni o sezioni psichiatriche e utilizzare come tali divisioni o sezioni neurologiche o neuropsichiatriche. Agli ospedali psichiatrici dipendenti dalle amministrazioni provinciali o da altri enti pubblici o dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza si applicano i divieti di cui all'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 1978, n. 43. Ai servizi psichiatrici di diagnosi e cura degli ospedali generali, di cui all'articolo 6, è addetto personale degli ospedali psichiatrici e dei servizi e presidi psichiatrici pubblici extra ospedalieri. I rapporti tra le province, gli enti ospedalieri e le altre strutture di ricovero e cura sono regolati da apposite convenzioni, conformi ad uno schema tipo, da approvare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della sanità di intesa con le regioni e l'Unione delle province di Italia e sentite, per quanto riguarda i problemi del personale, le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative. Lo schema tipo di convenzione dovrà disciplinare tra l'altro il collegamento organico e funzionale di cui al quarto comma dell'articolo 6, i rapporti finanziari tra le province e gli istituti di ricovero e l'impiego, anche mediante comando, del personale di cui all'ottavo comma, del presente articolo. Con decorrenza dal 1° gennaio 1979 in sede di rinnovo contrattuale saranno stabilite norme per la graduale omogeneizzazione tra il trattamento economico e gli istituti normativi di carattere economico del personale degli ospedali psichiatrici pubblici e dei presidi e servizi psichiatrici e di igiene mentale pubblici e il trattamento economico e gli istituti normativi di carattere economico delle corrispondenti categorie del personale degli enti ospedalieri.
Art. 8 Infermi già ricoverati negli ospedali psichiatrici.
Le norme di cui alla presente legge si applicano anche agli infermi ricoverati negli ospedali psichiatrici al momento dell'entrata in vigore della legge stessa. Il primario responsabile della divisione, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, con singole relazioni motivate, comunica al sindaco dei rispettivi comuni di residenza, i nominativi dei degenti per i quali ritiene necessario il proseguimento del trattamento sanitario obbligatorio presso la stessa struttura di ricovero, indicando la durata presumibile del trattamento stesso. Il primario responsabile della divisione è altresì tenuto agli adempimenti di cui al quinto comma dell'articolo 3. Il sindaco dispone il provvedimento di trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera secondo le norme di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 e ne dà comunicazione al giudice tutelare con le modalità e per gli adempimenti di cui all'articolo 3. L'omissione delle comunicazioni di cui ai commi precedenti determina la cessazione di ogni effetto del provvedimento e configura, salvo che non sussistano gli estremi di un delitto più grave, il reato di omissione di atti di ufficio. Tenuto conto di quanto previsto al quinto comma dell'articolo 7 e in temporanea deroga a quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 6, negli attuali ospedali psichiatrici possono essere ricoverati, sempre che ne facciano richiesta, esclusivamente coloro che vi sono stati ricoverati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e che necessitano di trattamento psichiatrico in condizioni di degenza ospedaliera.
Art. 9 Attribuzioni del personale medico degli ospedali psichiatrici.
Le attribuzioni in materia sanitaria del direttore, dei primari, degli aiuti e degli assistenti degli ospedali psichiatrici sono quelle stabilite, rispettivamente, dagli articoli 4 e 5 e dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128.
Art. 10 Modifiche al codice penale.
Nella rubrica del libro III, titolo I, capo I, sezione III, paragrafo 6 del codice penale sono soppresse le parole: "di alienati di mente". Nella rubrica dell'articolo 716 del codice penale sono soppresse le parole: "di infermi di mente o".
Nello stesso articolo sono soppresse le parole: "a uno stabilimento di cura o".
Art. 11 Norme finali.
Sono abrogati gli articoli 1, 2, 3 e 3-bis della legge 14 febbraio 1904, n. 36, concernente "Disposizioni sui manicomi e sugli alienati" e successive modificazioni, l'articolo 420 del codice civile, gli articoli 714, 715 e 717 del codice penale, il n. 1 dell'articolo 2 e l'articolo 3 del testo unico delle leggi recanti norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, nonché ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge. Le disposizioni contenute negli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della presente legge restano in vigore fino alla data di entrata in vigore della legge istitutiva del servizio sanitario nazionale. Fino a quando non si provvederà a modificare, coordinare e riunire in un testo unico le disposizioni vigenti in materia di profilassi internazionale e di malattie infettive e diffusive, ivi comprese le vaccinazioni obbligatorie, sono fatte salve in materia di trattamenti sanitari obbligatori le competenze delle autorità militari, dei medici di porto, di aeroporto e di frontiera e dei comandanti di navi o di aeromobili.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Data a Roma, addì 13 maggio 1978
Leone - Andreotti - Bonifacio - Anselmi
Visto, il Guardasigilli: Bonifacio
STRALCIO DELLA LEGGE 833/1978
TITOLO III
Norme transitorie e finali
Art. 64 - Norme transitorie per l'assistenza psichiatrica.
La regione nell'ambito del piano sanitario regionale, disciplina il graduale superamento degli ospedali psichiatrici o neuropsichiatrici e la diversa utilizzazione, correlativamente al loro rendersi disponibili, delle strutture esistenti e di quelle in via di completamento. La regione provvede inoltre a definire il termine entro cui dovrà cessare la temporanea deroga per cui negli ospedali psichiatrici possono essere ricoverati, sempre che ne facciano richiesta, coloro che vi sono stati ricoverati anteriormente al 16 maggio 1978 e che necessitano di trattamento psichiatrico in condizioni di degenza ospedaliera; tale deroga non potrà comunque protrarsi oltre il 31 dicembre 1980 . Entro la stessa data devono improrogabilmente risolversi le convenzioni di enti pubblici con istituti di cura privati che svolgano esclusivamente attività psichiatrica . È in ogni caso vietato costruire nuovi ospedali psichiatrici, utilizzare quelli attualmente esistenti come divisioni specialistiche psichiatriche di ospedali generali, istituire negli ospedali generali divisioni o sezioni psichiatriche e utilizzare come tali divisioni o sezioni psichiatriche o sezioni neurologiche o neuro-psichiatriche. La regione disciplina altresì con riferimento alle norme di cui agli articoli 66 e 68, la destinazione alle unità sanitarie locali dei beni e del personale delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza (IPAB) e degli altri enti pubblici che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge provvedono, per conto o in convenzione con le amministrazioni provinciali, al ricovero ed alla cura degli infermi di mente, nonché la destinazione dei beni e del personale delle amministrazioni provinciali addetto ai presidi e servizi di assistenza psichiatrica e di igiene mentale. Quando tali presidi e servizi interessino più regioni, queste provvedono d'intesa. La regione, a partire dal 1° gennaio 1979, istituisce i servizi psichiatrici di cui all'articolo 35, utilizzando il personale dei servizi psichiatrici pubblici. Nei casi in cui nel territorio provinciale non esistano strutture pubbliche psichiatriche, la regione, nell'ambito del piano sanitario regionale e al fine di costituire i presidi per la tutela della salute mentale nelle unità sanitarie locali, disciplina la destinazione del personale, che ne faccia richiesta, delle strutture psichiatriche private che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge erogano assistenza in regime di convenzione, ed autorizza, ove necessario, l'assunzione per concorso di altro personale indispensabile al funzionamento di tali presidi. Sino all'adozione dei piani sanitari regionali di cui al primo comma i servizi di cui al quinto comma dell'articolo 34 sono ordinati secondo quanto previsto dal D.P.R. 27 marzo 1969, n. 128 , al fine di garantire la continuità dell'intervento sanitario a tutela della salute mentale, e sono dotati di un numero di posti letto non superiore a 15. Sino all'adozione e di provvedimenti delegati di cui all'art. 47 le attribuzioni in materia sanitaria del direttore, dei primari, degli aiuti e degli assistenti degli ospedali psichiatrici sono quelle stabilite, rispettivamente, dagli artt. 4 e 5 e dall'art. 7, D.P.R. 27 marzo 1969, n. 128 . Sino all'adozione dei piani sanitari regionali di cui al primo comma i divieti di cui all'art. 6 del D.L. 8 luglio 1974, n. 264 , convertito, con modificazioni, nella L. 17 agosto 1974, n. 386, sono estesi agli ospedali psichiatrici e neuropsichiatrici dipendenti dalle IPAB o da altri enti pubblici e dalle amministrazioni provinciali. Gli eventuali concorsi continuano ad essere espletati secondo le procedure applicate da ciascun ente prima dell'entrata in vigore della presente legge. Tra gli operatori sanitari di cui alla lettera i) dell'art. 27, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 , sono compresi gli infermieri di cui all'art. 24 del regolamento approvato con R.D. 16 agosto 1909, n. 615 . Fermo restando quanto previsto dalla lettera a) dell'art. 6 della presente legge la regione provvede all'aggiornamento e alla riqualificazione del personale infermieristico, nella previsione del superamento degli ospedali psichiatrici ed in vista delle nuove funzioni di tale personale nel complesso dei servizi per la tutela della salute mentale delle unità sanitarie locali. Restano in vigore le norme di cui all'art. 7, ultimo comma, L. 13 maggio 1978, n. 180
Controcanto - Mario Tobino e la controversia con Basaglia
«I novatori social-psichiatrici».
(Per le antiche scale, 1982, Arnoldo Mondadori Editore)
Così, con questo linguaggio sorpassato e con evidente fastidio, Mario Tobino – psichiatra e scrittore che esercita nei manicomi dal 1939 al 1980 - chiama gli psichiatri che sostengono le proposte di Franco Basaglia e di Psichiatria Democratica.
Tobino rappresenta – di fatto - il controcanto alla rivoluzione basagliana e della Legge n. 180, controcanto che cerchiamo di far emergere analizzando la controversia con Franco Basaglia, che, nel 1978, si sviluppa sui quotidiani La Nazione e Paese Sera.
Alla fine del testo si trovano una Nota Biografica, una Bibliografia e le Note, che permettono di leggere le esatte parole usate da Tobino e da Basaglia.
LA CONTROVERSIA
Tra i due psichiatri, a pochi giorni dalla approvazione della Legge 180, si svolge una discussione pubblica, molto dura, dipanata sulla stampa in tre articoli: Lasciateli in pace, il manicomio è la loro casa, scritto da Tobino e pubblicato il 18 aprile su La Nazione; una intervista di Paese sera a Basaglia, Magliano, le false donne (4 maggio 1978); Dolorosa follia, ho udito la tua voce, di nuovo su La Nazione, 7 maggio.
(Ringraziamo la Fondazione Mario Tobino che ha messo a disposizione - dai propri archivi - le immagini dei tre articoli linkate sopra).
LASCIATELI IN PACE
Lasciateli in pace nasce dai dubbi sulla legge 180 e sulla presumibile difficoltà nel metterla in atto, preoccupazioni condivise con alcuni medici e paramedici di Maggiano. Il contenuto rilevante è nella seconda parte dell’articolo, nel dialogo tra lo psichiatra e l’infermiere Scipioni, in cui si enunciano i principi della carità continua e dell’assistenza amorevole, senza sosta, verso i malati e verso le loro esigenze. Scipioni si fa rappresentante dei timori sulla abolizione degli ospedali psichiatrici, decretata dalla legge in procinto di essere approvata.
La preoccupazione di Scipioni – e di Tobino, che sembra parlare attraverso l’infermiere – è per il destino dei tanti malati. Soprattutto quelli anziani e soli, che hanno vissuto per anni nel manicomio di Lucca e che – una volta dimessi per decreto – non avrebbero un posto dove andare. Per loro non ci sarebbe nessuna famiglia ad accoglierli, sarebbero lasciati all’abbandono e allo scherno, se non alla violenza, del mondo “libero”.
In sostanza, Tobino difende l’istituzione manicomiale come luogo di cura e di protezione per i malati di mente; una casa, per loro che una casa “fuori” non avrebbero più. È l’appello di un medico che ha vissuto tra i matti e per i matti, che adotta un criterio morale con al primo posto la dignità e l’individualità complessa di ogni singolo malato.
UNA RISPOSTA POLITICA
La risposta di Basaglia su Paese sera è durissima, quasi violenta, su un registro completamente diverso da quello di Tobino: egli accusa Tobino di ostacolare il progresso della psichiatria, di puntare sulla dimensione emotiva[1], di essere lui stesso demagogico e sprezzante quando definisce la nuova linea della psichiatria demagogia e moda.
In questa intervista, Basaglia attacca violentemente la psichiatria tradizionale e manicomiale, che ritiene essere al servizio del potere per controllare le persone emarginate, e accusa Tobino di essere al servizio del potere[2] con il suo articolo.
Il suo discorso è di carattere politico: Franco Basaglia sostiene[3] che carità continua e aspetto umano non abbiano alcun significato e che Tobino non affronti il discorso politico che sta dietro al tema della chiusura dei manicomi; egli oppone - alla dignità dell’individuo di cui parla Tobino – la dimensione antropologica molto più ampia, teoretica, della dignità dell’uomo[4]; nega la possibilità di dialogare con le posizioni altre, perché lo ritiene inutile e impossibile[5], nell’ottica di distruggere il potere.
A conclusione dell’intervista, denigra l’avversario per minarne l’autorevolezza, attaccando il romanzo Le libere donne di Magliano[6] che, a suo avviso, contiene solo falsità[7].
L’ULTIMO ATTO, TOBINO RISPONDE SULLO STESSO PIANO
Mario Tobino non può esimersi dal controbattere alle accuse di Basaglia e lo fa 3 giorni dopo, sul quotidiano toscano La Nazione, con l’articolo intitolato Dolorosa follia, ho udito la tua voce.
La controrisposta non è più né aneddotica né di piglio letterario, ma calata nello spazio analitico, teorico e metodologico. [8]
Dopo un breve preambolo di deviazione dei colpi diretti alla sua persona, va diritto ai punti che gli premono: la realtà di manicomi ben diversi dalle prigioni; l’effettiva esistenza della follia [9]; l’inopportunità della chiusura dei manicomi.
In risposta alla ideologizzazione del concetto di manicomio - prigione, Tobino ricorda che le esperienze “liberalizzanti” di Gorizia, di Colorno e di Trieste – dove ha operato Basaglia - non sono le uniche in Italia, ma ne esistono altre, altrettanto “aperte” e innovative; che lo stesso manicomio di Lucca[10] fu tra i primi ad aprirsi; che, a Lucca, i matti sono trattati con attenzione alle singole esigenze, sono liberi e girano tranquillamente, giocano a carte, lavorano allo spaccio, fanno riparazioni, sostituiscono i custodi.
Tobino ricorda - e fa appello alla memoria dello stesso Basaglia – le manifestazioni della follia, i deliri, le urla e le violenze; reali, innegabili, spesso difficilmente controllabili; la follia, secondo Tobino è questa, non la si può dimenticare.
Ed è solo grazie alla nuova chimica, all’alleanza con gli psicofarmaci[11], che si danno questi progressi: senza di essi non sarebbe stato possibile né controllare la follia – pur sopprimendo[12] una parte della personalità dei malati – né aprire i manicomi.
È l’ultimo tema, quello della chiusura dei manicomi[13], su cui Tobino pone l’accento più accorato e pone le domande critiche: dove andranno i malati che da anni vivono nei manicomi e che non hanno un luogo dove andare? Come saranno assistiti sul territorio dove le strutture ipotizzate dalla Legge non esistono, dove i reparti psichiatrici negli ospedali avranno al massimo 15 posti?
Di fatto, Tobino, affronta in modo esplicito la dimensione politica della follia e ne sottolinea l’esistenza puntuale, sociale e contestuale, chiamando in causa la fragilità dei dispositivi della Legge 180, l’impreparazione del tessuto sociale e la necessità di un posto per questi malati, di sapere che c’è un luogo adatto alla follia, seppure mascherata dalla chimica.
UNA ANALISI DELLA CONTROVERSIA
Ci sono elementi, tra quelli che emergono dalla controversia, per i quali si può intravedere una possibilità di conciliazione. È il caso della cancellazione dei trattamenti coercitivi e segreganti dei soggetti psichiatrici e dell’apertura nei confronti della società e della quotidianità, che sembrano essere obiettivi comuni a entrambi gli psichiatri.
Entrambi, inoltre, sembrano essere su una linea simile sulla modalità di gestione dei pazienti non più internati: Basaglia parla di diffusione della cura sul territorio, di somministrazione delle cure vicino a dove stanno i malati, di reinserimento; Tobino ipotizza l’ospedale come luogo di riferimento[14] per il malato; entrambi coinvolgono i pazienti in attività costruttive di laboratorio o di lavoro socialmente utile.
Nel focalizzare i principi, i criteri morali, che stanno alla base di questa etica della psichiatria, si possono trovare alcuni medesimi fondamentali: l’attenzione al malato, la cura e non la repressione, l’occupazione come mezzo per restituire un senso del tempo e dell’utilità sociale, la libertà di scelta sul ricovero e sulla presenza nel luogo di cura, il rapporto con il tessuto sociale.
Invece, sul punto dell’esistenza o meno della follia, non è possibile una composizione della controversia: Tobino, seppure non escluda del tutto l’origine sociale, ha una visione organica, fisiologica della follia, e accusa[15] Basaglia di credere che la chiusura dei manicomi cancelli ogni traccia della follia. Basaglia, infatti, la nega e nello stesso tempo, ne attribuisce la creazione alla società malata, al potere, per rinchiudere i disallineati, i disturbatori dell’ordine e dello sfruttamento[16].
Altro punto di dissidio insanabile è il tema della presenza e della forma delle strutture di cura, che coinvolge anche la visione politica delle due posizioni: Tobino non prescinde dalla necessità di un luogo dove i matti possano trovare – per periodi lunghi o brevi, più o meno volontariamente, in modo comunque aperto – riparo, protezione, cura e tranquillità[17]; e sottolinea l’assenza di preparazione dei territori, della popolazione e delle famiglie per la trasformazione dalle strutture accentrate a quelle diffuse; Basaglia, al contrario, non transige, insiste sulla necessità di distruggere l’istituzione manicomiale[18] e ribadisce la necessità della riforma, da farsi subito, in nome della «crescita politica, e quindi civile e culturale del paese».
VINCITORI
A volte le controversie scientifiche hanno un vincitore (come tra Pasteur e Pouchet[19], a metà del XIX secolo), a volte nessuno, a volte vincitori e vinti, ben oltre i contendenti.
In questo caso, la “vittoria” arride a Basaglia e alle proposte di Psichiatria Democratica[20], che vedono il parlamento prendere atto del lavoro fatto[21] e varare la legge 13 maggio 1978, n. 180.
Oltre che dalla condizione di possibilità fornita dai farmaci, questa vittoria è stata decretata:
- dal fatto che il progetto di riforma della psichiatria è nato e cresciuto nel mezzo degli anni ’70[22], in un contesto con cui condivideva lo stile di pensiero[23], il linguaggio[24] e le forme di espressione;
- dall’abilità degli innovatori nell’arruolare le forze politiche usando – appunto – concetti evocativi irrinunciabili in quegli anni: libertà dalle costrizioni, distruzione delle istituzioni, lotta contro il potere; e evocando la lotta anche contro chi resiste all’innovazione[25].
- dalla leva su elementi motivazionali anch’essi parte integrante della cultura rivoluzionaria di quegli anni, come il senso di colpa della “società”, rea della creazione e dell’espulsione della follia e dei folli[26].
ALTRI VINCITORI E MOLTI PERDENTI
Alla lunga, hanno vinto, dopo 20-30 anni, tutte le persone colpite da problemi psichiatrici – depressione, psicosi, schizofrenia – che hanno guadagnato il diritto a essere curati restando, almeno in parte, all’interno del proprio tessuto sociale (grazie al duro lavoro di chi quella legge[27] ha voluto interpretare e attuare e grazie alla diffusione e alla messa a punto dei farmaci antipsicotici).
Hanno perso, invece, i matti che vivevano dentro ai manicomi, progressivamente espulsi, poiché – scrivono Corbellino e Jervis nel 2008 – l’impossibilità di nuovi ricoveri negli ospedali psichiatrici genera una drammatica situazione di mancata assistenza per i malati critici[28].
Hanno perso anche le famiglie dei ricoverati e dei nuovi malati che, a causa della fretta della rivoluzione e dell’assenza di reali alternative alla struttura psichiatrica, si trovano sulle spalle tutto il carico della gestione, i sacrifici e le tragedie[29].
Hanno perso, più di tutti, alcune centinaia di malati che – dimessi dal manicomio – sono morti per suicidio o accidentalmente, per incapacità di vivere in un mondo ad essi ormai sconosciuto.
Dice lo psichiatra Cherubino Trabucchi[30] che si tratta di duemila – tremila persone.
MARIO TOBINO, NOTA BIOGRAFICA
Mario Tobino nasce a Viareggio nel 1910, si laurea in medicina nel 1936 e prende la specializzazione in clinica delle malattie nervose e mentali nel 1941, con una tesi sulla necessità di una rifondazione umanizzante della psichiatria contemporanea.
Esercita come psichiatra nei manicomi dal 1939 al 1980: ad Ancona, a Gorizia e a Firenze San Salvi (1939-1940), dal 1941 al 1980 nell’ospedale psichiatrico di Maggiano, in provincia di Lucca, dal 1948 come primario del reparto femminile. Nel 1944 partecipa alla guerra partigiana. Vive all’interno del manicomio – nelle stanze dei medici – fino quasi alla morte (1991).
La scrittura contende alla psichiatria il ruolo di principale occupazione. Dalla prima raccolta di poesie del 1934 a Una vacanza romana del 1992, Tobino pubblica 4 raccolte di poesie e 23 romanzi e raccolte di racconti. Di questi, almeno 4 sono incentrati sull’esperienza psichiatrica a Maggiano: Le libere donne di Magliano, Per le antiche scale (Premio Campiello 1972), Gli ultimi giorni di Magliano, Il manicomio di Pechino (Premio Strega 1990).
BIBLIOGRAFIA
M. Tobino, Lasciateli in pace, il manicomio è la loro casa, La Nazione, 18 aprile 1978
F. Basaglia, Magliano: Le false donne, Paese sera, 4 maggio 1978
M. Tobino, Dolorosa follia, ho udito la tua voce, La Nazione, 7 maggio 1978
M. Tobino, Le libere donne di Magliano, Arnoldo Mondadori Editore, 1963
M. Tobino, Per le antiche scale, Arnoldo Mondadori Editore, 1972
M. Tobino, Gli ultimi giorni di Magliano, Arnoldo Mondadori Editore, 1982; Ed. del 2019, Mondadori Libri
M. Tobino, Il manicomio di Pechino, Mondadori, 1990
health, volume 14, 1985, issues 1 and 2, The Unfinished Revolution in Italian Psychiatry: An International Perspective
https://doi.org/10.1080/
G. Corbellino - G. Jervis, La razionalità negata: psichiatria e antipsichiatria in Italia, Bollati-Boringhieri, 2008
F. Basaglia, F. Ongaro, A. Pirella, S. Taverna, La nave che affonda, Cortina, 2008
V. Furlanetto, Cento giorni che non torno – Storie di pazzia, di ribellione e di libertà, Laterza, 2024
V. Andreoli, Fratelli di Carmelo Samonà: il matto in casa, in Il matto di carta. La follia nella letteratura, BUR, 2008
S. Redaelli, Circoscrivere la follia, Mario Tobino, Alda Merini, Carmelo Samonà, Sub Lupa Academic Publishing, Warsaw, 2013
NOTE
[1] Basaglia parla di «equivoca pietà» e di «agire emotivo» (Magliano: Le false donne, Paese sera, 4 maggio 1978)
[2] «il suo scritto rende un grosso servizio al potere, su questo non si può discutere» (Cit.)
[3] «Tobino parla “di carità continua e aspetto umano”. Quale significato hanno oggi queste espressioni? Nessuno. Il discorso è politico e Tobino non lo affronta. Anzi, finge di non affrontarlo poiché tutta l’impostazione del suo articolo è politicizzata al massimo» (Cit.)
[4] «la dignità dell’uomo, di tutti gli uomini» (Cit.)
[5] «instaurare un dialogo comune, generale […] impresa impossibile poiché l’istituzione che vogliamo distruggere è il potere stesso e nessuno rinuncia senza lottare al suo potere» (Cit.)
[6] Romanzo che lo stesso Basaglia, in gioventù, aveva amato e considerato una sorta di trattato psichiatrico (cfr. Magliano: Le false donne, Paese sera, 4 maggio 1978
[7] «a Gorizia […] ho potuto verificare ogni cosa, controllare ogni sensazione. Era tutto falso» (Cit.)
[8] «non ho potuto non sorridere quando ho letto che sarei strumento del dominante potere. Da quasi quarant'anni vivo al manicomio di Lucca e in verità mai sono stato in relazione, a contatto con chi comanda, chi è dominante. Per anni e anni la mia vita si è svolta in compagnia dei malati; adesso la mattina il primo dialogo lo faccio allo spaccio, al loro spaccio, dove vado a prendere il caffè e poi ancora durante la giornata. Nel dopopranzo sono solito passeggiare qui intorno e molto spesso con malati mi accompagno, malati liberi, che se la girano tranquillamente. La sera, dopo cena, quante volte ho giocato con loro a carte e, lo giuro, mai, mai abbiamo insieme trescato col potere, mai ordimmo per difenderlo» (Dolorosa Follia, ho udito la tua voce, La Nazione, 7 maggio 1978)
[9] Come già visto, in tutta la sua produzione Mario Tobino usa in modo diretto i termini follia, malattia mentale, matto/matti, lasciando poco spazio agli eufemismi; da una parte può essere un retaggio del periodo in cui ha studiato ed esercitato, dall’altra possiamo considerarlo un modo per non dimenticare di cosa si parla in termini comuni.
[10] Tobino definisce l’ospedale psichiatrico di Maggiano «libero e umano» e ricorda che «con entusiasmo […] fummo tra i primi a tirare giù i muri di cinta, strappare le inferriate, aprire, dare luce» (M. Tobino, Dolorosa follia, ho udito la tua voce, La Nazione, 7 maggio 1978)
[11] «nel 1952, arrivarono gli psicofarmaci che riescono a velare, a intorpidire, a rendere apparentemente molli molti segni della pazzia» (Cit.);
[12] «Sono stati gli psicofarmaci a rivoluzionare i manicomi e non le loro teste. E nemmeno si domandano se la follia loro la conoscono, se ne saprebbero distinguere il volto, loro che l'hanno frequentata soltanto dopo l'avvento degli psicofarmaci, se ne sanno la violenza, la fantasia, l'orrore, l'inesprimibile immacolatezza, l'impenetrabile lutto. E neppure amano conoscere, per nulla sono ansiosi di valutare di quanto con i composti chimici la follia è stata offuscata, travestita, mascherata (ma non vinta); e a volte costretta a brancolare.
Neppure sorge loro l'inquietante interrogativo, l'as-sillo morale, se è giusto con gli psicofarmaci ottundere la personalità, arginare, imbavagliare, legare una delle più profonde, meravigliose, misteriose manifestazioni umane: la follia.» (Gli ultimi giorni di Magliano, p. 20)
[13] « fuori, come gli andrebbe? I cittadini, che hanno da lavorare, che trascinano i loro affanni, li ascolterebbero, li sopporterebbero? I cittadini debbono essere sensibilizzati ma io finora di questa sensibilizzazione non ho visto nessun progresso, se anche non è aumentato il sospetto» (M. Tobino, Dolorosa follia, ho udito la tua voce, La Nazione, 7 maggio 1978)
[14] «[Un luogo] dove ritornare, rifarsi vedere, venire […] a prendere le cure, […] un luogo dove si entra e si esce tranquillamente» (Cit.)
[15] «io credo che la follia esista e Basaglia invece mi pare che sia convinto che, chiusi i manicomi, svanisca la cupa malinconia, l’architettura della paranoia, le catene delle ossessioni» (Cit.)
[16] «La follia non esiste, non è mai esistita. Sono stati la Società, il Potere a crearla [...] hanno eretto i manicomi per rinchiudere chi disturbava il loro sfruttamento [...]» (F. Basaglia, F. Ongaro, A. Pirella, S. Taverna, La nave che affonda, Cortina, 2008)
[17] Tobino è autore, nel 1958 in tempi non sospetti, insieme a due giovani architetti, di un progetto di «un futuro ospedale psichiatrico, un ospedale per matti in armonia con le vicende dei savi, un istituto che avesse, dopo le sequele di cattiverie, dopo tanto sangue versato, un grano, appena un grano di più di bontà e tolleranza» (Gli ultimi giorni di Magliano, ed. 2019, p. 206); per avere un’idea del progetto: Mappe del progetto per l'Ospedale di Vicenza (Mario Tobino, Giorgio Ramacciotti, Piero Marello) (MTb.II.30.41), Mostre Virtuali Ficlit, #3508
[18] «I manicomi […] noi diciamo che si possono distruggere e lo abbiamo dimostrato in anni di lotta» (F. Basaglia, Magliano: Le false donne, Paese sera, 4 maggio 1978)
[19] Cfr. H.M. Collins, T. Pinch, Il Golem, Tutto quello che dovremmo sapere sulla scienza, Edizioni Dedalo, 1995
[20] https://it.wikipedia.org/wiki/Psichiatria_Democratica, https://www.psichiatriademocratica.org/
[21] «Sono perciò soddisfatto che il Parlamento abbia preso ufficialmente atto della lotta di questi anni» (F. Basaglia, Magliano: Le false donne, Paese sera, 4 maggio 1978)
[22] Cfr. Franco Basaglia e la legge 180: frammenti dello scenario sociale e politico, Controversie, 4 dicembre 2024
[23] Cfr. L. Fleck, Genesi e sviluppo di un fatto scientifico : per una teoria dello stile e del collettivo di pensiero, Il Mulino, 1983; L. Fleck, Stili di pensiero, La conoscenza scientifica come creazione sociale, a cura di F. Coniglione, Mimesis Edizioni, 2019
[24] scrive Tobino: «Si indicono di continuo le riunioni - qualsiasi scusa è buona - alle quali debbono assistere medici, infermieri e anche malati di mente […] Nelle riunioni si rimuginano le prossime salutari innovazioni, ciò che si è in procinto di operare per il trionfo della giustizia, lo smascheramento del Potere, la liberazione degli schiavi, dei martiri», (Gli ultimi giorni di Magliano, p. 19)
[25] «Tutti hanno paura: sanno che il potere, quello politico in primo luogo - quello che in molti casi li ha fatti assumere nell'ospedale -, è con la 180, e con questo i mezzi di comunicazione» (M. Zappella, Introduzione a Gli ultimi giorni di Magliano, ed. 2019)
[26] «La follia non esiste, non è mai esistita. Sono stati la Società, il Potere a crearla [...] hanno eretto i manicomi per rinchiudere chi disturbava il loro sfruttamento [...]» (Paese sera, Cit.)
[27] La legge n. 180 e il suo successivo incoroporamento nella legge istitutiva del Servizio Sanitari Nazionale, Legge 23 dicembre 1978, n. 833.
[28] «La nuova legge rendeva immediatamente illegale ogni nuovo ricovero negli ospedali pubblici […] fattore principale che causò […] una drammatica – e talora tragica – carenza di assistenza per i nuovi pazienti affetti da disturbi mentali acuti e gravi» (G. Corbellino – G. Jervis, La razionalità negata: psichiatria e antipsichiatria in Italia, Bollati-Boringhieri, 2008)
[29] «gran parte del carico fu sostenuto dalle famiglie dei pazienti con grandissimi sacrifici e non poche vere tragedie» (Cit.)
[30] Gli ultimi giorni di Magliano, p. 258
Investire sulla relazione e sugli operatori - Intervista a Raffaella Bricchetti
L: Buongiorno Dott.ssa Bricchetti.
R: Buongiorno a Lei
L: Vorrei iniziare questa nostra chiacchierata chiedendole anzitutto se ci potesse raccontare qualcosa di Lei, di cosa fa. Per poter introdurre meglio i lettori nel vivo dell’intervista
R: Certo. Dunque, chi sono e cosa faccio... Sono laureata in filosofia specializzata in psicologia alla facoltà di Lettere e Filosofia con indirizzo psicologico all’Università Statale di Milano perché ai miei tempi le facoltà di psicologia erano solo a Padova e a Roma e non avendo la possibilità di andare a Padova per mille motivi familiari ho intrapreso questa strada. Laureata mi sono iscritta alla specializzazione e sono stati altri quattro anni. Ricordo tra i miei docenti anche il Dottor Musatti[1]. Nel frattempo, sia per la prima tesi, quella di facoltà, che per la tesi di specializzazione, avevo contattato il dottor Erba[2], che ai tempi lavorava al Paolo Pini (manicomio cittadino per eccellenza ai tempi) come psichiatra.
L: Ecco Dottoressa Bricchietti, può raccontarci per la sua esperienza la realtà manicomiale Italiana prima del 1978? Qual era il vero tessuto quotidiano dell’esperienza d’esser folli e del tentare di curare e lenire?
R: Certamente, come le dicevo ho conosciuto Erba nel ’74 e insieme abbiamo fatto la prima tesi (quella di facoltà) analizzando moltissimi casi di persone che arrivavano in manicomio. Persone con delle storie psichiatriche assolutamente incredibili, “gli alienati”. Persone che non potevano essere considerate soggetti, ma erano considerate semplicemente dei reietti che dovevano essere controllati, sedati, repressi perché creavano scompiglio all’interno della società. Ricordo in manicomio, ad esempio, quest’uomo di nome Luciano che era comunque una persona molto degna, non saprei come altro definirla, sempre vestito bene con camicia e giacca, mai sciatto o trasandato, di una famiglia modesta che dall’età di 15 anni l’aveva mandato in manicomio perché era un “masturbatore compulsivo”. Lui si masturbava sempre, continuamente, anche in manicomio poi lo faceva perché in realtà diciamocelo, cosa diavolo aveva da fare di meglio?! E così lui era lì da sempre.
Ai tempi i manicomi erano dei luoghi di contenimento perché queste persone venivano prese e lì stavano. Mi ricordo anche Angela, che è stata anche uno dei capitoli della mia tesi; quando l'abbiamo presa in considerazione era arrivata al centocinquantesimo ricovero. Lei entrava, stava dentro due giorni, si rifocillava un po' e poi se ne andava. Le porte le venivano riaperte sempre perché era una donna giovane di nessuna pericolosità né per sé né per gli altri... era molto bizzarra quello sì. Mi è capitato di rivederla poi dopo la chiusura del reparto psichiatrico e mi prese in giro dicendomi “ma guarda io ti ho vista che eri grande così!” Ecco, c'erano anche questi personaggi che andavano e venivano in questo reparto molto aperto. Faccia conto che in Italia ai tempi c’erano 98 manicomi con 100mila persone dentro. La cosa che colpì di più Basaglia quando entrò nell’ospedale di Gorizia fu “l’odore di morte e di piscio”, che è vero perché l’odore di morte e di piscio caratterizzava tutto.
Io da bambina mi ero fatta delle fantasie su come fosse un manicomio. Abitavo in un piccolo paese vicino a Brescia e c’erano alcune persone che lavoravano a Canton Mombello che era il manicomio di Brescia. Ai tempi la cosa che mi aveva incuriosito molto era che gli infermieri venivano assunti anche in base alla stazza perché più erano grandi, grossi e potenti più erano in grado di contenere le persone che avrebbero potuto avere delle manifestazioni violente. Questo anche per farvi capire il clima riguardo questi luoghi, le idee che circolavano. A me però questa voce mi aveva sempre incuriosita e quando decisi di fare la prima tesi di laurea sul tema fu perché avevo casualmente letto un articolo su un giornale in cui intervistavano Sergio Erba che aveva introdotto il concetto di “terapia della famiglia all’interno del manicomio”. Ecco questa cosa mi fece scattare ulteriormente la curiosità e gli chiesi di poter assistere e di poter fare la tesi. Mi avvicinai così alla settima divisione del Paolo Pini di Milano dove il Dottor Erba dirigeva un reparto. Quando entrai scoprì che il clima era completamente diverso da quello che avevo immaginato da bambina: ad esempio, il giovedì mattina c’era un’assemblea di reparto dove i pazienti non erano considerati dei numeri ma delle persone, ciò che poi è stato uno dei principi della Legge Basaglia, considerare la persona ricoverata una persona non da sedare o da contenere con fascette ma una persona con la quale parlare. Era faticoso e questa fatica non era tanto dovuta al comportamento dei pazienti, quanto dal personale infermieristico che non era abituato a mettersi in gioco nella relazione con il paziente. Era difficile per loro non intrattenere con i pazienti rapporti che non fossero di forza. Ad un certo punto infatti ci fu proprio una divisione degli infermieri tra chi voleva provare a lavorare in questa maniera e chi no. Così funzionava al piano dove c’era il Dottor Erba, al piano di sotto un altro psichiatra di cui non ricordo il nome procedeva con idee molto ma molto più tradizionaliste...
L: Nel 1978 grazie a Franco Basaglia inizia quindi il percorso verso la riorganizzazione dell’assistenza psichiatrica ospedaliera, ci racconti di questo periodo di transizione...
R: Faccia conto che io sono entrata in questo mondo nel ’74, la Legge 180 è del maggio ’78. Già prima comunque c’era una tendenza ad un approccio diverso alla malattia mentale solamente che era riservata al singolo psichiatra e al reparto dove lavorava, non era una cosa generalizzata e generalizzabile... Qualcosa a livello di chi operava nei contesti manicomiali si stava muovendo ma il livello di establishment diciamo “ufficiale” e politico era ancora orientato nel mantenere il manicomio come luogo di contenimento. È stato molto più difficile a livello istituzionale cambiare qualcosa. Le singole persone erano sicuramente più illuminate ma a livello di istituzioni è stato difficile. Con l’avvento della Legge Basaglia e la chiusura di questi manicomi uno dei temi di base della legge era proprio quella dell’umanizzazione del manicomio.
Basaglia aveva iniziato giovanissimo a Gorizia come direttore e lì aveva avuto grossi problemi. Era finito quindi a Colorno, in provincia di Parma, poi era andato a Trieste, insomma aveva girato vari manicomi sempre con questa idea che voglio esprimere leggendo proprio le sue parole:
“restituire l’individualità e la dignità ai pazienti che dovrebbero essere riconosciuti prima come esseri umani e poi come delle persone da riabilitare. La prima cosa da fare è sospendere ogni forma di giudizio e considerare l’individuo nella sua interezza partendo dalla sua storia, dal ruolo sociale svolto, dalle emozioni e dal malessere, per poi procedere con diagnosi e terapia ma evitando stigmatizzazioni inutili”. Questa legge è stata talmente rivoluzionaria che era arrivata ben prima alle orecchie di tanti psichiatri che non potevano ignorare queste cose. A Milano ad esempio c’era il “Gruppo di Psichiatria Democratica” che era molto attivo (ne facevano parte personaggi come Benedetto Saraceno[3], Leo Nahon[4] etc). I concetti quindi di cui parlava Basaglia li si maneggiava. Cercavamo di andare verso una nuova realtà, il desiderio di umanizzare il manicomio cercando di trasformarlo in quelle che potevano essere delle comunità terapeutiche dove per i pazienti, ad esempio, si iniziavano ad introdurre delle attività per evitare che questi passassero l’intera giornata a letto o in giro per i vialetti del Paolo Pini senza niente da fare se non fumare, fumare, fumare...
Un’altra innovazione di questo momento di transizione era l’idea di ricoverare anche i famigliari del paziente designato. Ricordo questi due ragazzi molto giovani che erano istituzionalizzati al Paolo Pini entrambi con diagnosi di schizofrenia e ad un certo punto venne invitata a rimanere tutta la famiglia, con questa madre molto dominante e un padre che si faceva più piccolino e la seguiva sempre da dietro. Questa donna arrivava sempre alle 9 del mattino con una borsa piena di cibo per i figli, che per altro erano magrissimi e lei riempiva loro la bocca di polpette, questi ragazzi me li ricordo come degli scoiattolini con le guanciotte piene di polpette che tenevano lì. La mattina avevamo un appuntamento fisso e si cercava di lavorare sulle dinamiche che venivano ad instaurarsi, ad un certo punto avevamo lavorato anche sul suo riempire le bocche dei figli. Insomma, esperienze ed esperimenti molto particolari.
La legge Basaglia comunque era molto bella nella teoria ma nella pratica è stata disattesa per molti anni. Addirittura se non ricordo male quelli che erano i precursori degli attuali Cps iniziarono ad aprire negli anni ’90. L’unica cosa rapida fu l’apertura dei reparti di psichiatria negli ospedali civili “normali” chiamiamoli così, come conseguenza immediata della chiusura manicomi.
L: Ma secondo lei quindi che cos’è cambiato veramente dopo che questi posti hanno chiuso?
R: Beh, hanno iniziato a creare i servizi di igiene mentale... A quei tempi Milano era divisa prima in 20 zone, poi 13, etc e una zona che faceva riferimento alla divisione del Paolo Pini era (adesso non si chiama più così) la zona 13 che era attorno all’aeroporto Forlanini (quindi via Mecenate, viale Ungheria etc) dove tutta la via Ungheria aveva un “buon gettito” di pazienti psichiatrici, invece la via Salomone erano tossici e lì cerano prima le case minime, poi le case bianche dove c’era, e forse c’è ancora oggi, una grossa presenza di tossicodipendenti. Quando hanno chiuso il Paolo Pini, hanno aperto in zona un ambulatorio con tre stanzette: una per l’infermeria, una per l’assistente sociale e una dove ruotavamo noi. Ecco lì siamo stati parecchi anni, nella stessa palazzina misero il consultorio e il fatto che ci fosse questa commistione tra matti e tossici (perché ai tempi ancora non avevano creato i servizi per la tossicodipendenza) non piaceva.
E nel concreto cosa succedeva, succedeva che c’erano appunto tutti questi tentativi di creazione di comunità terapeutiche, ambulatori zonali dove affluivano i pazienti psichiatrici mandati dai medici o che venivano ricoverati 10/15 giorni nei reparti di psichiatria e poi una volta dimessi passavano direttamente al territorio mandati con tanto di foglio di via in queste strutture per prendere contatti con il personale. Molti assumevano farmaci, per cui venivano a prenderli e a questo punto non ci si limitava a dare solamente il farmaco al paziente ma si cercava di parlare con lui, di vedere che cos’era successo nel frattempo, che cosa l’aveva portato in ospedale. Sempre in quell’ottica di umanizzazione e di rispetto della persona, di rendere la persona soggetto della propria potenziale -non tanto guarigione- quanto consapevolezza che il disagio che lui stava vivendo poteva essere affrontato diversamente e non solo con il farmaco. Ad esempio, se veniva una signora depressa si cercava di instaurare un approccio relazionale sia con lei, persona che arrivava portando una sofferenza, che con la famiglia.
L: Come prendevano i pazienti, a livello di cambiamento di approccio e non solo di cambiamento strutturale, l’esser trattati così diversamente, in questa maniera appunto relazionale?
R: Non era facile, non era facile. Però questo era ciò che ritenevamo l’approccio migliore cioè di “responsabilizzazione del paziente”. Il paziente non è oggetto di cura ma è soggetto. Il lavoro era quello di fare in modo che la persona si rendesse conto di essere portatore di una domanda e portatore di un possibile dimensionamento del suo star male. Solo lui poteva in qualche modo fare qualcosa per uscire da quella situazione. Noi, nella nostra posizione di curanti, potevamo “aiutarlo a”.
L: Lei prima diceva che però i manicomi erano dei luoghi per i pazienti di contenimento sì, ma in qualche modo luoghi in cui le persone che li abitavano ci avevano passato tutta la vita per poi ritrovarsi a dire “cosa faccio/dove vado”?
R: Assolutamente! Persone smarrite... Se vi ricordate Luciano di cui vi parlavo prima, quando hanno chiuso i manicomi lui si era trovato veramente perso perché dentro almeno era in una situazione molto protetta. Chiuso il manicomio lui è stato sbattuto fuori ma la famiglia non lo voleva, non sapevano dove cacciarlo e onestamente non mi pare siano riusciti a trovargli una sorta di comunità dove farlo stare... Mi pare di ricordare che non abbia vissuto a lungo fuori. Questo per dire che non è che ai tempi ci fossero i matti attaccati al cancello che urlavano “noi vogliamo uscire”, perché quello paradossalmente era un ambiente molto protetto dove le persone magari erano lì da sempre. Come dicevo anche per Angela; lei arrivava lì, mangiava un po’ perché magari passava qualche giorno in giro per Milano senza mangiare, e se ne andava. Era anche una Milano degli anni ’70 in cui la realtà fuori non è come quella di adesso. Io ai tempi ho visto solo un signore di colore nell’arco di tutta la mia esperienza, che era stato ricoverato perché aveva dato un po’ fuori di matto ma rimesso un attimo in sesto se ne era andato ed aveva continuato a fare quel che faceva, lavorare etc. Adesso credo che nelle odierne comunità terapeutiche ci siano molti più immigrati, piazzati ovunque senza esserci tante altre strutture per poterli ospitare...
L: Quindi lei crede che quello un tempo fosse un po’ un rifugio per gli emarginati sociali di allora...
R: Sicuramente... un’alternativa era il dormitorio di Viale Ortles. Perché una volta “liberati” dai manicomi questi soggetti non sapevano dove andare e andavano nei dormitori. Avevo avuto dei contatti con il direttore del dormitorio di viale Ortles anche per capire come cercare di fare questi passaggi perché non è che nei dormitori le persone poi potessero vivere: andavano là per dormire, stavano fino alla mattina alle 6, facevano la colazione ma poi dovevano andare fuori. Non c’era più quindi un luogo dove queste persone potevano stare 24 ore su 24. Il concetto di fondo però era quello del rispetto della persona, perché prima non era assolutamente così. Persona in quanto portatrice di un disagio, e quindi, nella sua storia come è nato, come si è evoluto questo disagio? Quindi, parlare e lavorare con queste persone.
L: Come prendeva l’opinione pubblica questo cambio di approccio in termini più relazionali di cui parlavamo poco prima?
R: L’opinione pubblica era arrabbiata! Comunque c’era ancora e credo ci sia tutt’ora una fetta più tradizionalista e in questo senso anche più assistenzialista, e le persone stesse arrivano da te con un’ottica di assistenzialismo. Riuscire a far cambiare alle persone questa ottica e renderli partecipi della terapeuticità della loro relazione non era facile. Persone che non ci stava anche ad assumersi la propria parte di responsabilità, volevano solo il farmaco e allora “va bene ti do il farmaco, però te lo do a modo mio”. Quando ad esempio venivano per fare le iniezioni depot[5] dei farmaci anti depressivi, questi nuovi infermieri erano capaci sì di fare l’iniezione ma anche di parlare con la persona, di cercare di sensibilizzarle in questo senso. Le famiglie spesso erano poco disposte a starci perché venivano messe in discussione, veniva messo in discussione il loro modo di relazionarsi con quello che doveva essere il paziente designato e magari le famiglie non avevano nessuna voglia di mettersi in gioco, era più comodo dire “lui è matto, è lui quello strambo, gli dia la medicina e a posto così”.
L: In Italia invece a livello di humus culturale, le persone erano spaventate da questo cambiamento?
R: Direi di no. Ma nemmeno gli importava così tanto anche perché le persone direttamente interessate non erano chissà quante e quindi si lavorava su quei numeri piccoli.
L: Siamo alla domanda finale, secondo lei, ad oggi c’è qualche aspetto che avrebbe bisogno di una nuova rivoluzione in ambito di salute mentale?
R: Sì. Ancora oggi fa molto più comodo somministrare quattro pillole piuttosto che tenere il paziente lì, una volta alla settimana, a parlare del suo male. Le cose sono cambiate ma fino ad un certo punto. Finché ho lavorato in consultorio sono sempre stata poco “ossequiosa” rispetto a quello che l’istituzione mi diceva di fare, ad esempio il pacchetto da dieci colloqui: io faccio i colloqui che mi servono, se il paziente ne vuole fare venti ne farà venti, se ne vuole fare cinque ne farà cinque ma lavoriamo insieme in quei venti o cinque che siano. Ho seguito ad esempio più pazienti per anni in consultorio, mandando su tutte le furie i responsabili. Adesso bisogna anche registrare tutte le prestazioni, c’è una sorta di controllo non tanto sui pazienti ma su noi operatori, ora. Per l’istituzione se tu fai più del tuo pacchetto standardizzato da dieci sedute con un paziente vuol dire che stai togliendo la possibilità ad un altro di utilizzarti e quindi tu devi fare dieci colloqui, punto. Finiti i dieci colloqui la persona che hai davanti speri si sia rimpannuncciata un po’ e se non si è rimpannuncciata pazienza e avanti il prossimo. Ora si cerca di lavorare sui comportamenti, così che la persona qualcosa modificherà, starà meno male in dieci appuntamenti e quindi vai, può arrivarne un altro che ha bisogno. Io questo non lo farò mai, faccio quello che ho imparato, lavorare con la relazione e quindi ho fatto così anche in consultorio.
L: Quindi se ci fosse una rivoluzione da fare ad oggi sarebbe quella di investire veramente sulla relazione?
R: Sì e anche di investire sugli operatori. Dare all’operatore la possibilità di lavorare un po’ più tranquillo rispetto alla registrazione della prestazione ad esempio. Io credo che questo approccio al disagio mentale ed emotivo non può passare attraverso una schematicità. Si sta tornando molto indietro ahimè...
***
Dovendo scrivere di Basaglia, dei suoi anni e di ciò che hanno rappresentato per la psichiatria italiana le sue intuizioni, ho pensato che potesse essere molto interessante parlarne con una persona che quegli anni li ha vissuti, permettendoci di rivivere la storia da un punto di vista privilegiato e originale in quanto legato al vissuto reale dei pazienti più ancora che alla teoria accademica.
Per chi scrive, giovane psicologa, alla luce di questa preziosa chiacchierata resta una sensazione di perdita. La sensazione è che oggi questo fermento di idee con al centro il benessere dei pazienti sia carente e si stia scivolando verso una standardizzazione di metodologie e un rigore operativo che lasciano poco spazio alla relazione.
Il sistema ha già riassorbito anche Basaglia e le idee di tutti i “rivoluzionari” di quegli anni?
NOTA BIOGRAFICA
Raffaella Bricchetti. Psicoterapeuta individuale e di coppia, laureata in Filosofia con indirizzo Psicologico e specializzata in Psicologia con indirizzo Sociale nel 1984, presso l’Università degli Studi di Milano. Dal 1974 collabora con la Scuola di Formazione Il Ruolo Terapeutico come docente clinica e teorica. Inoltre è redattrice della rivista “I Quaderni del Ruolo Terapeutico”.
NOTE
[1] Cesare Luigi Eugenio Musatti (Dolo, 21 settembre 1897 – Milano, 21 marzo 1989) è stato uno psicologo, psicoanalista, filosofo e politico italiano, tra i primi che posero le basi della psicoanalisi in Italia
[2] Sergio Erba psichiatria con formazione psicoanalitica. Dagli anni '60 sino all'85 ha lavorato per il servizio pubblico nella Clinica psichiatrica dell'Università di Milano, nell'Ospedale Psichiatrico P. Pini e al Centro psicosociale di zona 13. Fondatore della scuola "Il Ruolo Terapeutico" di Milano e dell’omonima rivista
[3] Benedetto Saraceno, Psichiatra ed esperto di sanità pubblica, ha lavorato a Trieste sotto la direzione di Franco Basaglia e a Milano come responsabile della Comunità per pazienti psicotici gravi prevista dalla legge Basaglia. Direttore del Laboratorio di epidemiologia e psichiatria sociale presso l’Istituto Mario Negri. È stato uno dei leader del movimento di Psichiatria antistituzionale e ha lavorato per molti anni in America latina, dove ha promosso modelli comunitari di assistenza psichiatrica ispirati alla difesa dei diritti umani dei pazienti. Dal 1999 al 2010 ha diretto il Dipartimento di salute mentale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità a Ginevra
[4] Leo Nahon, Psichiatra, è stato assistente di Franco Basaglia all’ospedale di Trieste. È stato poi Primario dei Servizi Psichiatrici di Vimercate e Carate e poi Direttore della Struttura Complessa di Psichiatria dell’Ospedale Niguarda a Milano.
[5] Letteralmente deriva dalla lingua francese e significa deposito. In medicina viene riferito a particolari formulazioni di farmaci che consentono l’accumulo nei tessuti ed il graduale rilascio nel tempo della sostanza terapeutica somministrata. Il farmaco quindi è disciolto in particolari veicoli oleosi che ne consentono lo stoccaggio nel tessuto muscolare (tramite iniezione intramuscolare profonda) o nelle mucose (mediante ovuli)