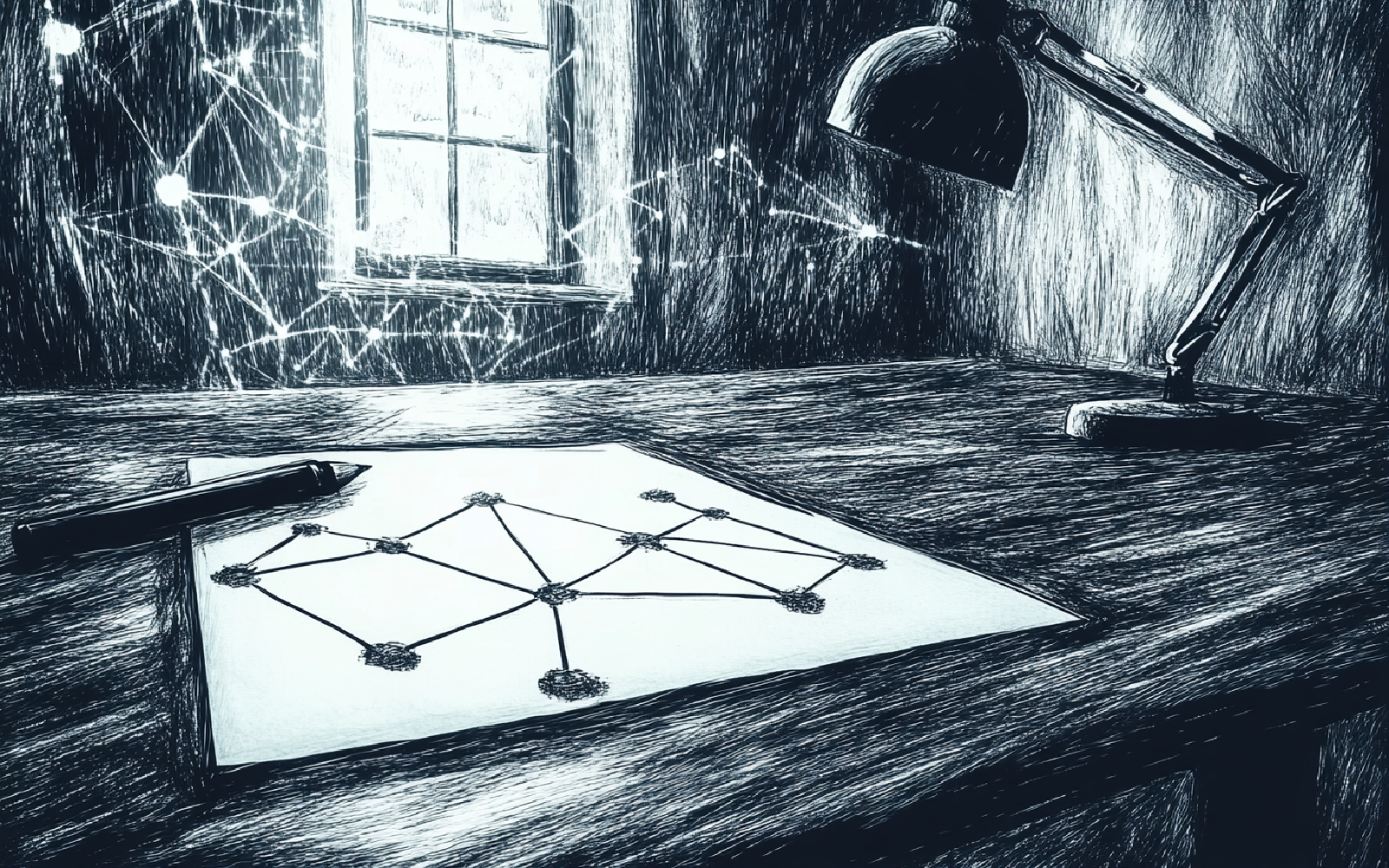Rete psichiatrica sul territorio - Intervista a uno psichiatra che attuò la legge 180
Nell'ottica di raccontare la legge 180, descritta in altri articoli di questi speciale di Controversie, decido di cercare di farmi raccontare le pratiche di chi ha lavorato nel contesto sociale successivo alla promulgazione della legge. Così incontro Antonio Iraci, medico psichiatra. Mi invita gentilmente a casa sua una sera e fin dalle prime chiacchiere, i convenevoli, ci inoltriamo nel suo lavoro dei primi anni '90 nelle comunità della provincia di Como...
Antonio Iraci: A inizio anni ‘90 lavoravo per l’Unità Operativa di Psichiatria di Menaggio. Avevo l’area di Porlezza che all’epoca coincideva con tre vallate del profondo Nord: la Val Rezzo, la Val Cavargna e la Val Solda.
Ricordo queste case con un’unica stanza, la parte nera per il fumo del camino, un letto, un tavolo e le imprecazioni di chi vi abitava. Si andava anche solo per fare un’iniezione di farmaco depot, per garantire la continuità delle cure.
Racconto sempre di una paziente che si chiamava Nini. Le volevo molto bene e lei ne voleva a me. Non sempre il medico vuole bene al paziente! La Nini diceva di essere la moglie del sindaco dimessosi, ma che lei non si era affatto dimessa! La Nini manteneva il suo ruolo sociale interessandosi a tutto ciò che poteva essere di nocumento ai suoi concittadini. Faceva proclami per il paese e andava in chiesa a seguire ogni messa per poi salire sul pulpito alla fine dichiarando: “Adess parli mi”.
La Nini in una metropoli sarebbe stata rinchiusa. Lì, in effetti, si è riusciti a fare un grosso lavoro. In una riunione col sindaco e col prete spiegai loro che se le avessi dato un antipsicotico si sarebbe buttata dal balcone (era già successo): a volte i sintomi sono meccanismi di difesa e se io non sono più nessuno allora non ha senso vivere e mi butto.
Allora montammo una bacheca all’ingresso del paese dove lei poteva mettere tutti i suoi proclami. Aderì tutta la comunità e questo è l’esempio di un caso gestito tenendo conto di tutte le problematiche del momento. Dovevamo gestirla in termini sociali e ce l’abbiamo fatta. Perché quando i pazienti non sono più rinchiusi e rintanati in una struttura allora devi costruire processi di integrazione del paese.
Jacopo Gibertini: Raccontami per favore come arrivi a questo. Il tuo rapporto con l’antipsichiatria e la legge Basaglia.
AI: La comprensione di tutto parte, per me, verso la fine degli anni ‘70 dove mi arriva fra le mani un libro, che leggo, che si chiama L’io diviso di Laing (edizioni Einaudi, ancora oggi). Avevo 25/26 anni, stavo studiando medicina. Vado a capire chi è Laing, insieme a David Cooper mi intrigano. Erano parte di quella gente che veniva considerata l’antipsichiatria. Non quella di oggi che sono dei beceri ignoranti. Allora l’antipsichiatria era la base di quella che sarebbe diventata la psichiatria sociale.
Cosa diceva l'antipsichiatria? Che i folli non sono dentro al manicomio, ma fuori perché per aderire alle regole di questo modello sociale bisogna essere matti. Che è una posizione estrema, ma come tale riesce a farti vedere le cose in una certa nuova maniera.
Nel ‘78 poi viene approvata la legge 180. Legge Orsini, Basaglia ne fu il consulente. Allora c’era anche questa possibilità d’illuminazione da parte dei democristiani. Uno dei temi fondamentali della legge 180 era la decriminalizzazione del paziente psichiatrico. Banalmente si escluse dal TSO il criterio di pericolosità sociale, riducendolo a criteri esclusivamente clinici.
E questa mi è sembrato un elemento di civiltà, di grande civiltà. I manicomi poi resteranno aperti per altri 20 anni circa, nel ‘98 si arriva alla chiusura completa. Durante questo periodo, a esempio, a Como avvenne ancora qualche ricovero.
JG: A Como quindi c’era ancora la struttura e funzionante?
AI: Io entro nel servizio pubblico nel 1990. Il manicomio era ancora aperto e buona parte dei miei colleghi più anziani venivano dall’esperienza manicomiale. Così anche gli infermieri psichiatrici che dovevano essere forti fisicamente per poter gestire certe situazioni. Qualcuno di questi poi non aveva un grande afflato empatico e capitava che alcune zone del manicomio diventassero pericolose la sera. Per gli infermieri!
Declinare la legge 180 era un bel casino. Questi medici erano tutte persone di grande esperienza, come dicevano loro. Tu arrivavi ideologizzato, coi tuoi capelli lunghi e ti mandavano a cagare in tempo zero. Non ero da solo, ma abbiamo dovuto unirci e studiare. Capire, comprendere cosa volesse dire servizio territoriale.
Noi abbiamo voluto dare al servizio territoriale una logica di presa in carico totale del paziente. Tu sei sul territorio e lui avrà te come riferimento sempre e comunque, per qualsiasi cosa. Se il paziente necessità una visita, lo aiuti fino a prenotargliela tu. Così come si andava per le valli per le iniezioni quando stavo nel CPS di Menaggio. E territorio non è l’ambulatorio. Basaglia diceva che bisogna far entrare in qualche modo la città nel manicomio. Per questo mi piace raccontare l’esempio della Nini.
Abbiamo anche fondato una delle prime comunità della zona, a Montemezzo, nel 1991. Durante la costruzione della casa andavo a prendere 6/7 pazienti con un furgone che aveva ancora il clacson a pedale. Li portavo a Montemezzo durante la costruzione della casa. La logica era quella di una cooperativa orto-floreale, produzione in proprio e altre attività che oggi consociamo perché si sono diffuse. Si trattava di un luogo dove le persone potevano convivere condividendo un quotidiano supportato. Abbiamo anche scritto articoli e fatto un convegno su questo.
JG: Mi piace il fatto che avete dovuto studiare. C’era una teoria e un modo diverso di spiegare la psichiatria a cui avevate accesso, eravate ideologizzati come hai detto tu. Però era una teoria del fare psichiatria irriducibilmente legata alle persone e al territorio. Come lo applichi allora?
AI: L’aspetto di vivacità di quell’epoca è che ognuno diceva “qual è il senso del CPS? (Centro Psico Sociale)”, “qual è il senso di una comunità?”. Dovevamo costruire senso su queste cose. Il reparto psichiatrico - il Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura (SPDC) - aveva una sola funzione. Ci ricoveri una persona, fai i colloqui per arrivare a una diagnosi, imposti la terapia e rinvii la persona al servizio territoriale per la continuità delle cure. Lo SPDC poteva e può essere una stazione del percorso terapeutico. La sua funzione è che la persona recuperi delle competenze dopo la fase acuta e di scompenso.
Poi però devi avere una lettura del servizio psichiatrico come rete. In questa rete ci sono dei nodi che sono l’ambulatorio, l’attività domiciliare sul territorio, il CRA (Comunità Riabilitativa ad Alta Assistenza) e le comunità dove fare percorsi più lunghi di risocializzazione. Ognuna di queste realtà doveva produrre un pensiero. Partecipare alla costruzione di una cultura di riferimento che era il modello complessivo. E l’area del territorio era il fulcro della progettualità. Il progetto lo costruivi sulla base di ogni paziente che incontravi, delle sue esigenze, dei suoi bisogni, delle sue criticità e pensando alle strutture a disposizione del territorio.
Nel 1993 entro in reparto a Menaggio. Avevo passato 6 mesi lì in precedenza e mi era piaciuto perché vedevo che si potevano fare delle cose. Al tempo il reparto era gestito da un anziano che aveva una buona filosofia, ma trovavo che l’applicazione fosse carente. Quando lui se n’è andato dopo un anno, il sostituto non c’era e il primario di allora propose a me di prendere la direzione. Io ho detto “sì, se posso fare”. Lui era un illuminato e - a patto che gli parlassi dei miei progetti - mi ha lasciato fare.
Ho recuperato un gruppo di giovani infermieri senza esperienze e abbiamo iniziato a fare riunioni e formazione tra di noi. “Vediamo qual è il modo migliore per poter lavorare qui dentro” ci siamo detti, sulla base delle fantasie che avevamo e del lavoro che volevamo fare. È molto identitaria come cosa. Nel senso che concerne l’identità che ognuno di noi esprime facendo riferimento a sé e al mondo. Come voglio pensarmi lì dentro, come voglio che quel posto venga pensato. Tutti i nodi contribuivano, mi sono venuti dietro in modo esplosivo. Tutti avevano voce in capitolo.
Un giorno ho chiesto al primario illuminato di coinvolgere i familiari. Io stavo facendo la scuola sistemica di terapia della famiglia che prevede un setting di colloquio specifico: lo specchio unidirezionale. In questo modo hai due setting, quello della conduzione del colloquio e quello degli operatori che osservano. Io facevo i colloqui con i pazienti e dietro lo specchio gli infermieri e i familiari si formavano. Registravamo tutto con il loro consenso e quello del paziente e poi lavoravamo tutti insieme su quel materiale. Più teste sono meglio di una si diceva, abbiamo fatto dei lavori bellissimi.
Per avere lo specchio poi avevo avuto qualche difficoltà perché nessuno veniva inviato a costruire la stanza. Così un giorno, con il primario, ci siamo messi a tirare giù la parete! A quel punto l’ospedale ha mandato delle persone a fare il lavoro e abbiamo iniziato.
JG: E i parenti si prestavano volentieri a questo lavoro?
AI: Assolutamente. Eravamo diventati attrattivi, arrivavano pazienti anche da fuori provincia e ci mandavano i casi più impestati. E a noi piaceva perché cercavamo di capire come, in effetti, stessero funzionando le cose lì, in quella persona e in quel contesto familiare.
Noi puntavamo sempre a ridurre il più possibile l’istituzione, a dare un grande supporto ai familiari tirando fuori la persona dal reparto il prima possibile. Il reparto non è che un momento di sgancio in cui ci sistemiamo. Non ha senso se stai bene dentro il reparto. Devi star bene fuori dove c’è il casino. Ci arrivavano tutte le forme di psicosi e dovevi cercare di far sì che il paziente tornasse almeno a galleggiare nel migliore modo possibile, ma nella sua vita quotidiana.
Ti racconto un caso emblematico del lavoro fatto. Arrivano due genitori che avevano ricoverato la propria figlia per mesi in una clinica privata in Svizzera. Volevano valutare come fosse il reparto di Menaggio perché ormai raschiavano il fondo. Menaggio era bellissimo: luminoso, senza il tipico puzzo dolciastro da psichiatria, avevamo camere con vista lago! Se tu sei in un posto dignitoso stai dando dignità alle persone. Avevo anche scritto un articolo, Le mura terapeutiche…
Bene, questa paziente aveva un disturbo ossessivo compulsivo gravissimo. Il suo problema era che qualunque tipo di movimento lei facesse lasciava indietro pezzi di sé. Quindi lei doveva tornare indietro a riprenderli, rifacendo lo stesso movimento, più e più volte.
Abbiamo iniziato a lavorare con l’accordo dei genitori. Anche insieme a loro abbiamo parlato moltissimo con lei cercando di comprenderla. Abbiamo valutato una terapia, modificandola e sistemandola mano mano.
In un mese è passata da non muoversi dal letto – la sua isola – a muoversi e infine tornare a casa con un piano terapeutico e un progetto di psicoterapia, che in quel caso segui direttamente io. Dopo 5 mesi giocava a tennis! Successone! Certo, lei donna intelligente e laureata ha abbassato le sue aspettative professionali. Però si è impegnata, ha fatto del suo meglio riuscendo a vivere una vita più serena.
JG: Un’opinione diffusa e contraria alla legge 180 è quella per cui si è scaricato tutto sulle famiglie. Pensi che questo sia differente dove l’istituzione si adopera verso le famiglie? Non le lascia sole?
AI: Certo, dove questo succede. Sono stato anche responsabile del Servizio territoriale di Como dal 2005. Quando sono arrivato lì ho scoperto che l’ovvio è rivoluzionario.
Ricordo la Presidente dell’associazione delle famiglie dei pazienti psichiatrici arrivare da me entrando adagio con il cappello in mano dicendo “noi siamo i parenti e noi siamo i colpevoli del resto, perché abbiamo prodotto noi il paziente psichiatrico”. Io ho detto “no, voi adesso vi sedete e parliamo perché io ho bisogno di voi!”, “dobbiamo costruire progetti insieme”. Era un contesto che si dimostrava arretrato culturalmente perché abituato al modello ospedaliero, manicomiale.
Dico così ma ho lavorato molti anni in ospedale. Sempre però rimanendo nell’ottica della rete. Io ero un nodo della rete e ogni nodo deve funzionare come si deve. Se anche solo vuoi dare una terapia devi spiegare bene al paziente cosa sta prendendo e perché, devi prenderti il tempo e sapere che ha capito. Come dicono gli analisti con il farmaco si assume anche il medico. E se il medico è un oggetto buono, io assumo un oggetto buono. La famiglia è parte fondamentale di tutto questo, della rete.
JG: In questo rapporto tra istituzione e famiglia mi viene in mente una cosa che ho sentito spesso, cioè che nonostante – anzi contro – Basaglia ci fosse una fetta importante dell’accademia, conservatrice…
AI: La scuola milanese non ha mai amato il modello territoriale. Anche perché nel modello territoriale hai meno potere. Se stai nell’ospedale mantieni potenti i reparti di pischiatria. Era, secondo me, una politica della scuola di Milano quella di favorire il reparto tralasciando il territorio.
Del resto se andavi a Trieste, a Udine o Arezzo trovavi reparti con numeri ridotti di posti letto. A Trieste poi facevano persino la gestione della fase acuta a domicilio. Loro grazie al fatto che lì c’era stato Basaglia riuscivano a fare tutto.
Tu non ti relazioni solo con il paziente. Hai un rapporto con le istituzioni, con i colleghi, con le famiglie e con le città. Se non leggi questa complessità rischi di fare un lavoro come stanno facendo in questo momento.
Nell’anno 2000 eravamo 35 psichiatri in tutta la provincia di Como. Oggi ce ne sono 9 forse 10. È stato chiuso il reparto di Menaggio (nel 2022), stanno chiudendo quello di Cantù. Como avrà 28 posti letto. Pensare ad Arezzo che ne ha 8, Trieste che ne ha una decina ti dice quale livello di arretramento c’è stato. Ed è doloroso perché cosa vuoi fare con 10 colleghi? Arriveranno dei giovani psichiatri, ma qual è la cultura che hanno? C’è un progetto di riproporre una cultura territorialista? Chi la porta avanti? Qualcuno al governo arriva a dire di riaprire i manicomi… io mi incateno.
JG: Pensi che non sia comunque possibile un passaggio culturale tra chi è rimasto e i giovani che arrivano?
AI: In questo momento faccio fatica a pensarlo. Anche perché c’è una fatica generale di chi sta lavorando. L’unica cosa che devi fare adesso è gestire l’emergenza, urgenza per urgenza, non hai tempo di fare altro.
JG: Non pensi che potrebbero essere comunque in atto, in chi si sta specializzando ora, dei nuovi modelli positivi?
AI: Si stanno attivando dei modelli. Devi in ogni caso seguire una scuola di pensiero. Devi comunque approcciarti all’ambito psicoterapico. I milanesi portano avanti però la scuola cognitivo comportamentale. Perché si ritiene sia quella misurabile! Binswanger diceva che la scientificità all’interno della psicologia è il cancro della psicologia. Come puoi pensare di standardizzare l’umano?
Secondo il metodo scientifico quello che io riesco a fare qui, con te, dovrebbe riuscire a farlo un signore negli Stati Uniti con un altro. Non è standardizzabile! È un disastro così come i protocolli di intervento… e i tirocinanti vengono da me dicendo con orgoglio di essere cognitivo-comportamentali.
Va bene, mi dico sempre che son partito sistemico e non so cosa sono ora. Forse è giusto comunque partire da qualcosa, un qualcosa che ti struttura per poi andare oltre.
JG: Quindi in un certo modo i modelli sono utili. Far passare il senso in cui sono nati quei modelli è più difficile?
AI: Devi anche considerare che anche i modelli di patologia psichiatrica si sono evoluti nel tempo. È rarissimo oggi vedere una paziente con una manifestazione isterica di tipo charcotiano. Adesso sono esplosi gli attacchi di panico. Depressioni in quantità notevoli (e c’è da dire che le terapie farmacologiche aiutano molto). Le psicosi sono molto ridotte mentre si ha un aumento vertiginoso delle nevrosi e dei disturbi della condotta alimentare così come delle tossicofilie in comorbilità con le patologie psichiatriche. Un aumento di circa il 30% della casistica, limitandosi a quella misurabile, quindi è una stima per difetto.
Inoltre, è cambiata anche la qualità dei pazienti e in mancanza di una cultura di riferimento anche i modelli organizzativi sono inutili. L’espansione delle sostanze psicoattive, a esempio, l’aumento delle persone intossicate e il relativo aumento delle aggressioni fuori e dentro l’ospedale ne sono un esempio. Il paziente psichiatrico è solitamente dentro a un mondo tale che è difficile riesca a far del male a qualcuno. Al contrario l’intossicato da cocaina o crack può esser molto pericoloso.
Senza un’organizzazione basata sul territorio di riferimento, si cerca poi di scaricare i pazienti socialmente pericolosi sui reparti di psichiatria o sulle CRA (Comunità Riabilitative ad Alta Assistenza). Questo è uno degli effetti del non aver pensato strutture adeguate dopo la chiusura degli Ospedali giudiziari. Quando lavoravo in ospedale c’era una lista di attesa di 70 pazienti per le REMS. Il reparto era diventato l’anticamera delle REMS, ma questo è pericolosissimo e io mi sono sempre opposto.
Torno alla tua domanda. Far passare il modello è una questione più delicata. Sono stato richiamato in servizio per sostenere l'ambulatorio per i disturbi della condotta alimentare, ma credo che a dicembre di quest’anno mi fermerò, in fondo sono un pensionato. Poi credo anche che probabilmente, se arriva il nuovo psichiatra, continuerò a lavorare per affiancarlo nel passaggio. Se mi sta simpatico. Nel frattempo passerò le prossime settimane a costruire un modello per i disturbi del comportamento alimentare. Mi aiuterà la dottoressa Floris, psicoterapeuta con cui lavoro da tempo. Sarà un modello territoriale perché è a casa che ci sono i problemi.
Franco Basaglia e la legge 180: frammenti dello scenario sociale e politico
Franco Basaglia nasce a Venezia nel 1924, un anno e mezzo dopo la presa di potere fascista.
Cresce e studia tra regime fascista e Seconda guerra mondiale. Consegue la maturità classica nel 1943; poi, si iscrive a medicina a Padova, dove svolge anche attività antifascista, che lo porta all’arresto, nel dicembre del 1944. Resta in carcere fino ad aprile del 1945, alla fine della guerra.
Nel 1949 si laurea in medicina e inizia la pratica clinica nel dipartimento per le malattie nervose e mentali di Padova, studia con Roberto Belloni, pioniere della neurofisiologia clinica, della neurochimica applicata e della neuroradiologia, base diagnostica delle neuroscienze cliniche padovane.
Negli anni dell’Università e della pratica clinica si dedica anche allo studio filosofico, all’esistenzialismo di Sartre, alla psichiatria fenomenologia di L. Binswanger.
Nel 1953 si specializza in malattie nervose e mentali e sposa Franca Ongaro, che – a differenza di quanto spesso si pensa – non era medica, né psicologa, ma letterata. Con lei lavora per tutta la vita.
Dal 1953 al 1961, assistente di Belloni a Padova, si dedica alla ricerca e alla pratica clinica, come; nel 1958 ottiene la libera docenza in psichiatria.
Il 1961 è l’anno della svolta: Franco Basaglia inizia il rivoluzionario lavoro di direzione dell’ospedale psichiatrico di Gorizia.
Tra il 1961 e il 1970 visita una comunità terapeutica di Maxwell Jones in Scozia e le esperienze di apertura francesi. Nel 1967 cura il volume Che cos'è la psichiatria? e nel 1968 L'istituzione negata. Rapporto da un ospedale psichiatrico, che racconta l'esperienza di Gorizia.
Tra il 1970 e il 1971, dirige – per poco tempo – la struttura psichiatrica di Colorno, vicino a Parma e, nel 1971, accetta la direzione dell’ospedale psichiatrico di Trieste, enorme struttura che sorge sul colle di San Giovanni e ospita 1182 malati di cui 840 sottoposti a regime coatto.
Trieste è il luogo in cui mette in pratica, in modo ampio e completo, il suo approccio di normalizzazione della malattia mentale e di apertura dell’ospedale psichiatrico alla città e della città all’ospedale psichiatrico.
Nel 1973 fonda la Società Italiana di Psichiatria Democratica; nello stesso anno l’Organizzazione Mondiale della Sanità riconosce Trieste come zona pilota per la ricerca sui servizi per la salute mentale.
Il 1978 è l’anno in cui il suo approccio prende forma in termini istituzionali con l’approvazione della legge 13 maggio 1978, n. 180 - la Legge Orsini, chiamata quasi sempre Legge Basaglia – che abroga quasi completamente la legge del 14 febbraio 1904, n.36 e che impone la chiusura dei manicomi, regolamenta il trattamento sanitario obbligatorio e istituisce i servizi di igiene mentale pubblici.
Franco Basaglia nel 1980 prende servizio come coordinatore dei servizi psichiatrici della Regione Lazio – dove potrebbe mettere in pratica il modello di psichiatria aperta e territoriale ma, colpito da un tumore, muore nel mese di agosto, a 56 anni.
FRAMMENTI DI CONTESTO SOCIALE ED ECONOMICO
Per comprendere “dove e come” nascono ed evolvono il pensiero e l’opera di Franco Basaglia e dei suoi colleghi, abbiamo provato a isolare alcuni frammenti di contesto che esemplificano quale fosse lo stile di pensiero che ha accompagnato questa evoluzione.
FRAMMENTO #1– IL REGIME FASCISTA
Franco Basaglia studia tra fascismo e Seconda guerra mondiale e viene incarcerato per alcuni mesi tra 1944 e 1945, per attività antifascista. È il periodo in cui, gli eccessi fascisti e nazisti, le leggi razziali e la repressione politica stimolano il desiderio di libertà. Durante il regime fascista le libertà fondamentali, di parole, di movimento, di educazione e di professione sono negate e il manicomio – più che nel passato -è usato come strumento politico, di contenimento, non solo della cosiddetta devianza sociale e mentale, ma anche della opposizione politica.
Un caso emblematico è quello di «Giuseppe Massarenti, leader del movimento bracciantile emiliano e poi sindaco socialista di Molinella – ricordato come il Santo del Socialismo italiano – fu mandato al confino nel 1926 e da lì seguirà un doloroso processo di impoverimento e di caduta nella marginalità che si concluse con il trasferimento alla Clinica delle malattie nervose e mentali di Roma prima e al celebre ospedale psichiatrico della capitale – il Santa Maria della Pietà – poi. Delirio paranoico la prognosi. Un classico» (Petracci M., I matti del duce. Manicomi e repressione politica nell’Italia fascista, 2014, Donzelli, XVIII, p. 238).
Durante il regime di Mussolini il numero di reclusi psichiatrici quasi raddoppia rispetto ai decenni precedenti, i manicomi italiani passano ad ospitare da 55 mila (dati del 1920) a 95 mila persone (dati del 1941)[1]
FRAMMENTO #2 – L’IMMEDIATO DOPOGUERRA
Il periodo della laurea e degli studi per la specializzazione scorre tra la fine della guerra e i primi anni ’60. Sono gli anni del boom economico, della scoperta del benessere, in Italia, per (quasi) tutti, della condanna delle miserie come quelle dei Sassi di Matera (la visita di P. Togliatti a Matera è del 1948), dell’affermazione di una nuova economia industriale – della Fiat che “importa” manodopera dal sud del Paese, della “fabbrica aperta” di Adriano Olivetti; sono anni in cui – sollevata dall’oppressione del regime, dalle disgrazie della guerra e dalla miseria delle difficoltà economiche - la società italiana può pensare anche a cose marginali: i matti e la malattia mentale, per esempio, le modalità coercitive in cui vengono trattati.
Nel 1957 Sergio Zavoli realizza il documentario radiofonico Clausura all’interno di un monastero di clausura delle Carmelitane scalze e – intervistando Padre Rotondi, cita Pio XII che, nell’enciclica Sponsa Christi aveva definito non più tollerabili certi disagi in cui vivono le monache di clausura.
Questo atteggiamento – però - non sembra toccare la facoltà di medicina di Padova e – in particolare – l’istituto di malattie nervose e mentali, diretto da Belloni, che era «intriso di positivismo scientista e lombrosiano […] fedele alla tesi organicistica che vede la malattia mentale come la conseguenza di tare biologiche congenite».
In quegli stessi anni, la fenomenologia e l’esistenzialismo dominano la scena filosofica e si spingono all’interno del perimetro della psicologia, della medicina, della psichiatria.
FRAMMENTO #3: GLI ANNI ’60, FINO AL 1968
Il periodo in cui Basaglia dirige l’ospedale psichiatrico di Trieste, tra il 1961 e il 1970, è quello in cui maturano le istanze che sfoceranno nella “rivoluzione” del 1968.
È un vero e proprio tentativo di rovesciamento del paradigma sociale, in cui la tradizione e la conservazione dei valori borghesi della fine del XIX secolo e anche del primo dopoguerra – gli stessi valori di ricerca del benessere economico che hanno favorito l’attenzione ai marginali – vengono messi in crisi.
Sono gli anni in cui si parla, si scrive, si canta e si urla – nelle manifestazioni e nei momenti di lotta - di immaginazione al potere, di libertà da ogni costrizione – culturale, sociale, sessuale.
È nel 1968 che il Ministro della Sanità Luigi Mariotti firma la Legge di riforma psichiatrica che porta il suo nome e che abolisce l’obbligo di iscrizione nel Casellario giudiziale e prevede la possibilità del ricovero volontario e i Centri di Igiene Mentale con equipe multi professionali composte da psichiatri, psicologi, infermieri, assistenti sociali [2]
Sono gli anni in cui inizia la fine del boom economico e – sulla scia del libertarismo del ’68 – si affermano le istanze di rivendicazione economica e sociale dei lavoratori delle fabbriche, sostenuti da ampie schiere di studenti liceali e universitari.
Nel 1968, ancora Zavoli, “entra” nel manicomio di Gorizia con le telecamere di TV7 a documentare
FRAMMENTO #4: DAL 1968 AL 1978
Negli anni tra il 1968 e la promulgazione della Legge 180 accadono fatti che possono essere ricordati come elementi rilevanti per la formazione del pensiero di Basaglia e del suo gruppo di co-pensatori, per il favore che questo pensiero può trovare tra società e contesto politico.
Si tratta – ad esempio - della crescita di consenso del Partito Comunista Italiano, che nel 1976 raggiunge il 34% delle preferenze, guadagnando quasi 10 punti percentuali e 5 milioni di voti rispetto al 1963, a solo 4 punti dalla Democrazia Cristiana.
Si tratta anche del tentativo di rovesciare il paradigma di contrapposizione partitica tra DC e PCI, che aveva dominato fino ad allora, attraverso la formula del compromesso storico che si sostanziò prima nel governo di solidarietà nazionale (1976), a guida Andreotti, e nell’ipotesi di entrata del Partito Comunista nella compagine del successivo governo, studiata da Enrico Berlinguer e da Aldo Moro e sostenuta da Zaccagnini. Il compromesso storico naufragò proprio nel 1978 con il rapimento e la successiva uccisione di Aldo Moro.
Sono anche gli anni del sindacalismo, della promulgazione della Legge 20 maggio 1970, n. 300 nota come Statuto dei lavoratori, che riconosce formalmente e in maniera organica una serie di diritti ai lavoratori di tutti i comparti, diritti fino ad allora spesso negati o ignorati, a partire dal Diritto all’opinione (Art. 1 della Legge Cit.) e del diritto all’Assemblea Sindacale, considerata in molti casi un atto di sedizione.
E del contro-sindacalismo: nel 1969 vengono ufficialmente riconosciuti i consigli di fabbrica; Alla fine del 1970 i CdF sono già 1.374 con 22.609 delegati: nel 1971, 2.566 con 30.493 delegati, nel 1972 un totale di 83.000 delegati; non mancano - però – le forme di opposizione da parte di alcune frange sindacali, che vedono nel Consiglio di Fabbrica un sistema per ingabbiare la protesta e suggeriscono mezzi di espressione con base più ampia e – in alcuni casi – modi più aggressivi.
Le assemblee sono un elemento chiave dei due decenni che seguono il 1960: note solo come momenti di aggregazione partitica o di movimento – molto spesso clandestine - diventano in breve tempo uno degli strumenti teoricamente portatori di democrazia più diffusi nelle fabbriche, nelle aziende, nelle scuole e nelle università; tutto si discute in assemblea, tutto si decide in assemblea, tutti i leader vengono nominato o acclamati in assemblea.
Le assemblee sono un modo per fare sentire la propria voce, per fare partecipare, per sentirsi liberi; Libertà è partecipazione, canta Giorgio Gaber nel 1972.
Far sentire la voce di chi non l’ha mai avuta in pubblico è anche uno dei momenti – chiave delle prime radio libere “impegnate”[3], che fanno intervenire gli ascoltatori al telefono in diretta.
Tra le voci che conquistano il diritto ad essere – finalmente – ascoltate ci sono quelle delle donne che, ad esempio, nonostante dure opposizioni interne, conquistano una propria progressiva rilevanza all’interno dei movimenti sindacali verso la metà degli anni ’70; e lo fanno con assemblee e comitati femminili, non contrapposti ma paralleli a quelli sindacali ufficiali.
E, a Verona, nel 1976, si svolge il primo processo per stupro in cui la vittima rifiuta di interpretare il ruolo passivo di “oggetto” della violenza sessuale per diventare “soggetto” di un’accusa che trascende i suoi stupratori, spiegando quanto la sua vicenda “personale” sia in realtà “politica”. In aula la ragazza è sostenuta dalla presenza di un coordinamento di gruppi femministi e la sua voce – non più silenziata come nei casi analoghi – si fa sentire in una dimensione pubblica, grazie alla copertura dei media più tradizionali e della televisione, che ne fa un documentario trasmesso in prima serata alla fine di ottobre dello stesso anno.
-----------
È in questo scenario o, meglio, questo susseguirsi di scenari sociali e politici – delineato in pochi tratti a cui manca sicuramente molta “storia” – che si forma l’esperienza e la rivoluzione di Franco Basaglia, di Franca Ongaro, di Giovanni Jervis e dei loro colleghi.
Idee ed esperienze che attingono anche a quella che fu chiamata da Pasolini – e non a torto - «ubriacatura di astrazione teorica» ma che ha sicuramente segnato la trasformazione della società italiana dal dopoguerra alla fine degli anni ’70.
NOTE
[1] Cfr. Petracci M., Cit.
[2] Reggio Emilia è in prima fila nell’avvio dell’esperienza territoriale e nel 1968 la Provincia apre i primi Centri di Igiene Mentale, affidati dal 1969 a Giovanni Jervis, psichiatra che aveva lavorato con Basaglia a Gorizia.
[3] Cfr. F. Monteleone, Storia della radio e della televisione in Italia, Feltrinelli, 2021
Epistemologia e clinica (oltre la politica) in Franco Basaglia
“Basaglia” è il nome di una rivoluzione quasi universalmente riconosciuta, anche se poco o nulla applicata fuori dall’Italia. I dibattiti sulla legge 180, sulle sue luci impossibili da spegnere, ma anche sui suoi limiti attuali, si susseguono ciclicamente. Spesso il Basaglia clinico tende a essere offuscato dalla, giustamente celebre, portata politica della sua battaglia e del suo gesto. Eppure, clinica e politica, in lui, sono legati.
Figlio della tradizione della psichiatria fenomenologica, esistenziale, dasein-analitica, in lui sono costanti i riferimenti a pensatori ritenuti fondamentali fino agli anni 60’-70’, e oggi un po’ in ombra, come Sartre, Heidegger, Merlau-Ponty, Husserl, Biswanger. Autori politici, ognuno a suo modo, da cui Basaglia trarrà i propri echi; correnti di pensiero appunto, non solo strettamente filosofiche, tali da investire tutti i campi delle scienze cosiddette “umane”.
La psichiatria è chiaramente una scienza limite, avendo come oggetto qualcosa di eternamente sfuggente come l’umano, rimanendo con un piede o entrambi, all’interno di un’altra scienza limite, cioè la medicina.
Medicina: sapere, tecnica, che unisce arte, nel senso ippocratico, e scienza transitata nella cornice del moderno. E sullo psi della iatreia (cura), su cosa sia o come sia quella psyché a salire fino alla nostra “psiche” o “mente” la risposta non è definitiva.
Tantomeno sulle sue malattie e le sue cure. Ne consegue che teoria e prassi, epistemologia e azione sono indissociabili; di qui, il problema storico, sociologico e infine politico non cesserà mai di ripresentarsi.
In Un problema di psichiatria istituzionale e testi vicini (L’ideologia del corpo, Corpo, sguardo e silenzio, ecc), l’originalità dell’intreccio che presenta Basaglia è evidente: emerge una teoria della clinica come specchio di una teoria politico-critica.
Il sottotitolo è eloquente: L’esclusione come categoria socio-psichiatrica. Da un punto di vista di filosofia politica, o anche socio-antropologico, la categoria dell’escluso è inerente a ogni società, e in particolare in quelle dove siano presenti divisioni gerarchiche.
Il capro espiatorio è quel “dispositivo” (politico, sociologico, antropologico) in cui le contraddizioni di una società vanno a concretizzarsi, scaricando l’aggressività che esse comportano.
Ma il malato mentale ha una sua peculiarità: egli è posto fuori dalla dialettica. Quelli che oggi chiameremmo “gruppi marginalizzati” hanno sempre avuto un potenziale attivo di rivolta. Il malato mentale è una figura più enigmatica: se Foucault voleva dare parola alla follia, è perché essa non parla mai in modo univoco, e dunque è al confine col silenzio; ma se il malato mentale è ridotto all’espressione della propria malattia, confine sempre aperto, la sua stessa parola sarà puro silenzio.
Così funziona la realtà di quest’esclusione peculiare: ogni parola di risposta, di tentativo di dialettica, è nuovo rinforzo, motivo per prolungare l’esclusione.
Il tutto comporta per Basaglia, che egli è all’interno della sua stessa epistemologia, cioè nel dispositivo per dire e poi curare, trattare, la follia come malattia mentale. Comporta che la psichiatria può trovare le leve per dialettizzare il malato. Le parole quasi d’ordine dell’impianto degli autori sopracitati sono imperniate intorno alla soggettività, alla libertà, al corpo, alla scelta.
Il problema centrale per quest’approccio è la questione della scelta, scelta di sé come libertà e dell’angoscia che questa comporta, eco esistenzialista, la cui difesa primigenia è l’esclusione. Ma non solo: l’altro da sé è anche la propria “fattità”.
Fattità che si è come corpo, “corpo oggettuale”, opacità, passività, nonché soggetto delle percezioni, corporeità con cui si è nel mondo (Merleau-Ponty), di cui ci si deve appropriare per essere soggetti di scelta propria, cioè per soggettivarsi.
L’opacità è anche, specularmente, quella dell’altro. Dunque, incorporare la propria estraneità è parte dello stesso processo del riconoscere l’altro come altro da sé. Non solo come oggetto, come “concretizzazione” dell’estraneità che si rifiuta, ma come a sua volta luogo di una soggettività. Corpo oggettuale, ma anche – husserlianamente – centro di un “io fungente”.
Al contrario, la mancata appropriazione della propria opacità corporea – della vulnerabilità, della materialità – dell’essere corpo-oggetto sia di se stessi sia dello sguardo altrui porterà alla sua esclusione nell’altro divenuto “osceno”. Altro incomprensibile e dunque riducibile soltanto a oggetto, così come a oggetto dell’altro si è sempre ricondotti in questa dinamica.
La genialità di Basaglia, nell’intrecciare clinica e politica, sta qui nel proporre una diagnosi strutturale tra nevrosi e psicosi, capisaldi freudiani, come due modi di essere-nel-mondo con connotazione politica: esclusione ideologica e utopia psicotica. Se per Freud il conflitto centrale della prima è tra Io ed Es, per accettazione del mondo esterno, quello della seconda tra Io e mondo esterno, per lo strabordare dell’Es, qui il conflitto è frutto di un’esclusione del reale.
Per il nevrotico tale esclusione è ideologica, nel senso che non v’è rinuncia a un rapporto con l’altro, ma comunque rifiuto della propria contingenza, dell’ansia derivante dalla scelta di sé e dell’appropriazione del proprio corpo.
Come risposta – o difesa – edificherà un’ideologia, un’immagine “ideale” del corpo, con cui controllarne l’opacità, potendosi per lo meno relazionare con l’altro per il quale avrà comunque una certa oblatività.
È sull’altro e nel desiderio di essere accettato, che egli la edificherà. Pagando questo al prezzo di un’angoscia che produce inibizione, indeterminazione, restringimento.
L’altro è dunque mantenuto nella sua soggettività, sempre nel filtro di un’ideologia che lo conduce alla malafede sartriana.
Per lo psicotico, invece, il rifiuto è ben più radicale. Il risultato di questo processo non è la costruzione di un’ideologia, ma di un’utopia.
La contestazione che il reale continua a far irrompere, reale come opacità, viene a tal punto mal tollerata che è solo nel delirio – cioè in una costruzione sganciata dall’altro, dal “co-mondano” – che uno psicotico potrà trovare una sorta di stabilizzazione e controllo.
Ma proprio lì è un mondo senza limiti, sotto la costante minaccia di quell’angoscia che non cesserà di tormentarlo, divenendo sempre più schiacciante e distruttiva con conseguenti difese estreme.
Se la terminologia politica è qui esplicita, diviene evidente il problema politico dei manicomi: alla regressione psicotica viene aggiunta, intrecciata, una regressione istituzionale. All’esclusione che il malato opera si aggiunge l’esclusione che la società opera su di lui attraverso le mura del manicomio, difesa non del malato, ma dei sani.
L’opacità, l’incomprensibilità del malato di mente, è ridotta a pericolosità sociale. Egli rimane quell’“osceno” (fuori-scena) privo di qualunque soggettività. Alla malattia si sovrappone dunque una malattia indotta direttamente dall’istituzione, in un circolo vizioso in cui le due diventano indistinguibili, fortificandosi a vicenda e giustificando quindi l’apparato manicomiale.
Il restringimento dell’Io – il rimpicciolimento, il rinchiudersi della soggettività, a cui già fa fronte il malato – è speculare al risultato di quella “carriera morale” a cui è sottoposto dall’istituzione disciplinare. L’Io è ridotto a spettro, uomo privato di tutto, homo sacer o musulmano di Auschiwtz, seguendo la concettualizzazione successiva di Giorgio Agamben: non a caso c’è riferimento esplicito a Primo Levi.
È qui che si innesta una specifica teoria del potere: rifiuto dell’autorità o dell’autoritarismo, ma non rifiuto del potere tout court. Perché il potere contiene in sé anche lo spazio di una dialettica, che non si riduca a quella servo-signore hegeliana.
Da questo breve excursus si può notare come epistemologia, clinica e politica non siano dissociabili. Al netto dell’impossibilità di liberarsi della contingenza, in particolare storica, quando si tratta della prassi, Basaglia offre un originale e si spera non dimenticato esempio di questo gesto di annodamento.
L’etica hacker al di là di destra e sinistra - Il potere e la Silicon Valley
Quo usque tandem
Fino a quando i politici e i media mainstream abuseranno delle categorie di destra e sinistra per parlare della Silicon Valley? Candidati, ministri, deputati e giornalisti si impigliano in questa classificazione già nei loro discorsi consueti, aggovigliandosi in parole d’ordine in cui è difficile comprendere cosa distingua questi orientamenti politici e in che modo li si debba identificare. La loro applicazione al sistema di economia e di potere delle Big Tech è ancora più arbitrario, dal momento che i fondatori e i manager delle multinazionali digitali americane, l’ecosistema degli startupper e dei finanziatori, dichiarano da sempre di appartenere ad un’élite dell’umanità in cui valgono regole di valutazione, diritti di decisione e libertà di manovra, che non si trovano nella disponibilità di tutti.
Nello statuto di Facebook e nella lettera agli azionisti al momento del collocamento in Borsa, Mark Zuckerberg chiariva che il fondatore avrebbe conservato un potere di voto maggioritario, in modo indipendente dalla distribuzione delle quote azionarie, perché aveva dimostrato di essere più smart di chiunque altro. La rivendicazione di questo privilegio proviene dall’etica hacker, che distingue gli esseri umani in capaci e incapaci, senza ulteriori sfumature. L’abilità è testimoniata dal talento di trovare una procedura per risolvere qualunque problema – anzi, nell’individuare il procedimento più semplice dal punto di vista dell’implementazione e più esaustivo dal punto di vista dei risultati. Se si considera che questa è la prospettiva con cui viene descritta l’intelligenza dalle parti della Silicon Valley, non sorprende che la progettazione di una macchina capace di vincere le partite di scacchi sia stata interpretata come la via maestra per realizzare l’Intelligenza Artificiale Generale (AGI), raggiungendo la Singolarità, il tipo di intelligenza che si ritrova negli esseri umani.
Il problema di cosa sia smartness è che dipende sempre dalla definizione, e dal contesto culturale che la concepisce. Per gli esponenti più influenti della Silicon Valley coincide con la capacità di escogitare algoritmi: una serie di operazioni governate da una regola che possono essere automatizzate – ingranaggi che, sistemati nei luoghi opportuni, fanno funzionare meglio la macchina-mondo, così com’è. La politica, come riflessione sul potere e come progetto antropologico che immagina una realtà migliore e una società più giusta (qualunque significato si assegni a migliore e a giustizia), non serve: è inefficiente, provoca disagi e rallentamenti. L’universo attuale non ha bisogno di aspirazioni al cambiamento, se non il requisito di un’efficienza maggiore, movimenti più oliati, privilegi che si perpetuano scontrandosi con meno frizioni, un’opinione pubblica convertita in una platea di utenti-clienti.
Smartness
In questa prospettiva, i «ragazzi» che hanno fondato le imprese da cui proviene l’ecosistema di software in cui siamo immersi, possono a buon diritto stimarsi più smart degli amministratori pubblici. Elon Musk ha avviato il progetto Starlink per l’erogazione di connettività a banda larga via satellite nel 2019, e oggi conta su oltre 7.000 satelliti già in orbita, con circa tre milioni di abbonati tra gli utenti civili di tutto il globo – senza contare la capacità di intervenire nelle sorti delle guerre in corso in Ucraina e Israele, o di contribuire al soccorso delle popolazioni alluvionate in Emilia Romagna nel 2023. L’Unione Europea ha varato un piano concorrente solo quattro anni dopo: Iris2 ha debuttato nel marzo 2023, dopo nove mesi di dibattito preliminare, con la previsione di lanciare 170 satelliti entro il 2027. Il progetto però sta già subendo dei rinvii a causa delle tensioni con i partner privati Airbus (tedesca) e Thales (francese).
Altro esempio: dopo l’approvazione dell’AI Act, l’Unione Europea ha allestito un Ufficio per l’applicazione del regolamento, che occuperà 140 persone. Nel piano è previsto un finanziamento distribuito fino al 2027, di 49 milioni di euro complessivi, per progetti che creino un grande modello linguistico generativo open source, capace di federare le aziende e i progetti di ricerca del continente. L’obiettivo è costruire un’alternativa concorrente a ChatGPT, che però OpenAI ha cominciato a progettare nel 2015, su inziativa di quattro fondatori privati (tra cui il solito Elon Musk e Sam Altman, attuale CEO), che hanno investito di tasca loro oltre 1 miliardo di dollari, e che è stata sostenuta con più di dieci miliardi di dollari da Microsoft nell’ultimo round di finanziamento.
L’archetipo randiano
La storia dei successi delle tecnologie ideate e commercializzate in tutto il mondo dalle società della Silicon Valley accredita la convinzione dei loro fondatori di incarnare l’élite più smart del pianeta; l’etica hacker stimola la loro inclinazione a concepire, realizzare e distribuire dispositivi il cui funzionamento viola qualunque normativa a tutela della privacy e della proprietà intellettuale in vigore, con la creazione di mercati che trasformano ambienti, comportamenti, relazioni, corpi umani, in beni di scambio e di consumo; la filosofia di Ayn Rand giustifica sul piano della cultura, dell’ideologia e della politica, il loro atteggiamento come la missione salvifica dell’individuo eccezionale nei confronti della destinazione storica dell’intera specie. La devozione agli insegnamenti della Rand accomuna tutti i leader delle Big Tech in un’unica visione dell’uomo e del mondo, che legittima i loro modelli di business come valide espressioni del loro talento, e censura le reazioni degli organismi di giustizia come il sabotaggio perpetrato dall’ottusità tradizionale e dalla repressione (sprigionata dalla vocazione comunista di ogni istituto statale) sulla libertà di azione dell’imprenditore-eroe. La rivendicazione della libertà di iniziativa al di là dei limiti di qualsiasi sistema legale non avviene solo sul piano del diritto, ma è avvertita come un dovere da parte dei depositari della smartness del pianeta – perché, come osserva il co-fondatore ed ex direttore di Wired Kevin Kelly, il loro coraggio di innovazione porta a compimento un percorso di evoluzione ineluttabile: il tentativo di resistervi conduce ad un ruolo subordinato nelle retrovie del presente, nella parte di chi viene accantonato dalla Storia.
Tecnologia e istituzioni
Riotta e Bonini rilevano che oggi l’espressione culturale della Silicon Valley è il Think Tank del Claremont Institute, dove verrebbe praticato una sorta di culto delle idee di Leo Strauss. Se così fosse, dovremmo riconoscere che il clima filosofico della zona si è molto moderato, e raffinato, rispetto al superomismo tradizionale della Rand. Tuttavia gli editorialisti de la Repubblica leggono questo passaggio come un segnale dello sbandamento verso destra dei rappresentanti delle Big Tech, tra i quali si avvertirebbe sempre di più la frattura tra progressisti e reazionari. L’articolo del 21 settembre di Riotta prepara l’interpretazione politica del premio «Global Citizen Award 2024» dell'Atlantic Council a Giorgia Meloni, consegnato il 24 settembre da Elon Musk in persona. Molti giornali hanno chiosato il significato dell’evento come la celebrazione dell’alleanza tra il gruppo di imprenditori legati a Musk e la destra europea e americana. Il contratto di cui il creatore di Starlink e la Presidente del Consiglio avrebbero parlato nel loro colloquio privato riguarda proprio la gara di appalto per i servizi di connettività dello stato italiano. Tim e OpenFiber si sono aggiudicati i progetti per la copertura con banda larga di tutto il territorio, alimentati dal Pnrr; ma hanno già accumulato ritardi e opposto difficoltà alla concorrenza satellitare, per cui il governo potrebbe decidere di sostituire la loro fornitura via terra con quella dei servizi di Elon Musk. Anche per le operazioni di lancio dei satelliti di Iris2, l’Italia potrebbe appoggiare la collaborazione con SpaceX, grazie alla quale verrebbero superati gli impedimenti sollevati da Airbus e Thales. Il rapporto con le società americane permetterebbe loro di entrare nelle infrastrutture strategiche per la gestione dei servizi civili e persino per quelli di sicurezza nazionale dell’Unione Eruopea.
Già negli anni Ottanta del secolo scorso Ulrich Beck osservava che il ritmo di avanzamento della scienza e della tecnologia è troppo veloce per permettere alle istituzioni pubbliche di vagliare i rischi, di verificare condizioni e conseguenze, di guidarne lo sviluppo: alla politica non resta che constatare e convalidare l’esistente. Il rapporto che si stabilisce tra le figure di Musk e della Meloni non sembra differente: non è l’imprenditore ad essere affiliato alle fila della destra politica, ma è l’innovatore spregiudicato che definisce le prospettive della tecnologia, le possibilità che essa pone in essere, e i criteri per giudicare dispositivi e processi concorrenti. L’Unione Europea è relegata nel ruolo di inseguitore poco efficiente di ciò che Starlink ha già concepito e realizzato: il discorso con cui Giorgia Meloni consacra Elon Musk come campione degli ideali della destra, in fondo, non è che il gesto di validazione dell’esistente da parte delle istituzioni, e l’affiliazione della politica al mondo che l’eroe randiano ha progettato per noi. È la Presidente del Consiglio ad essere arruolata tra i legittimatori della leadership naturale dell’hacker, nelle fila di coloro che percepiscono il bene comune come la soluzione tecnologica di problemi che, o permettono questo tipo di ricomposizione, o non esistono.
Come ha dichiarato Sam Altman alla fine di luglio 2024, anche la crisi delle disparità sociali ha una soluzione che deve essere gestita dalle aziende tecnologiche, con la distribuzione di un reddito base universale a tutti coloro che stanno per perdere il lavoro: a causa della rivoluzione imminente dell’Intelligenza Artificiale Generale, secondo il CEO di OpenAI, questa sarà la situazione in cui a breve verseremo quasi tutti. Sono quasi due decenni che con le piattaforme digitali, Facebook e Google in primis, l’intero mondo Occidentale si è trasformato in un enorme esperimento sociale a cielo aperto, controllato e mirato solo da chi possiede le chiavi del software (purtroppo, molto spesso, nemmeno troppo in modo consapevole).
Come al tavolo dell’Atlantic Council, Giorgia Meloni siede alla destra di Elon Musk, alla corte dei re della tecnologia politica.
BIBLIOGRAFIA
Ulrich Beck, Una società del rischio. Verso una seconda modernità, trad. it. a cura di W. Privitera, Carocci Editore, Roma, 2005.
Paresh Dave, Here’s What Happens When You Give People Free Money, «Wired», 22 luglio 2024.
Kevin Kelly, Quello che vuole la tecnologia, Codice Edizioni, Milano 2010.
Gianni Riotta, Carlo Bonini, Silicon Valley, in fondo a destra, «la Repubblica», 21 settembre 2024.
Namibia, uccidere per mangiare - Animali protetti e persone affamate
83 elefanti, 300 zebre, 100 gnu, 150 antilopi, 60 bufali e 30 ippopotami: sono 723 grandi animali – protetti – dei parchi nazionali che saranno uccisi da cacciatori ufficialmente incaricati dal Governo della Namibia.
Questo piano istituzionale è un intervento mirato a contrastare la più grave carestia degli ultimi 100 anni, con le scorte alimentari già esaurite per l’84%, più della metà della popolazione che si trova in gravi difficoltà alimentari dal mese di luglio e un aggravamento delle condizioni di malnutrizione per i bambini sotto i 5 anni .
Quindi: il Governo della Namibia intende sacrificare una parte consistente delle risorse naturalistiche del paese per far mangiare la propria gente, per alleviare le gravi sofferenze e difficoltà in cui questa gente versa. Sono risorse dei parchi, oggetto dell’interesse turistico e – per questo – elemento importante dell’economia namibiana; e sono protette dalle leggi costituzionali: «Lo stato dovrà promuovere e proteggere attivamente il benessere della popolazione facendo proprie le politiche internazionali rivolte ai seguenti obiettivi: protezione degli ecosistemi, processi ecologici essenziali, biodiversità, e uso delle risorse naturali come base sostenibile per il bene di tutti i namibiani, presenti e futuri» (Articolo 35 della Costituzione della Namibia). Ma, d’altra parte, questo stesso dettato costituzionale legittima l’uso degli animali per far mangiare i namibiani: «per il bene di tutti i namibiani», e quale maggior bene della sopravvivenza?
In più, anche questi animali hanno fame, perché la carestia colpisce tutti, indistintamente, e hanno iniziato ad esercitare pressione sui villaggi e sui paesi “di confine” con le aree protette, facendo danni e – pare - qualche vittima tra gli umani.
E sono tanti, forse troppi: in molte regioni dell’Africa i programmi – realizzati secondo criteri ecologici e scientifici - di protezione delle specie caratteristiche e di sostegno al popolamento hanno dato risultati superiori alle aspettative e generato un numero di individui superiore al livello di sostenibilità territoriale, eccesso che rischia di mettere in crisi gli equilibri tra umani e non umani e tra diverse specie.
QUESTIONI DI CONFINE
Da questa storia emergono – immediate – alcune questioni di confine, anch’esse, tra scienza e morale.
La prima riguarda il valore morale delle specie animali, umane e non umane; è evidente che per il Governo e, immaginiamo, per tutti i namibiani, sfamare la popolazione è più importante della vita di qualche centinaio di animali dei parchi.
In secondo luogo, gli animali dei parchi sono – lo dice la costituzione – risorse naturali il cui uso, che sia essere fotografati, cacciati o macellati, è finalizzato al bene della popolazione. Il confine è, qui, proprio tra individui e risorse. Questo confine ricalca la trasformazione di queste regioni, in cui – prima dell’intervento coloniale, delle successive rivoluzioni indipendentiste e delle occidentalizzazioni – tradizionalmente, gli animali avevano un diritto all’individualità e godevano di forme di rispetto e di attenzione dettate dalle tradizioni di equilibrio tra i diversi abitanti, umani e non; ora sono risorse, da preservare e utilizzare con calcolo economico.
Terzo: l’effetto dannoso della fame è acuito dalla conflittualità “di confine” tra animali dei parchi e insediamenti umani: risultato – anche – degli interventi di preservazione e di ripopolamento di medio lungo periodo che hanno, probabilmente, trascurato l’analisi degli effetti collaterali.
INCROCI PERICOLOSI
Proviamo a incrociare questa storia con altre storie recenti, serie e meno serie, che parlano di uccidere per mangiare e a considerare le reazioni “pubbliche” che si sono registrate:
- La FAO è irremovibile – nonostante l’evidente contraddizione con i programmi transnazionali di riduzione delle emissioni di CO2 – sull’utilizzo del bestiame d’allevamento, mucche, maiali, polli, come fonte di cibo di elevata qualità. Legittima, in nome dell’evidenza scientifica della superiorità delle proteine di origine animale, l’industria dell’uccisione, per far mangiare “bene” la popolazione mondiale.
- Nel dibattito di pochi giorni fa tra i due candidati alla Presidenza degli Stati Uniti, uno dei candidati ha accusato gli immigrati Haitiani (neri e irregolari, è implicito) di uccidere, per mangiarli, i cani, i gatti e le oche dei vicini di casa (bianchi e regolari, si presume) cittadini di Pittsburgh.
Sulla posizione della FAO si registrano solo i commenti negativi di alcuni scienziati che studiano meno superficialmente il problema della CO2 e – naturalmente – degli attivisti animalisti. Nessun Governo e nessuna istituzione nazionale o sovranazionale pare aver preso una posizione di contrasto.
Sulla fandonia di cani, gatti e oche raccontata a fini elettorali dal candidato americano, invece, sono insorti tutti: molti per deprecare la falsità dell’argomento – puntualmente smentito dalle autorità di Pittsburgh – tutti, nessuno escluso, hanno aderito all’opinione di sdegno di fronte alla sola idea che possa accadere qualcosa del genere. Perlomeno per cani e gatti. Per le oche, invece, il fronte non è certamente compatto: il Governo inglese va verso l’abolizione delle importazioni del foie gras ma l’opposizione conservatrice si oppone; in California il divieto è già attivo da tempo e in Belgio sono stati chiusi gli allevamenti forzati; ma in Francia si continua a produrre.
E sulla Namibia? Preoccupazione e un po’ di sdegno delle organizzazioni naturaliste e animaliste, pur se mitigate dalla contropartita: si uccide – e in numero limitato - per alleviare la fame, per salvare i bambini, per far arrivare la popolazione all’arrivo di aiuti più consistenti. Non si dovrebbe, però… e nessun Governo, in tutto il mondo, sembra aver detto una parola.
GERARCHIE CONTROVERSE
Questi “incroci” sembrano disegnare delle mappe della gerarchia di rilevanza morale del mondo animale. Senza dubbio, in tutti i casi che abbiamo visto, gli umani sono al primo posto, ben al di sopra dei non umani: è legittimo, per un’ampia parte delle opinioni, uccidere altri animali per nutrire gli umani.
Però, va notato, non tutti gli “altri” animali sono ugualmente sacrificabili. I cani e i gatti godono di uno statuto privilegiato – sicuramente se domestici, apparentemente anche se randagi; non sono “buoni da mangiare”, ucciderli per mangiarli è deprecabile, incivile, barbaro.
Appena “sotto” ai cani e ai gatti, si vedono delle crepe: le oche, se a mangiarle sono gli immigrati Haitiani in USA, questi compiono un delitto. Se lo fa un cittadino francese, è rispetto della tradizione alimentare.
Solo in India le mucche non si mangiano, sia questa una questione religiosa o micro-economica, ma nel resto del mondo – fatto salvo per una abbastanza ridotta percentuale di eretici vegetariani e vegani – la carne di mucche, maiali e polli è necessità proteica, cultura, abitudine, (spreco), ed è legittimata anche dalla FAO con argomenti scientifici.
E gli animali selvaggi delle regioni esotiche? Elefanti, zebre, gnu, ippopotami, eccetera, godevano – in generale - anch’essi di uno statuto di intoccabilità, afferivano alla categoria delle specie a rischio di estinzione, da preservare, della biodiversità; ma si è aperta una crepa e pare che si possano uccidere e mangiare anche loro. E, oltre alla questione morale: meglio mangiare un elefante o lasciare malnutrito un bambino? entrano in gioco la dimensione economica: grandi animali affamati possono fare danni e per sostenere l’economia turistica dei parchi ce ne sono più che abbastanza, e la legittimazione scientifica, ecologica: troppi elefanti (ippopotami, gnu, …) mettono in crisi l’equilibrio faunistico e del verde territoriale.
Quello che si nota qui è che i criteri per costruire la scala di valore degli animali sono principalmente sociali e spesso godono di legittimazione scientifica – l’inferiorità intellettiva di alcuni animali rispetto ad altri, ad esempio, è oggetto di numerose ricerche cognitive.
Tuttavia, non sembra che tra questi criteri sociali ci siano il valore della vita dei singoli individui non umani né quello della sensibilità, criteri che animano – invece – la lotta contro l’alimentazione forzata delle oche in molti paesi europei e che – sempre – legittimano la posizione dominante degli umani, a cui tutti possono – di fatto - essere sacrificati.
Ancora un orso ucciso dalla politica - E la scienza che si crede neutrale
Tocca parlare di nuovo di un orso - ucciso “col favore delle tenebre”, come si direbbe in gergo giornalistico e senza, tuttavia, sbagliarsi - dal Presidente della Provincia Autonoma di Trento con l'aiuto della scienza che pretende di essere politicamente e moralmente neutrale.
I FATTI
Il 16 luglio scorso un’orsa, con un piccolo vicino, aggredisce e ferisce un turista francese che percorre il Sentiero degli scaloni, nei pressi di Dro, in Trentino. L’orsa sembra essere l’esemplare femmina, madre di 3 cuccioli, chiamato in codice KJ1.
Il giorno dopo, il Presidente della Provincia Autonoma di Trento delibera “la rimozione tramite uccisione (abbattimento)” dell’orsa KJ1 perché pericolosa per l’incolumità pubblica e perché non c’è il tempo per altre misure.
La misura di rimozione – attenzione, non di uccisione - è giustificata dal parere dell’ISPRA[1], secondo la valutazione del PACOBACE - Piano d’Azione interregionale per la Conservazione dell’Orso Bruno sulle Alpi Centro-Orientali, che classifica l’orsa come esemplare ad alta pericolosità.
A sostengo di questa ordinanza c’è il fattore tempo: la Provincia ritiene che non ne ce ne sia abbastanza per catturare l’orsa, metterle un radiocollare ed eventualmente trasferirla in altre zone o in cattività, senza pregiudicare la sicurezza dei cittadini e dei turisti.
Il 19 di luglio, il TAR di Trento accoglie il ricorso di gruppi di ambientalisti[2] e blocca il decreto di uccisione perché «senza alcuna possibile alternativa e senza un accertamento definitivo dell’effettiva riconducibilità dell’aggressione all’orsa KJ1», riporta Il Fatto Quotidiano. in sostanza, il Tribunale Amministrativo contesta l’assenza di sufficienti ragioni di merito per l'uccisione.
Nei giorni successivi si ripete il copione: la Provincia di Trento (PAT) emette una seconda ordinanza di uccisione e il TAR di Trento si ripete nel bloccarla poiché – seppur accogliendo la necessità di garantire la sicurezza ai cittadini – non riscontra la necessità della misura estrema dell’uccisione.
Il TAR sottolinea anche l’esigenza di preservare la sicurezza con maggiori misure di prevenzione quali una maggiore informazione e l’eventuale chiusura delle aree in cui si muove l’orsa giudicata pericolosa.
In media res: il 23 luglio l’orsa viene catturata in una trappola a tubo nell’Alto Garda, le prelevano campioni di DNA e le viene apposto il radiocollare. L’esame del DNA è compatibile con quello rinvenuto nel luogo dell’aggressione, a prova del fatto che KJ1 possa essere stata effettivamente l’autrice dell’aggressione.
Ultimo, triste e inevitabile atto: il 29 luglio – si dice in tarda serata - il Presidente della PAT, con un uno-due degno di Mohammed Alì, questa volta non lascia tempo alla reazione ambientalista, delibera per la terza volta la rimozione per uccisione dell’orsa e nella mattinata del 30 luglio una squadra del Corpo forestale la uccide.
LA POSIZIONE DELL’ISPRA
L’ISPRA, autore, depositario, interprete e attuatore del Piano Regionale per la Conservazione dell’Orso Bruno, segue i criteri di valutazione della pericolosità degli orsi contenuti nel piano e – a differenza di altri casi di cui abbiamo già parlato – li contestualizza, integrandoli con la “storia personale” dell’orso, fino a definirne il grado di pericolosità. KJ1, in ragione dell’evento del 16 luglio, di 68 casi di danni a cose e 7 altri incontri in cui non sembra aver dimostrato quella paura che garantisce la tranquillità degli umani[3], è classificata “ad alto rischio” e se ne consiglia l’immediata rimozione.
La rimozione, dice il Piano d’Azione – dice l’Ispra, in sostanza – può essere effettuata tramite tre opzioni di intervento:
- cattura con rilascio allo scopo di spostamento e/o radio marcaggio;
- cattura per captivazione permanente;
- abbattimento.
L’Ispra non va oltre e lascia all’Autorità, al Soggetto Decisore «di potersi muovere con adeguata autonomia per la realizzazione d'interventi il più possibile preconfigurati e codificati» evitando che «a causa di ritardi decisionali connessi ad aspetti burocratici e/o organizzativi, gli stati di crisi degenerino in situazioni che possono rivelarsi pericolose per la sicurezza e l’incolumità pubblica».
Il decisore – in questo caso - è la Provincia Autonoma di Trento, nella persona del suo Presidente.
LA POSIZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Cercando di evitare l’ovvia (e, dal mio punto di vista, giusta) retorica e polemica nei confronti di quella che appare una guerra personale del rappresentante della Provincia contro gli orsi, un'analisi lucida delle ragioni del Presidente della PAT[4] fa emergere tre criteri morali che hanno ispirato la sua azione:
- il primo criterio, espresso esplicitamente, è la sicurezza, la salvaguardia e l’incolumità di “chi vive nelle nostre valli” e “dei nostri ospiti”
- il secondo criterio che emerge è la tutela dell’economia della Provincia di Trento, in cui il turismo gioca una parte molto significativa e il “rischio orsi” può farne diminuire l’appeal
Da qualunque punto di vista, l’istanza morale del Presidente della PAT è comprensibile e condivisibile: incolumità delle persone e salvaguardia del turismo – una delle principali risorse economiche della zona[5] – sono obiettivi chiave per la politica locale a cui riesce difficile obiettare.
È interessante[6] - però - che nell’ordinanza di uccisione di KJ1 si ritrovi anche il riferimento alla «sfera soggettiva dell’animale», come valore da perseguire.
Tuttavia, la scala di valori morali del Presidente vede dichiaratamente la «vita e l’incolumità dell’uomo» come «assiologicamente superiori rispetto alla vita di un animale».
Il Presidente della PAT giustifica, quindi, in questo modo la sua scelta morale di rimuovere l’orsa dal territorio attraverso l’uccisione e non con una delle altre possibili misure: il pericolo per la vita dei cittadini e dei turisti, che è – a suo avviso - di maggior valore di quella dell’animale non umano.[7]
EPPURE C’È QUALCOSA CHE NON QUADRA
Primo: in questa storia emerge che la Scienza – impersonificata nell’Ispra, nel Piano PACOBACE e nei suoi specialisti di ambiente e di etologia – si nasconde dietro alla cortina della neutralità, fermandosi alla valutazione della pericolosità, lodevolmente contestualizzata, e al suggerimento della rimozione.
Non prende, tuttavia, posizione sul “come”: trasferimento, cattività e morte sembrano essere soluzioni alla pari, senza differenze sostanziali e morali; le conseguenze della classificazione vengono lasciate alla politica.
Viene naturale pensare che, se si trattasse di un criminale umano, neuroscienziati, psichiatri ed esperti di diverse discipline scientifiche avrebbero molto da eccepire su questa normalizzazione compiuta dall’Ispra: come dire che l’allontanamento, il carcere e la pena di morte sono la stessa cosa, decida pure il Governo cosa fare di costui!
Un’occasione persa: la scienza, l’Ispra, potrebbe bene fare un passo di più, dare indicazioni su quale delle scelte sia più opportuna, tenendo conto sia della sicurezza degli umani che della sfera soggettiva dell’animale non umano (tutelata, tra l’altro, dalla costituzione e dal Codice penale), invece che arroccarsi in questa presunta neutralità e indipendenza morale, protetta dalla disciplina e dai suoi meccanismi esatti.
Secondo: La decisione del Presidente della PAT, che presenta un lato assolutamente condivisibile (chi vorrebbe mettere a rischio i propri concittadini e la loro economia?) è apparentemente giustificata dal principio del primato della vita umana rispetto a quella animale ma, in realtà, fa una torsione di questo principio mettendo a confronto due “oggetti” non commensurabili: il rischio (ipotetico) per l’umano e la morte (certa, per decreto) dell’animale. E di questa torsione dà pure ampia giustificazione nel decreto: «La vita di un animale pericoloso, nelle circostanze date, non può che ricoprire una valenza recessiva rispetto, non tanto e non solo alla vita e all’incolumità dell’uomo, quanto piuttosto al solo pericolo latente e concreto che detto animale possa reiterare attacchi nei confronti dell’uomo stesso».
Il pericolo “latente e concreto” – ma non così concreto da essere prevedibile e inevitabile con misure diverse dalla morte - diventa – in modo perverso e ingiustificato - un termine fondamentale dell’equazione che porta all’uccisione dell’orsa e all’abbandono dei suoi piccoli.
Terzo: il 23 luglio l’orsa KJ1 era stata catturata e le era stato messo il radiocollare. Cadeva così la necessità di fare in fretta, poteva essere trattenuta, trasferita o messa in cattività.
Poteva non essere uccisa: un’altra occasione persa.
Quarto ed ultimo punto: il Presidente della PATi, con il suo uno-due – ordinanza e uccisione - tra la sera del 29 e la mattina del 30 luglio, impone il primato dell’azione di potere sopra ad ogni posizione avversa e si fa beffe della giustizia amministrativa[8], delle istanze morali di chi sostiene la causa della soggettività dell’animale, delle valutazioni scientifiche alternative e della propria stessa dialettica di stampo scientifico[9] che dovrebbe accettare il dibattito e il confronto aperto, articolato e alla luce del sole.
Ancora un’occasione persa, quella di affrontare in modo democratico la discussione tra scienza, politica e morale.
NOTE
[1] Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, un ente pubblico di ricerca, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, e di autonomia tecnica e scientifica
[2] L’istanza è stata presentata da Leal e Lav, cui si sono immediatamente uniti Aidaa, Enpa e Oipa
[3] È bizzarro: mi hanno insegnato fin da piccolo, quando iniziavo ad andare per montagne, e ho sempre pensato che dobbiamo essere noi, animali umani, ad aver paura degli orsi e dei lupi e che questa paura dovrebbe tenerci lontani da loro e dai guai, come si fa – ad esempio – in Abruzzo (vedi…)
[4] Si vedano, ad esempio: il DECRETO DEL PRESIDENTE della PAT N. 81 DI DATA 29 Luglio 2024,
[5] Il turismo trentino vale circa 1,5 miliardi di euro e rappresenta il 10% del PIL della provincia; si veda: http://www.statistica.provincia.tn.it/news/
[6] La categoria dell’”interessante” – nata nell’800 e oggi espressione meno frequente - è stata un criterio valoriale importante per tutti gli anni ’70 e ’80, soprattutto nel giudizio di lavori artistici e letterari; può essere di interesse studiarne l’origine, l’applicazione e la critica in Kierkegaard, nei “Diari del Seduttore”, di cui è indiscussa protagonista. L’“interessante”, categoria della riflessione, si delinea in quanto sorprendente, contemporaneamente armonico e disarmonico, possibilità del dis-uniforme.
[7] Dietro a questa posizione che è condivisa da molti ed ha una grande rilevanza storica e culturale c’è una storia filosofica e scientifica di secoli, che parte dall’Antica Scrittura - “Tenete sottoposti i pesci del mare e le creature volatili dei cieli e ogni creatura vivente che si muove sopra la terra” (Genesi 1:28) – evolve nella Scolastica e viene codificata dalla fisiologia cartesiana in poi. È indubbio che - quando ritenuta scientifica – abbia tratti di origine sociale, politica, religiosa.
[8] Giustizia amministrativa, il TAR, di cui la stessa Provincia dice «un baluardo di giustizia per i cittadini e spesso di giustezza dell’operato provinciale, nella convinzione che l’efficienza, la correttezza e la concretezza dell’azione amministrativo siano fattori di progresso per tutta la nostra comunità» https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/Comunicati/I-40-anni-del-Tar-di-Trento-un-baluardo-di-giustizia-per-i-cittadini
[9] Si veda ancora l’ordinanza di abbattimento DECRETO DEL PRESIDENTE della PAT N. 81 DI DATA 29 Luglio 2024
Il doppio click - Terza parte: L’università e la guerra, conoscere è valutare
PREMESSA
Lo scorso 13 giugno, presso l’Università di Pisa e come in molte altre università italiane, si è svolta una seduta straordinaria del Senato Accademico, indetta dal Rettore, sulla spinta dei movimenti studenteschi dell’ateneo che reclamano il boicottaggio delle forme di collaborazione con le università israeliane e con gli enti operanti nel settore bellico del nostro paese. [1].
L’oggetto della riunione consisteva nel prendere diverse decisioni in merito ad alcune scelte: da una parte, la sospensione temporanea di tutti questi progetti di ricerca, per sensibilizzare e dissuadere il mondo universitario e la società civile nel paese ebraico dal sostegno alle operazioni militari [2], e – dall’altra parte – l’abbandono definitivo da parte dell’ateneo pisano dei progetti suscettibili di dual use (ovvero concepiti per l’ambito civile, ma applicabili anche a quello militare).
Durante la seduta, ciascun senatore e senatrice ha presentato le proprie riflessioni riguardo alle decisioni da prendere, così si sono ben presto delineate due argomentazioni opposte.
Da un lato, molti docenti hanno espresso la propria contrarietà alle mozioni di boicottaggio, in ragione del fatto che, secondo il loro giudizio, le università di tutto il mondo, devono affermarsi come entità diverse e separate dai governi dei rispettivi paesi, poiché hanno una vocazione naturale alla diffusione delle idee e della conoscenza, e quindi alla costruzione di ponti e collaborazioni transfrontaliere per l’affermazione di rapporti di pace fra le popolazioni – un ruolo che quindi non può prevedere il boicottaggio, poiché contrario e sicuramente controproducente rispetto a questa vocazione.
Dall’altro lato, altri hanno sostenuto le mozioni, rivendicando anch’essi l’autonomia politica e amministrativa delle università, peraltro sancita dalla costituzione, ma ribadendo l’opportunità di ricorrere al boicottaggio come strumento per affermare nei confronti del contesto internazionale una forma pacifica di discredito verso l’accademia e, contestualmente, verso la società e lo stato israeliani, in opposizione alla negligenza di tanti parlamenti e governi occidentali, tra cui quello italiano.
In altre parole, si potrebbe dire che tutto il dibattito si è basato sul fatto che una parte considera l’università come un’entità indipendente rispetto allo stato in cui si trova (non solo in senso normativo, ma come constatazione di fatto), e l’altra non può fare a meno di far notare l’impossibilità di scindere gli atenei dall’apparato politico su cui sono basati e tutte le varie diramazioni sociali che li sostanziano.
UN PARALLELO CON I MODELLI A DIFFUSIONE E A TRADUZIONE
Così, in questi due partiti, ritroviamo, di riflesso, i due approcci conoscitivi presentanti nel precedente articolo, il modello a diffusione e quello a traduzione.
Seguendo il primo, infatti, in sede di riunione l’università è stata paragonata a quella comunità ideale di intellettuali cosmopoliti che hanno preceduto l’epoca dei lumi, denominata Res Publica Literarum. Come se, in fondo, la pratica accademica potesse avvenire meglio, e fosse tanto più veritiera, quanto più essa è indipendente e disinteressata rispetto ai condizionamenti esterni, ovvero quelli del potere e del denaro su tutti. Accettarli, infatti, è ammesso solo perché essi consentirebbero la sua missione liberatrice, anche se al costo di uno sporco ricatto. Perché invece, sarebbe meglio rifiutare incentivi e contributi conservando la propria autonomia, dato che questi non farebbero altro che corrompere o ostacolare la vera natura delle scoperte. Che c’entra, ad esempio, una collaborazione su un progetto di ricerca di biologia marina con la guerra? Perché interromperlo? (#lasciatelilavorare) [3].
Invece, abbiamo visto che per il modello a traduzione la scienza è sempre tecnoscienza, e che quindi la distinzione aristotelica fra téchne ed episteme è un non-senso.
Non esiste infatti il sapere “in generale” in forma distillata, ma è sempre dipendente dalla tecnica che lo produce, sia essa quella del laboratorio, dell’archivio o della pinacoteca. Quindi, il finanziamento pubblico, statale o privato, conta nel determinare il tipo di conoscenza che viene prodotta.
Infatti, non si può trascurare che uno dei settori che assorbono maggiormente la ricerca e lo sviluppo è proprio la difesa:
«la tecnoscienza è una questione essenzialmente militare … L'analogia tra corsa alla dimostrazione e corsa alle armi non è solo metaforica, ma sottende letteralmente un comune problema: vincere. Oggi non vi è esercito capace di vincere senza scienziati e solo pochi scienziati e ingegneri riuscirebbero a far vincere le proprie tesi senza l'esercito. Solo ora il lettore può rendersi conto del perché io abbia impiegato molte espressioni proprie del lessico militaresco (prove di forza, controversia, lotta, vincere e perdere, strategia e tattica, equilibrio di forze, potenziale, numero alleati), espressioni che, sebbene di continuo sulla bocca degli scienziati, vengono impiegate di rado dai filosofi per descrivere il mondo pacifico della scienza pura. Mi sono avvalso di questo lessico perché, grosso modo, la tecnoscienza è parte di una macchina da guerra e dovrebbe essere studiata come tale» (Latour B. (1998), La scienza in azione, Edizioni di Comunità, Roma/Ivrea, pp. 230-2, grassetto mio).
PER UN SAPERE RESPONSABILE E INTERESSATO
Il modello diffusionista (quello del doppio click), sembra perpetuare l’idea che il sapere sia gratuito, e così risulta essere in primo luogo un’offesa a tutti i precari della ricerca che campano con un salario appena al di sopra della soglia minima di sussistenza, come in Italia.
La realtà è che chi crede in una forma di sapere emancipato dai mezzi necessari per produrlo, vive in una condizione simile a quella – drammatica – dei soldati protagonisti del film Lebanon (Maoz, 2009), interamente ambientato all’interno di un carrarmato. Dalla propria monade, infatti, l’unico tramite per conoscere il mondo esplorato e leggere le vite degli altri è il periscopio e il grilletto, l’unica aria che permette di respirare è quella della sua pancia, stracolma di vomito, lacrime, olio e sigarette, le uniche scelte che consente sono quelle del suo stesso movimento che tiene in vita i carristi, che la guerra non vogliono farla. Questo è il senso del principio «il migliore dei mondi possibili», che sta dietro al cambio di paradigma proposto dalla prospettiva di Gaia: non esiste la possibilità che dispositivi dual use non facciano la guerra (come è stato affermato in senato accademico), solo perché esisterebbe la possibilità di tener fede a certi principi “superiori” per controllare l’utilizzo dei prodotti della ricerca. Ad ogni nuova tecnica segue sempre una nuova soggettività, un nuovo mondo di possibilità incluse e vincolanti.
Infatti, per prendersi gioco degli intellettuali e dei politici blasé che, durante la seconda guerra del golfo, sostenevano che la democrazia fosse un’idea che bastasse esportare per poter invertire le sorti dei paesi “canaglia” o “sponsor del terrorismo”, il filosofo Peter Sloterdijk ha brevettato il “parlamento gonfiabile”: come un pacco di aiuti umanitari, questo dispositivo può essere sganciato da un aereo, e nel giro di poco tempo si installa automaticamente come una cupola capiente, dotata di sedute a emiciclo, e con tutti i comfort per il pieno supporto della democrazia, che si consolida istantaneamente (Sloterdijk P. (2005), Instant Democracy: The Pneumatic Parliament®, in B. Latour, P. Wiebel (eds.), Making Things Public: Atmospheres of Democracy, MIT Press, pp. 952-55).
Allo stesso modo si può dire che un dispositivo del genere potrebbe essere attivato quando viene proposta, con squallido e ipocrito ritardo, la soluzione, “due popoli, due stati” [4]: in realtà, non sembra esserci niente che ci possa far sperare nella creazione di uno stato palestinese, per almeno i prossimi decenni, forse per generazioni intere. Su quali infrastrutture potrebbe mai sorreggersi? Quale rete di strade e ferrovie, approvvigionamento energetico e agroalimentare, cablaggi internet e per le comunicazioni, sistemi e edifici amministrativi, istituti di statistica, scuole, università, ospedali, mercati e caserme di polizia sono a disposizione, al momento, dato che almeno per quanto riguarda Gaza, il territorio è stato quasi raso al suolo? Quali comitati, associazioni, gruppi di interesse, sindacati, filiere di imprese, enti di ricerca, accordi commerciali internazionali e partiti politici potrebbero mai popolare un parlamento, e autogovernarsi, dato che un’economia ed una società politica indipendenti non possono sussistere in condizioni di occupazione permanente?
Tristemente, l’unica prospettiva immediata, all’imposizione del cessate il fuoco, è la predisposizione di sistemi di accoglienza per sfollati sotto la protezione delle Nazioni Unite, in una condizione di privazione assoluta di qualsiasi mezzo. Per questo non possiamo trascurare quelli che invece noi abbiamo a disposizione. Faticosamente conquistati affermando valori e posizioni di parte, e che ci permettono di conoscere il mondo in cui, fondamentalmente, abbiamo deciso di voler vivere.
È il caso di citare la famosa frase di Desmond Tutu, «se davanti a un'ingiustizia sei neutrale, hai scelto di stare dalla parte dell'oppressore», e allora, «se i vostri avversari vi dicono che vi state dando alla politica, prendendovi seriamente per rappresentanti di innumerevoli voci neglette, in nome del Cielo rispondete: ‘Sì certo!’. Se la politica consiste nel rappresentare la voce degli oppressi e di chi non ha volto, allora saremmo tutti in una situazione assai più rosea se – invece di pretendere che siano gli altri a impegnarsi in politica e che voi, oh, voi non vi occupate ‘che di scienza’ – riconosceste che anche voi state cercando effettivamente di assemblare un altro corpo politico e di vivere in un cosmo coerente, composto in modo differente. Se è del tutto corretto che non state parlando in nome di un’istituzione delimitata dalle frontiere degli Stati-nazione e che il fondamento della vostra autorità poggia su un sistema di elezione e di prove assai strano, è proprio questo che rende così prezioso il vostro potere politico di rappresentanza di così tanti nuovi agenti. Potere la cui importanza sarà capitale negli imminenti conflitti sulla forma del mondo e la nuova geopolitica. Non svendete questo potere di rappresentanza per un piatto di lenticchie» [5].
NOTE
[2] In analogia con quanto fatto nelle università di tanti altri paesi nel mondo, come riportato ad esempio dal sito della campagna internazionale BDS https://www.bdsitalia.org/index.php/acc-notizie/2843-mobilitazioni-studentesche
[3] Ritorniamo così all’importanza della comprensione del turismo, come espresso nel primo articolo della serie, per cogliere in parallelo anche la trasposizione in campo economico del modello a diffusione, che tende a legittimare la rendita e il guadagno facile da proventi («sogno una vita in vacanza»), specialmente di tipo finanziario, liberati da vincoli di ogni genere, che non farebbero altro che ostacolare la libera impresa e il genio inventivo dell’imprenditore (la famosa «troppa burocrazia che frena la crescita», tipo i controlli amministrativi sui mercati e lo sviluppo tecnologico, il pagamento delle imposte, dei salari ai dipendenti o il rispetto degli adempimenti nei confronti degli stakeholders).
[4] E perché non una federazione di sei stati sul modello dell’UE postbellica (Egitto, Israele, Siria, Libano, Giordania e Palestina), come proposto dal compianto Johan Galtung? (Galtung J. (2014), Affrontare il conflitto. Trascendere e trasformare, Pisa University Press, pp. 135-141).
[5] Latour B. (2020), La sfida di Gaia. Il nuovo regime climatico, Meltemi, Milano, pp. 60-1.
Cibo di alta qualità, crescita economica, salvare il pianeta o salvare gli animali? - 4 istanze morali in tensione
Due settimane fa, parlando della FAO e della controversia sulle misure più efficaci per contenere le emissioni di gas serra, abbiamo evidenziato un possibile conflitto tra l’obiettivo di diminuire significativamente la CO2 immessa nell’atmosfera e la missione della FAO stessa di garantire a tutti abbastanza cibo di alta qualità.
Nell’accezione della FAO, infatti, il cibo di alta qualità è principalmente rappresentato dalle proteine di origine animale e, quindi, ridurre le emissioni di CO2 che vengono dagli allevamenti intensivi significa mettere in crisi il meccanismo di approvvigionamento di una parte importante del cibo di alta qualità.
Questa tensione tra i due obiettivi mostra come, spesso, i problemi di carattere scientifico (il modo in cui ridurre la produzione di CO2 è indubbiamente un problema scientifico) celino una dimensione politica e, quindi, di scelte morali [1].
In questo caso, esaminando con maggiore attenzione i termini della controversia, emerge che ci sono almeno quattro obiettivi di carattere politico e morale in tensione reciproca:
- La riduzione della CO2 anche attraverso il drastico ridimensionamento dell’industria della carne [2], che fa capo all’istanza morale di “salvare il pianeta”,
- La garanzia che tutti abbiano sufficiente cibo di alta qualità, che fa capo all’istanza morale di “salvare le persone umane” dalla fame e dagli effetti negativi che derivano da una alimentazione insufficiente o troppo povera,
- La salvaguardia dell’economia e dell’occupazione delle sfere sociali in cui operano i produttori di carne, la cui istanza morale può essere riassunta in “garantire lavoro e sussistenza”,
- L’attenzione alla vita e al benessere degli animali non umani, importante per una sempre più diffusa sensibilità la cui istanza morale di riferimento è “non uccidere e non far soffrire tutti gli animali”.
In modo molto schematico e semplificato, la tensione reciproca tra le 4 istanze morali è abbastanza evidente considerando gli effetti della riduzione degli allevamenti:
- ridurre significativamente gli allevamenti (e la CO2 che producono) può generare crisi economica e disoccupazione, almeno nel breve periodo e, contestualmente, ridurre la disponibilità di cibo di alta qualità per chi ne ha bisogno
- mantenere in continuità gli allevamenti con la conseguente stabilità economica e occupazionale, può – invece – impedire il raggiungimento degli obiettivi di contenimento della CO2 e (senza può) provoca morte e sofferenza a milioni di animali non umani (bovini, ovini e suini)
A queste 4 istanze morali va aggiunta quella del rispetto e della continuità delle tradizioni, tra cui quelle alimentari, che includono – spesso – il consumo di carne, abitudinario o addirittura con sfumature rituali (ad esempio, il Sunday Roast in Gran Bretagna, il capitone a Natale e l’agnello a Pasqua in Italia, il tacchino per il Thanksgiving negli US ecc.), che complica ulteriormente il quadro.
Questa contrapposizione di obiettivi mostra chiaramente come, dietro una questione scientifica (il maggiore o minore valore della CO2 da allevamenti), si ponga la necessità di fare delle scelte morali, di determinare quali siano le priorità da assegnare alle diverse opzioni e ai diversi obiettivi, cosa sia più importante, quale sia il valore da collocare in cima alla scala.
E, ancora una volta, mostra che le scienze e il lavoro scientifico non siano neutrali ma
- influenzate da istanze sociali, politiche e morali; l’interpretazione riduttiva del tasso di CO2 legato agli allevamenti intensivi, in questo caso, può essere stato influenzato da considerazioni di natura economica, occupazionale e alimentare
- politicamente e socialmente attive; in questo caso, ancora, la lettura della FAO ha orientato l’agenda politica e ambientale in direzione diversa da quella della riduzione dell’allevamento di animali da carne
È, perciò, opportuno non credere alla presunta obiettività e neutralità delle scienza ma – riconoscendone la rilevanza per la vita di tutti e senza cadere in forme di critica distruttiva – fare attenzione alle implicazioni sociali, politiche e morali che esse sottendono.
--------
A ben vedere, inoltre, queste contrapposizioni tra istanze morali che, prese una alla volta, sono tutte ampiamente condivisibili (chi non vuole salvare la Terra? E chi non vorrebbe eliminare la fame dal mondo? E chi si opporrebbe ad una economia florida e con meno disoccupazione? A chi piace veder soffrire e morire animali innocenti?) sono ben rappresentate tra gli organismi sovranazionali che, in particolare, fanno capo alle Nazioni Unite:
- la FAO – che ha la missione di assicurare cibo sufficiente e di qualità per tutti
- l’UNEP – che lavora a favore della tutela dell’ambiente e della sostenibilità
- la WOAH – che si occupa della salute e del benessere degli animali non umani
- l’ILO – organizzazione internazionale per il lavoro, con il fine di creare maggiori opportunità di occupazione e redito dignitosi
- la Banca Mondiale e il Fondo Monetario Internazionale – che dovrebbero impegnarsi per uno sviluppo equo ed equilibrato di tutte le nazioni
Organismi e obiettivi in tensione o, addirittura, in parziale conflitto tra loro. Come si possono – quindi – armonizzare agende [3] tanto diverse tra loro?
Un primo passopotrebbe essere quello di abbattere una sorta di tabù, quello dell’identificazione del cibo di alta qualità con la carne animale seguendo, ad esempio, le linee guida del Rapporto EAT – Lancet, che indica vie alternative (e spesso a minor costo) di alimentazione ricca e completa. Se la FAO adottasse questo punto di vista uno dei termini di opposizione si eliminerebbe.
Un secondo passo potrebbe essere, conseguenza del primo, l’adozione di una politica di progressiva trasformazione dell’economia dell’allevamento in economia della produzione e trattamento dei cereali per alimentazione umana, con misure di sostegno eco-finanziario da parte della Banca Mondiale, e con risultati efficaci per la salvaguardia dell’ambiente (meno CO2), del benessere di animali umani (meno rischi cardiaci) e non umani (meno sofferenze e morti).
Inoltre, eludendo la difficoltà di armonizzare politiche mondiali, potrebbe essere opportuno focalizzare gli interventi su aree micro economiche ed ambientali, in cui le misure di contenimento delle emissioni di CO2 possono essere orientate in modo mirato e gli interventi per la trasformazione ambientale, alimentare e produttiva possono essere sostenuti in modo più efficace, creando esperienze pilota e buone pratiche da diffondere.
Sempre con un occhio attento alle relazioni tra scienze, società, morale e politica, e con le orecchie aperte alle istanze minoritarie – anche quelle scientifiche – che possono alimentare l’innovatività e le soluzioni meno ovvie.
NOTE
[1] In modo molto semplificato, possiamo definire scelta morale una scelta fatta in modo consapevole sulla base di esperienze, convinzioni e scale di priorità e di valori. Per fare queste scelte usiamo, infatti, quello che sappiamo, quello che abbiamo provato, quello che ci ha insegnato se la scelta ci farà bene o male; per sapere se quello che accadrà ci farà bene o male usiamo l’esperienza del piacere e del dolore; per discernere tra piacere e dolore utilizziamo una scala di valori, cioè una classifica di cosa fa più bene o più male.
[2] Soprattutto bovina, cfr. Pathways towards lower emissions. A global assessment of the greenhouse gas emissions and mitigation options from livestock agrifood systems, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, 2023, ISBN 978-92-5-138448-0, si può scaricare qui, p. 12
[3] Qualcosa, in questo senso, è stato fatto: si tratta di ONE HEALTH un approccio integrato alla salute umana, animale e ambientale, che coinvolge la FAO, la WHO e la WOAH, e che – per ora – consiste in un gruppo trasversale di esperti costituito nel 2021 con l’obiettivo di sviluppare un punto di vista olistico su salute e ambiente e di fornire consulenza su questo tema alle Agenzie che lo formano. Questo approccio sembra essere, tuttavia, molto orientato alla tutela della salute umana.
Un fiume norvegese, il governo e dei pescatori tradizionali - La conoscenza scientifica come forma di colonialismo?
Noi occidentali abbiamo imparato a dare per scontato che la conoscenza scientifica abbia un primato epistemologico sulle altre forme di conoscenza. Ma esistono anche delle conoscenze tradizionali che non sono formalizzate in teorie, concetti specifici, ma che possono avere una forte presa sulla realtà.
------------
Nel saggio “Indigeneity, science and difference: notes on the politics of how”, John Law e Solveig Joks (2019) analizzano una controversia coloniale riguardante la regolamentazione della pesca del salmone nel fiume Deatnu.
Da un lato c’è il governo norvegese che, con i suoi ricercatori e biologi, vuole imporre delle norme per preservare le popolazioni di salmoni attraverso la riduzione delle attività di pesca. Secondo il governo e i ricercatori, gli obiettivi di stoccaggio non venivano raggiunti e il numero di salmoni stava diminuendo.
Questo gruppo di scienziati finlandesi e norvegesi aveva raccolto statistiche, modellato stock ittici ed eseguito proiezioni demografiche; sulla base di questi elementi aveva elaborato delle regole rigide su chi può e chi non può pescare in questo fiume scandinavo, con quali tecniche, in quali periodi e in quale ora del giorno. Queste norme sono il prodotto di statistiche e proiezioni biologiche sulla popolazione ittica.
Dall’altro lato ci sono le popolazioni indigene dei Sàmi che abitano sulle rive del fiume: i Sami conoscono come si comporta il livello dell'acqua nella sua loro parte di Deatnu, conoscono l'ora del giorno più propizia, il momento della stagione più favorevole per pescare, le predisposizioni dei vari tipi di salmone, e come incidono la temperatura, il sole, il vento, la pioggia e la neve sulla pesca.
In altre parole, hanno pratiche e concezioni diverse del fiume e del salmone.
Inoltre, la cautela e il rispetto per il fiume e per il salmone, il senso del luogo, la modestia, sono valori fondamentali che orientano la loro pratica di pesca; ad esempio, non pescano più salmone del necessario, non contano i pesci che catturano (farlo sarebbe irrispettoso) e non pescano quando i salmoni stanno per riprodursi. Fanno affidamento su un tipo di conoscenza caratterizzata da un'avversione per le statistiche. Anche i pescatori Sàmi si preoccupano per il salmone, solo che non lavorano con i numeri, ma si chiedono: arriverà il salmone? Continueranno ad arrivare? E, se ne arrivano meno, perché?
Nonostante ciò, il governo norvegese ha adottato le norme prodotte dal gruppo di scienziati riducendo i periodi di pesca da 11 (nel 2016) a 4 (nel 2017).
Queste regole - però - impedivano ai Sami di pescare quando le condizioni erano giuste, oppure glielo impedivano in un’altra parte del fiume anche se lì le condizioni sono giuste ma non in quella dove loro abitavano; impedivano di pescare anche se lo stato del tempo e del fiume sono ottimali, o le attività degli altri pescatori e l’ottima pesca dell’ultimo periodo hanno fatto capire loro che quello è un buon momento per pescare.
-------------
Il punto è che queste regole ignorano le competenze delle popolazioni locali e la loro più profonda preparazione perché le costringe a pescare in orari predeterminati e, a volte, inappropriati; oppure permettono di pescare quando invece non si può perché non c’è nessuno che ti può aiutare con le reti, oppure perchè l’acqua è troppo bassa o alta.
Gli autori dello studio mettono in luce l’asimmetria di potere tra le pratiche della biologia e le conoscenze ecologiche tradizionali dei Sami. La scienza dei biologi e ricercatori si basa sulla raccolta e l’elaborazione rigorosa di dati sistematici all'interno di un modello o ipotesi di ricerca, in grado di produrre un tipo di conoscenza oggettiva.
Quella dei Sàmi, invece, è un tipo di conoscenza in gran parte basata sull’esperienza, orale e visiva, intuitiva, e altamente qualitativa. Proprio per questo motivo viene marginalizzata.
Questo produce degli effetti più ampi.
In primo luogo, con la pesca limitata a quattro periodi all’anno, diventerà quasi impossibile per i giovani Sami imparare l’arte della pesca tradizionale, e questo la farà piano piano scomparire, insieme a quell’insieme di saperi e conoscenze sul come controllare una barca e maneggiare una rete, ma anche su come funziona il fiume, dove scorrono i canali profondi, dove è probabile che nuotino i salmoni. Tutto ciò richiede tempo, pazienza e pratica, ma con l’introduzione di queste regole tutto ciò viene loro tolto.
In secondo luogo, la scelta di adottare quelle norme ha una forte dimensione politica. Siamo di fronte a due modi differenti di assemblare la realtà. La modellazione scientifica della pesca mette in scena un modello fatto di meccanismi causali standard per spiegare le specificità di particolari fiumi, popolazioni e tassi di sfruttamento. In questo mondo non c’è spazio per le pratiche di pesca Sámi.
Gli autori parlano di un “soffocamento ontologico”, da parte del mondo delle regole che ignora le contingenze tradizionali dei locali e mette in atto un altro tipo di realtà. I modelli degli scienziati mettono in pratica una logica di colonizzazione perché presumono che esista un unico mondo “scopribile” attraverso meccanismi e/o correlazioni.
Ma questo tipo di rappresentazione non lascia spazi per storie, realtà e conoscenza alternative.
Sembra evidente che, a volte, la conoscenza scientifica ha lo stesso effetto del colonialismo sui Paesi che sono diventati colonie, cioè l’imposizione di un modo di pensare alla realtà in aperto contrasto e incompatibile con gli stili di vita tradizionali.
L’idea dell’oggettività, dello sguardo da nessun luogo non è realistica, I laboratory studies (Latour e Woolgar 1979; Knorr Cetina 1997) hanno mostrato come l’oggettività venga prodotta attraverso una continua manipolazione degli oggetti.
In questo caso abbiamo una ontologia, quella degli scienziati e biologi, che viene sovrapposta all’ontologia dei Sàmi.
I Sami hanno, infatti, una visione di cos’è oggettivo, ma la scienza impone una realtà divergente, che poi propone alla politica e pretende che sia implementata.
CONCLUSIONE
Nel momento in cui le norme vengono implementate si genera un circolo vizioso, in cui alcuni scienziati possono giustificare le proprie pratiche con frasi del tipo “eh ma sono scelte politiche”. Allo stesso tempo, la politica, implementando quel tipo di decisioni può deresponsabilizzarsi, attraverso il famoso mantra “lo dice la scienza”. La scienza fornisce una importante legittimazione alle scelte politiche a causa della sua autorità epistemica sulle altre forme di sapere, ma proprio per questo motivo non può rivendicare una neutralità perchè le decisioni prese producono degli effetti.
La scienza è una pratica sociale che crea un tipo di realtà e, spesso attraverso la politica, la mette in atto. Non c’è spazio per altre versioni. La natura viene rappresentata come un'unica realtà modellata da meccanismi generali che possono essere individuati dai ricercatori, mentre la cultura viene vista come multipla, soggettiva e normativa.
La sfida non è convincere le popolazioni Sami che la conoscenza scientifica è epistemicamente superiore, ma piuttosto fare in modo che la conoscenza dei Sami venga integrata nella scienza. La necessità è quella di creare pratiche materiali concrete che avvicinino gli uffici, i laboratori, i modelli biologici dei “coloni” alle pratiche locali dei Sámi.
Nel caso specifico la direzione potrebbe essere quella di “ammorbidire” il realismo della biologia.
BIBLIOGRAFIA
Knorr-Cetina K. (1997), Sociality with Objects. Theory, Culture and Society 14 (4):1-30.
Latour B. e Woolgar S. (1979), Laboratory life: The construction of scientific facts, Princeton University Press, Princeton.
Law, J., & Joks, S. (2019). Indigeneity, Science, and Difference: Notes on the Politics of How. Science, Technology, & Human Values, 44(3), 424-447.
Avanti verso il nulla - Sul futurismo nichilista contemporaneo (prima parte)
La nave
ha anche un motore
e avendo un motore
non sa dove va ma continua a andare
(Giorgio Gaber, La nave, 1974)
Cosa diremmo di una persona che, magari a causa di un trauma o di un lutto, vivesse concentrata sul passato e rifiutasse di vivere il presente e fosse del tutto chiusa alla dimensione del futuro? Certo, che non sta bene. Non si può vivere decentemente così. E di una che, specularmente, fosse proiettata esclusivamente verso il futuro e le future realizzazioni, incapace di vivere nel presente, e di tenere in conto a maggior ragione delle esperienze del passato? Anche in questo caso, diremmo che soffrirebbe, che non sarebbe in grado di godere della vita, la quale in fondo è fatta di una serie di momenti presenti. Se fossimo in un contesto di psicologia individuale potremmo parlare nel primo caso di un disagio dovuto a una forma di malinconia, nel secondo a una forma di euforia maniacale.
Spostandoci sul terreno del carattere sociale,[1] abbiamo da una parte un orientamento “passatista”, fissato cioè a un passato ritenuto in quanto tale preferibile e incline, dunque, al misoneismo (al rifiuto cioè di ogni novità), tipico delle società preindustriali; dall’altro un orientamento futuro-centrico, “futurista”, altrettanto nevroticamente fissato all’esaltazione del dileguare di ogni cosa in favore di un “nuovo” in quanto tale certamente migliore. Quest’ultimo è propriamente il carattere dell’epoca che viviamo in particolare nelle società più avanzate, segnate dal predominio dispotico di un potere che è insieme tecnico e capitalistico. Il dogma di oggi dice che «il futuro è il posto migliore»;[2] ed è di tale dogma, non meno contestabile per il fatto di essere… moderno, che si parlerà in questo articolo.
Il documento da cui propongo di prendere le mosse è la fulminante dichiarazione dell’ingegnere informatico Yann LeCun, capo del team di Meta (il nuovo nome di Facebook) che si occupa di intelligenza artificiale, nel corso di un’intervista rilasciata a un quotidiano italiano: «Mi affascina il futuro. Del presente mi interessa capire solo gli sbagli e come superarli».[3] Una frase che può essere considerata un “concentrato” di un più generale modo di rapportarsi alla temporalità che la società attuale suggerisce e impone ogni giorno nel suo «monologo elogiativo» permanente.[4] Il dirigente di Meta, che risponde in questo modo alle caute preoccupazioni espresse dall’intervistatore sulle prospettive dell’IA, com’è chiaro, non dichiara solo di essere affascinato dal futuro, ma di trascurare e disprezzare il presente (del passato naturalmente neppure parla), in quanto – sembra di capire – unicamente luogo di passaggio verso l’unica meta interessante, appunto il futuro. Ma c’è un problema: quella meta, una volta divenuta presente (ogni futuro di oggi è il presente di domani), ricadrà nello stesso disinteresse, in favore del futuro di domani. E in verità una meta non c’è neppure: c’è solo quella che potremmo chiamare una fuga senza fine verso il nulla, o «furia del dileguare» – per usare una espressione hegeliana[5] – per la quale ogni momento presente non vale che in quanto preparazione di un momento futuro, che sarà ovviamente migliore, e così via all’infinito.
Ha osservato il filosofo tedesco-coreano Byung-Chul Han, in un bel libro dedicato alla Scomparsa dei riti, che «oggi al tempo manca una struttura stabile. Non è una casa, bensì un flusso incostante: si riduce a una mera sequenza di presente episodico, precipita in avanti». (La scomparsa dei riti. Una topologia del presente, Milano, Nottetempo, 2021, p. 13).
Si procede, dunque, sempre “avanti” e sempre più rapidamente, in un fenomeno di accelerazione sociale che è oggetto di crescente attenzione da parte delle scienze sociali.[6] In questo illimitato e davvero scriteriato procedere, nessun valore, nessun obiettivo, nessuna condizione desiderabili debbono essere posti, perseguiti, mantenuti; l’unica cosa che conta e che deve esistere, l’unico punto di riferimento per il nostro agire, è il costante flusso delle merci, ma anche delle esperienze, delle tecniche, delle forme di vita:[7] una condizione, dunque, realmente nichilista.
È una dinamica che era stata a suo tempo già individuata da Marx, che pure non si era soffermato sugli esiti nichilistici qui indicati, quando aveva rilevato che «il movimento del capitale è senza misura» (Marx K., Il capitale, libro I, a cura di Delio Cantimori, Roma, Editori Riuniti, 1974, p. 185).
-------------
In questa modalità di rapporto con il tempo, che nasce nel quadro della modernità capitalistica e della sua complessiva rimodulazione dell’esperienza e della vita sociale, accade – secondo quanto sottolineato trent’anni fa da Giacomo Marramao – che «la prospettiva tende progressivamente a fagocitare l’esperienza» (Giacomo Marramao, Minima temporalia. Tempo spazio esperienza, Milano, Il Saggiatore, 1990, p. 108), potendosi parlare di vera e propria «propensione nichilista» (cit. p. 104) della modernità. Mi pare tuttavia evidente che è l’ultima fase della modernità, quella apertasi negli ultimi decenni, a rendere egemone e “totalitaria” tale propensione. E l’accelerazione dell’innovazione tecnologica in molti ambiti, in quello informatico in particolare, ha avuto in questo un ruolo determinante.
Ha osservato a questo proposito Gabriele Balbi, in un notevole recente pamphlet sulla ideologia digitale, che «il tempo storico ideale per la rivoluzione digitale è proprio il futuro, anche perché nel presente viene sempre raccontata come incompleta, come un processo in continua evoluzione, come una trasformazione che non ha né può avere una fine predefinita» (Balbi G., L’ultima ideologia. Breve storia della rivoluzione digitale, Roma-Bari, Laterza, 2022, p. 64-65). Non sorprende, allora, che un recentissimo saggio sulle prospettive dell’applicazione dell’intelligenza artificiale si dichiari in copertina – programmaticamente – una Apologia del futuro (De Biase L, Apologia del futuro. Quello che il domani può fare per noi, Roma, LUISS University Press, 2024).
Il tempo dell’era digitale, in effetti, è proprio un tempo della precarietà e dell’incompletezza, foriero inevitabilmente di ansia e di senso di inadeguatezza, forse proprio di quella «vergogna prometeica» indicata da Günther Anders come il portato principale e perturbante della nostra epoca di dominio della tecnica industriale (fa parte di essa non solo il sentirsi inferiori in potenza alle macchine, ma anche, insieme, il sentirsi troppo lenti rispetto alle velocità macchiniche).[8]
Non mancano del resto alcuni sintomi addirittura clamorosi di tale deriva, se pensiamo per esempio a certi esiti obiettivamente antiumanistici propri di quelle visioni della rivoluzione digitale che si dichiarano post- o transumaniste. Così per esempio Hans Moravec, uno dei profeti del transumanismo, poteva affermare già vent’anni fa, in relazione agli imminenti sviluppi delle nanotecnologie e dell’intelligenza artificiale, con un misto di fatalismo e di entusiasmo: «l’uomo biologico si troverebbe naturalmente spinto fuori dall’esistenza, poiché una specie sopravvive raramente a uno spazio ostile che presenta un grado di evoluzione superiore» (cit. in Paul Virilio, Ce qui arrive, Paris, Éditions Galilée, 2002, tr.it. Milano, Cortina, 2002, p. 19-20).
Al venir meno di ogni valore, di ogni capacità di identificare dei fini razionali nello sviluppo sociale, si accompagna come si vede, in non pochi casi, il rifiuto della umanità stessa. O meglio quella che – se si pensa a certo dibattito oggi molto in voga sull’IA – si potrebbe definire una voglia matta di dimissioni dall’umano.
-------------
In ogni caso, quel che qui mette conto sottolineare è che nella visione attuale dovremmo affidarci con sicurezza all’impersonale flusso delle cose, alle asserite leggi dello sviluppo tecno-scientifico, sicuri che esse siano apportatrici di beneficio generale. Una visione del mondo e della storia non solo falsa, dal momento che postula una natura neutrale e deterministica dello sviluppo tecnologico (come se esso non fosse attraversato dalla storia, dal conflitto degli interessi, dalle dinamiche economiche, da influssi culturali ecc.), ma chiaramente finalizzata a radicare nelle coscienze dei contemporanei un senso di stupido ottimismo e di cieca fiducia verso l’organizzazione sociale presente. Una pedagogia dell’apatia e della passività, in definitiva.
L’adesione a questo “regime di temporalità” implica infatti l’adesione al modello economico e sociale dominante, a quello che un sociologo italiano, Mauro Magatti, ha definito «capitalismo tecno-nichilista», ovvero un modello in cui la razionalità strumentale e l’imperativo del profitto hanno riassorbito senza residui ogni altro criterio.[9] Tale modello, che si forma a partire dall’ultimo quarto del Novecento, prima negli Stati Uniti poi in Europa, non ha più molto a che fare con il vecchio capitalismo “weberiano” (lavoro, disciplina, impegno, attaccamento alla proprietà…), ma è piuttosto un capitalismo del desiderio e della seduzione, nonché della liberazione attraverso la tecnica. Un capitalismo che promette all’individuo una generalizzata libertà (di natura peraltro fantastica e delirante) un po’ da tutto: dal lavoro faticoso, dalla politica, dalle relazioni sociali e sentimentali, ora perfino – nelle tecno-utopie postumaniste, come si vedeva poc’anzi – dalla materia e dalla biologia stesse. Ma navigando in questo insieme di… “liberazioni” da ogni radicamento, è l’umano stesso che abdica a se stesso, l’individuo stesso, apparentemente celebrato, che finisce per precipitare appunto nel nulla.
Sulla dimensione realmente nichilistica del capitalismo contemporaneo (cioè dove per nichilismo non si intende una ideologia o una dottrina, ma appunto una configurazione socio-culturale reale) è intervenuto nei suoi ultimi anni il filosofo Aldo Masullo (1923-2020):
«la condizione del nostro odierno esistere esige non tanto una discussione sull’essenza del nichilismo, quanto un’esplorazione di effettivi stati di nichilismo. (…) Uno dei sintomi è la profonda trasformazione dei nostri rapporti con il tempo. Oggi la velocizzazione dei cambiamenti (travolgente esito tecnologico), l’accelerazione del quotidiano, l’immediatezza del repentino, insomma il dissolversi della durata nel delirio di eventi puntiformi, esaltano l’istantaneo senza ragione e il vuoto del presente».[10]
Particolarmente radicato in ambito scientifico-tecnologico,[11] questo approccio alla temporalità dilaga in realtà in ogni campo della vita odierna (sempre più permeato del resto dalla macchina tecno-scientifica e dalle sue “esigenze”), spingendoci tutti in una dimensione di accelerazione permanente i cui effetti in termini di disagio crescente sono ormai oggetto di un’ampia letteratura sociologica, psicoanalitica, antropologica ecc.,[12] oltre ad essere stati denunciati nella celebre enciclica Laudato si’ di Papa Francesco con parole molto lucide.[13]
-------------
In un piccolo saggio dedicato al concetto di Futuro, Marc Augé ha rimarcato il nesso che nella percezione attuale del futuro ricopre la dimensione (tipica di società industriali avanzate e consumistiche) della “innovazione”: quest’ultima – sosteneva l’antropologo francese scomparso nel 2023 – costituisce un vero e proprio «fatto sociale totale», secondo la celebre definizione di Marcel Mauss, poiché «riguarda simultaneamente tutti gli aspetti della società e fa appello a tutti i suoi attori» (Augé M., Futuro, Torino, Bollati Boringhieri, 2012, p. 81).[14] È insomma un futuro-come-innovazione quello che risulta oggi socialmente egemone, un futuro come costante susseguirsi di novità (proprio come l’industria capitalistica deve perennemente presentare nuove merci, vere o presunte non importa), un futuro meramente quantitativo. Un futuro che – dicono molti osservatori – finisce per farsi fagocitare da se stesso, e dunque un futuro che, paradossalmente, si auto sopprime in favore di un eterno presente (così François Hartog, su cui si tornerà, che parla infatti di «presentismo» per indicare l’attuale «regime di storicità»)[15].
È chiaro che stiamo parlando di quale idea di progresso sia oggi dominante; ovvero di come questa idea, così intimamente legata a tutta la vicenda della modernità occidentale, si configuri nella società industriale avanzata di oggi (o forse dovremmo dire, per essere à la page, società digitale). Se questa furia “futuristica” di cui abbiamo parlato appare oggi così dominante e in sostanza accettata è anche perché il mito del progresso è uno di quelli cui, nel disincantamento generalizzato, ancora crediamo (paradossi del postmodernismo? Forse…). Ma, giunto a questo punto, per non abusare della pazienza del lettore, rimando alla seconda parte di questo articolo. Stay tuned.
NOTE
[1] Uso qui il concetto di “carattere sociale” come inteso tra gli altri da Erich Fromm, per esempio, in Beyond the chains of illusion. My encounter with Marx and Freud (1962), tr.it. Marx e Freud, Milano, il Saggiatore, 1968, p. 75-92. Vedi anche la voce Carattere sociale, in Luciano Gallino, Dizionario di sociologia, Torino, Utet, 2014 (1.ed. 1978), p. 94-96.
[2] Così, dovendo proporre una serie di scritti e discorsi di Barack Obama al termine del suo secondo mandato presidenziale, una grande casa editrice italiana decide di intitolare il volume che li raccoglie: Barack Obama, Il futuro è il posto migliore. Il 44. Presidente degli Stati Uniti in parole sue, prefazione di Walter Veltroni, Milano, Rizzoli ETAS, 2017.
[3] La dichiarazione del manager di Meta si trova in: Pierluigi Pisa, Arriva la nuova IA di Meta. “Imparerà da sola, penserà e proverà emozioni umane”, “la Repubblica”, 14 giugno 2023, p. 32-33.
[4] L’espressione si deve a Guy Debord, nella Società dello spettacolo (1967): «Lo spettacolo è il discorso ininterrotto che l’ordine presente tiene su se stesso, il suo monologo elogiativo» (Guy Debord, La società dello spettacolo, in Id., La società dello spettacolo. Commentari sulla società dello spettacolo, introduzione di Carlo Freccero e Daniela Strumia, Milano, Baldini & Castoldi, 2019, p. 71-72).
[5] Il concetto di «furia del dileguare» [die Furie des Verschwindens], coniato da Hegel nella Fenomenologia dello spirito (Cfr. G.W.F. Hegel, Fenomenologia dello spirito, vol. II, trad. di Enrico De Negri, Firenze, La Nuova Italia, 1963, p. 129) con riferimento agli esiti utopistico-estremistici della Rivoluzione francese (dove alla «libertà assoluta» non resta che «l’operare negativo» che non s’acquieta mai, producendo catastrofi politiche), viene qui adottato per indicare la pulsione intima dell’Occidente capitalistico, che lo spinge (ci spinge) ad operare solo in senso negativo e dissolvente, senza alcun costrutto sensato ed equilibrato.
[6] Mi limito qui a citare Hartmut Rosa, Accelerazione e alienazione. Per una teoria critica del tempo nella tarda modernità, Torino, Einaudi, 2015.
[7] Osservava David Harvey, in un saggio ormai di riferimento su questi temi, The condition of postmodernity (1990): «La dinamica di una società “usa e getta”, come l’hanno definita scrittori come Alvin Toffler, cominciò a diventare evidente durante gli anni Sessanta. Significava qualcosa di più del semplice buttar via una cera quantità di prodotti (…); significava buttar via valori, stili di vita, relazioni stabili, e l’attaccamento alle cose, agli edifici, ai luoghi, alle persone, ai modi ereditati di fare ed essere» (David Harvey, La crisi della modernità, Milano, il Saggiatore, 1993, p. 349).
[8] Cfr. Günther Anders, L’uomo è antiquato.1. Considerazioni sull’anima nell’epoca della seconda rivoluzione industriale, Torino, Bollati Boringhieri, 2003, p. 37-120.
[9] Cfr. Magatti M., Libertà immaginaria. Le illusioni del capitalismo tecno-nichilista, Milano, Feltrinelli, 2009.
[10] Nell’intervista il grande filosofo italiano riassumeva le tesi del suo Stati di nichilismo, Roma-Napoli, Paparo, 2016.
Ricordiamo che, nella filosofia italiana contemporanea, sostenitori della tesi del nichilismo come condizione storico-sociale del modo di produzione capitalistico sono stati Costanzo Preve, in particolare in Il convitato di pietra. Saggio su marxismo e nichilismo (Milano, Vangelista, 1991), e Massimo Bontempelli, La conoscenza del bene e del male, Pistoia, CRT, 1998.
[11] Giampietro Gobo ha sottolineato di recente su questo blog come l’accelerazione sociale dominante sia dannosa per la stessa attività scientifica: cfr. Giampietro Gobo, Quando la pazienza è più produttiva della fretta. Sull’esistenza di un nuovo pianeta, “Controversie”, 07/05/2024,
[12] Cfr. Hartmut Rosa, Accelerazione e alienazione, cit.
[13] «La continua accelerazione dei cambiamenti dell’umanità e del pianeta si unisce oggi all’intensificazione dei ritmi di vita e di lavoro, in quella che in spagnolo alcuni chiamano “rapidación” (rapidizzazione). Benché il cambiamento faccia parte della dinamica dei sistemi complessi, la velocità che le azioni umane gli impongono oggi contrasta con la naturale lentezza dell’evoluzione biologica» (Papa Francesco, Laudato si’. Lettera enciclica sulla cura della casa comune, commenti di Bruno Bignami, Luis Infanti de la Mora, Vittorio Prodi, Bologna, Edizioni Dehoniane, 2015, p. 19).
[14] Nelle società attuali – osserva ancora Augé – «potremmo dire che ormai siamo capaci di definire il nostro rapporto con lo spazio e il tempo, cioè con l’elemento essenziale dell’attività simbolica che definisce l’essenza dell’uomo e dell’umanità, solo attraverso artefatti messi a punto dall’industria e fatti circolare su mercato» (ivi, p. 78).
[15] Cfr. François Hartog, Regimi di storicità. Presentismo e esperienze del tempo, Palermo, Sellerio, 2007.