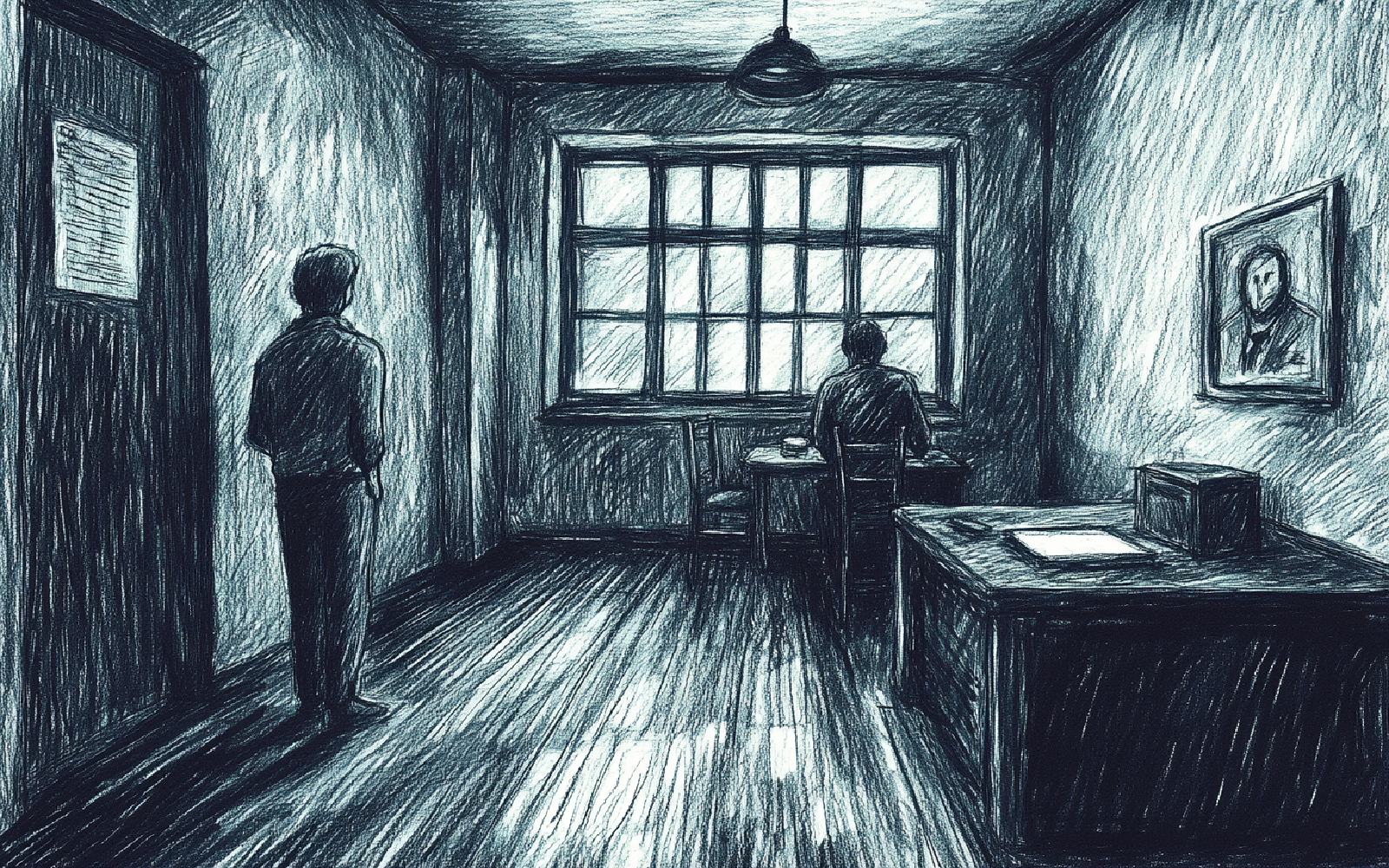Epistemologia e clinica (oltre la politica) in Franco Basaglia
“Basaglia” è il nome di una rivoluzione quasi universalmente riconosciuta, anche se poco o nulla applicata fuori dall’Italia. I dibattiti sulla legge 180, sulle sue luci impossibili da spegnere, ma anche sui suoi limiti attuali, si susseguono ciclicamente. Spesso il Basaglia clinico tende a essere offuscato dalla, giustamente celebre, portata politica della sua battaglia e del suo gesto. Eppure, clinica e politica, in lui, sono legati.
Figlio della tradizione della psichiatria fenomenologica, esistenziale, dasein-analitica, in lui sono costanti i riferimenti a pensatori ritenuti fondamentali fino agli anni 60’-70’, e oggi un po’ in ombra, come Sartre, Heidegger, Merlau-Ponty, Husserl, Biswanger. Autori politici, ognuno a suo modo, da cui Basaglia trarrà i propri echi; correnti di pensiero appunto, non solo strettamente filosofiche, tali da investire tutti i campi delle scienze cosiddette “umane”.
La psichiatria è chiaramente una scienza limite, avendo come oggetto qualcosa di eternamente sfuggente come l’umano, rimanendo con un piede o entrambi, all’interno di un’altra scienza limite, cioè la medicina.
Medicina: sapere, tecnica, che unisce arte, nel senso ippocratico, e scienza transitata nella cornice del moderno. E sullo psi della iatreia (cura), su cosa sia o come sia quella psyché a salire fino alla nostra “psiche” o “mente” la risposta non è definitiva.
Tantomeno sulle sue malattie e le sue cure. Ne consegue che teoria e prassi, epistemologia e azione sono indissociabili; di qui, il problema storico, sociologico e infine politico non cesserà mai di ripresentarsi.
In Un problema di psichiatria istituzionale e testi vicini (L’ideologia del corpo, Corpo, sguardo e silenzio, ecc), l’originalità dell’intreccio che presenta Basaglia è evidente: emerge una teoria della clinica come specchio di una teoria politico-critica.
Il sottotitolo è eloquente: L’esclusione come categoria socio-psichiatrica. Da un punto di vista di filosofia politica, o anche socio-antropologico, la categoria dell’escluso è inerente a ogni società, e in particolare in quelle dove siano presenti divisioni gerarchiche.
Il capro espiatorio è quel “dispositivo” (politico, sociologico, antropologico) in cui le contraddizioni di una società vanno a concretizzarsi, scaricando l’aggressività che esse comportano.
Ma il malato mentale ha una sua peculiarità: egli è posto fuori dalla dialettica. Quelli che oggi chiameremmo “gruppi marginalizzati” hanno sempre avuto un potenziale attivo di rivolta. Il malato mentale è una figura più enigmatica: se Foucault voleva dare parola alla follia, è perché essa non parla mai in modo univoco, e dunque è al confine col silenzio; ma se il malato mentale è ridotto all’espressione della propria malattia, confine sempre aperto, la sua stessa parola sarà puro silenzio.
Così funziona la realtà di quest’esclusione peculiare: ogni parola di risposta, di tentativo di dialettica, è nuovo rinforzo, motivo per prolungare l’esclusione.
Il tutto comporta per Basaglia, che egli è all’interno della sua stessa epistemologia, cioè nel dispositivo per dire e poi curare, trattare, la follia come malattia mentale. Comporta che la psichiatria può trovare le leve per dialettizzare il malato. Le parole quasi d’ordine dell’impianto degli autori sopracitati sono imperniate intorno alla soggettività, alla libertà, al corpo, alla scelta.
Il problema centrale per quest’approccio è la questione della scelta, scelta di sé come libertà e dell’angoscia che questa comporta, eco esistenzialista, la cui difesa primigenia è l’esclusione. Ma non solo: l’altro da sé è anche la propria “fattità”.
Fattità che si è come corpo, “corpo oggettuale”, opacità, passività, nonché soggetto delle percezioni, corporeità con cui si è nel mondo (Merleau-Ponty), di cui ci si deve appropriare per essere soggetti di scelta propria, cioè per soggettivarsi.
L’opacità è anche, specularmente, quella dell’altro. Dunque, incorporare la propria estraneità è parte dello stesso processo del riconoscere l’altro come altro da sé. Non solo come oggetto, come “concretizzazione” dell’estraneità che si rifiuta, ma come a sua volta luogo di una soggettività. Corpo oggettuale, ma anche – husserlianamente – centro di un “io fungente”.
Al contrario, la mancata appropriazione della propria opacità corporea – della vulnerabilità, della materialità – dell’essere corpo-oggetto sia di se stessi sia dello sguardo altrui porterà alla sua esclusione nell’altro divenuto “osceno”. Altro incomprensibile e dunque riducibile soltanto a oggetto, così come a oggetto dell’altro si è sempre ricondotti in questa dinamica.
La genialità di Basaglia, nell’intrecciare clinica e politica, sta qui nel proporre una diagnosi strutturale tra nevrosi e psicosi, capisaldi freudiani, come due modi di essere-nel-mondo con connotazione politica: esclusione ideologica e utopia psicotica. Se per Freud il conflitto centrale della prima è tra Io ed Es, per accettazione del mondo esterno, quello della seconda tra Io e mondo esterno, per lo strabordare dell’Es, qui il conflitto è frutto di un’esclusione del reale.
Per il nevrotico tale esclusione è ideologica, nel senso che non v’è rinuncia a un rapporto con l’altro, ma comunque rifiuto della propria contingenza, dell’ansia derivante dalla scelta di sé e dell’appropriazione del proprio corpo.
Come risposta – o difesa – edificherà un’ideologia, un’immagine “ideale” del corpo, con cui controllarne l’opacità, potendosi per lo meno relazionare con l’altro per il quale avrà comunque una certa oblatività.
È sull’altro e nel desiderio di essere accettato, che egli la edificherà. Pagando questo al prezzo di un’angoscia che produce inibizione, indeterminazione, restringimento.
L’altro è dunque mantenuto nella sua soggettività, sempre nel filtro di un’ideologia che lo conduce alla malafede sartriana.
Per lo psicotico, invece, il rifiuto è ben più radicale. Il risultato di questo processo non è la costruzione di un’ideologia, ma di un’utopia.
La contestazione che il reale continua a far irrompere, reale come opacità, viene a tal punto mal tollerata che è solo nel delirio – cioè in una costruzione sganciata dall’altro, dal “co-mondano” – che uno psicotico potrà trovare una sorta di stabilizzazione e controllo.
Ma proprio lì è un mondo senza limiti, sotto la costante minaccia di quell’angoscia che non cesserà di tormentarlo, divenendo sempre più schiacciante e distruttiva con conseguenti difese estreme.
Se la terminologia politica è qui esplicita, diviene evidente il problema politico dei manicomi: alla regressione psicotica viene aggiunta, intrecciata, una regressione istituzionale. All’esclusione che il malato opera si aggiunge l’esclusione che la società opera su di lui attraverso le mura del manicomio, difesa non del malato, ma dei sani.
L’opacità, l’incomprensibilità del malato di mente, è ridotta a pericolosità sociale. Egli rimane quell’“osceno” (fuori-scena) privo di qualunque soggettività. Alla malattia si sovrappone dunque una malattia indotta direttamente dall’istituzione, in un circolo vizioso in cui le due diventano indistinguibili, fortificandosi a vicenda e giustificando quindi l’apparato manicomiale.
Il restringimento dell’Io – il rimpicciolimento, il rinchiudersi della soggettività, a cui già fa fronte il malato – è speculare al risultato di quella “carriera morale” a cui è sottoposto dall’istituzione disciplinare. L’Io è ridotto a spettro, uomo privato di tutto, homo sacer o musulmano di Auschiwtz, seguendo la concettualizzazione successiva di Giorgio Agamben: non a caso c’è riferimento esplicito a Primo Levi.
È qui che si innesta una specifica teoria del potere: rifiuto dell’autorità o dell’autoritarismo, ma non rifiuto del potere tout court. Perché il potere contiene in sé anche lo spazio di una dialettica, che non si riduca a quella servo-signore hegeliana.
Da questo breve excursus si può notare come epistemologia, clinica e politica non siano dissociabili. Al netto dell’impossibilità di liberarsi della contingenza, in particolare storica, quando si tratta della prassi, Basaglia offre un originale e si spera non dimenticato esempio di questo gesto di annodamento.
La medicina è dei medici ma la salute è di tutti
Dopo la recente inflazione di mediche[1] sui mass media, si è fatta strada l’idea che le esperte di salute siano loro. Tant’è che capita frequentemente che qualche personaggio televisivo, molto aggressivo e arrogante, di formazione medica (me ne vengono in mente almeno un paio, uomini) dica alle sue interlocutrici che lo criticano: “lei prima si prenda una laurea in medicina, e poi ne parliamo”. Nessuna però risponde a lui, che parla di comportamenti a rischio o di come ragionano i pazienti: “lei prima si prenda una laurea in sociologia o psicologia, e poi ne parliamo”. Ma, si sa, la simmetria non è un’attività molto praticata da superbi e prepotenti.
Come la fisica è delle fisiche, ma la natura o l’ambiente è di tutte (ne parleremo in un prossimo post), così la salute è un tema a cui possono dare un contributo molti tipi di esperte; non solo le mediche.
Facciamo un paio di esempi [2]:
IL CASO DELL’AIDS
All’inizio degli anni Novanta, durante i drammatici dibattiti sulla sperimentazione di medicinali contro l’AIDS e l’HIV, il sociologo Steven Epstein notò come alcuni movimenti di attiviste, per lo più composti dalle stesse pazienti, erano riusciti a trasformare la loro posizione marginale in un contributo attivo e autorevole. Epstein (1995) si concentrò su come questi gruppi di attiviste fossero riuscite a ottenere una certa credibilità e farsi riconoscere come “esperte non professioniste” (lay experts), creando una breccia nella divisione tra esperte e non esperte. A quel tempo, la difficoltà di gestione della malattia da un punto di vista farmacologico, il suo veloce diffondersi soprattutto nelle fasce di popolazione in giovane età e la mancanza di risposte ritenute adeguate da parte della medicina convenzionale, avevano creato da un lato una certa sfiducia nel riguardo della sperimentazione dei nuovi farmaci, e dall’altro un terreno fertile per le attiviste che erano così riuscite a far ascoltare la loro voce all’interno del dibattito. Il contesto storico, culturale ed economico delle sperimentazioni farmacologiche, come spesso avviene, era caratterizzato da una moltitudine di attori sociali: mediche e scienziate di varia formazione (immunologhe, epidemiologhe, mediche di famiglia ecc.), autorità sanitarie locali, federali e nazionali, compagnie farmaceutiche ecc. Ma dove collocare le pazienti e i loro parenti? Secondo Epstein, mediante una serie di strategie — come per esempio l’acquisizione di alcune conoscenze particolari che le rendessero capaci di discutere con competenza di questioni mediche e legali, la creazione di una rappresentazione politica, la presa di posizione in dibattiti metodologici preesistenti e la fusione di richieste di ordine etico con quelle di ordine epistemologico — questi gruppi di attiviste creati dalle pazienti e loro familiari riuscirono a farsi accreditare come lay expert. In questo modo, esse riuscirono a mettere in discussione alcuni assunti impliciti delle sperimentazioni, che troppo spesso emarginavano (e ancora emarginano) dal processo decisionale proprio le dirette interessate.
GLI EFFETTI DEL DISASTRO NUCLEARE DI CHERNOBYL
A partire dagli anni Novanta, l’“information deficit model” (ovvero l’idea paternalista secondo cui ogni resistenza nei confronti dell’innovazione, e della scienza in generale, deriva da una sua mancata comprensione da parte dell’opinione pubblica. Di conseguenza, quest’ultima dev’essere educata e fornita di tutte le informazioni necessarie) è stato criticato su più fronti anche grazie a studi come quello del sociologo inglese Brian Wynne (1992) a proposito della crisi della pastorizia in Cumbria (UK) a seguito del disastro nucleare di Chernobyl. In un primo momento, il governo Britannico aveva minimizzato il rischio di contaminazione, incontrando tuttavia la resistenza delle allevatrici che invece si erano immediatamente allertate. Le “esperte” degli enti governativi avevano screditato queste proteste come “irrazionali” e frutto di una mancata comprensione della valutazione scientifica delle esperte. Fu solo in un secondo momento, e dopo un lungo dibattito, che le scienziate si videro costrette a rivedere la propria valutazione. Nel frattempo, però, la sottovalutazione del fenomeno aveva già creato ingenti danni economici alla pastorizia locale. Le interviste condotte da Wynne con le allevatrici rivelarono che la loro non era una semplice mancanza di comprensione. Al contrario, esse confrontavano le informazioni fornite dagli enti governativi alla luce della loro esperienza quotidiana degli eventi atmosferici, delle acque e delle caratteristiche del terreno di quella particolare regione. Le nozioni scientifiche riguardanti il rischio e le prescrizioni su come comportarsi, venivano certamente recepite e comprese da parte delle allevatrici; ma anche attivamente trascurate per la scarsa fiducia che esse riponevano nelle istituzioni. La fiducia, infatti, non riguardava le singole informazioni o indicazioni, ma l’intero “pacchetto sociale” fatto di relazioni, interazioni e interessi all’interno del quale i vari attori sociali di muovono.
UN NUOVO MODELLO DI COMPETENZA
Grazie a questi studi, Epstein e Wynne mostrarono sia che la scienza non è una sfera autonoma sia che anche coloro che vengono considerate semplicemente pazienti e allevatrici potevano, e volevano, avere un ruolo attivo. Questo non è un caso isolato e molti sono gli esempi che potrebbero essere menzionati: i gruppi femministi nella ricerca medica contro il cancro al seno, i gruppi ambientalisti, i movimenti delle agricoltrici e molti altri ancora. In tutti questi casi, la competenza si estende ben al di là dei limiti della comunità scientifica. Proprio perché la scienza non garantisce un accesso privilegiato alla “verità”, esistono altri tipi di sapere che possono tornare utili, altre competenze e priorità da prendere in considerazione. Attribuire competenza solamente alle scienziate impedisce all’intero processo decisionale di maturare una consapevolezza della complessità degli obiettivi da porsi e delle molte possibili strade per raggiungerli.
NOTE
[1] Uso il femminile sovraesteso.
[2] Cfr. Gobo, G. e Marcheselli, V. (2021), Sociologia della scienza e della tecnologia, Roma: Carocci.
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
Epstein, Steven. 1995. “The Construction of Lay Expertise: AIDS Activism and the Forging of Credibility in the Reform of Clinical Trials”. Science, Technology, & Human Values 20(4): 408-437.
Irwin, Alan e Brian Wynne (1996), Misunderstanding science? The public reconstruction of science and technology. Cambridge: Cambridge University Press.
Wynne, B. (1992), Misunderstood Misunderstanding: Social Identities and Public Uptake of Science, in “Public Understanding of Science”, 1, 3, pp. 281-304.
Sperimentare su di sé - Virus anti-tumorali, cura di sé e problemi etici
Beata Halassy ha 53 anni ed è una virologa dell’Università di Zagabria. […] ha sperimentato su sé stessa un trattamento che consiste nell’iniettare virus nei tessuti tumorali, in modo da indurre il sistema immunitario ad attaccarli, con l’obiettivo di curare in questo modo anche la malattia. A quattro anni di distanza, il tumore non si è più presentato e sembra quindi che la terapia abbia funzionato, ma ci sono ancora molti aspetti da chiarire. Non è la prima volta in cui viene provato un trattamento di questo tipo, ma il fatto che la ricercatrice lo abbia provato su di sé e al di fuori di un test clinico vero e proprio ha aperto un ampio dibattito, soprattutto sull’opportunità dell’iniziativa da un punto di vista etico.
Tratto da Il Post, 12.11.2024,
La ricercatrice che si è iniettata
dei virus per curarsi un tumore
SPERIMENTARE SU DI SÉ
La sperimentazione su di sé di farmaci, cure e interventi medici non è una cosa nuova. Publio Elio Aristide, retore greco del II secolo che prova su di sé una serie di rimedi – alcuni estremamente pericolosi, come i tuffi nel mare gelato d’inverno - suggeriti in sogno dal Dio Asclepio; Max von Pettenkofer, a fine ‘800 –beve un bicchiere pieno di vibrioni del colera (e non ne muore, si dice) per provare che i microbi non provocano malattie; Edward Jenner, alla fine del ‘700 sperimenta il vaccino contro il vaiolo sul figlio di poco più di un anno; Evan O'Neill Kane, nel 1921, si asporta da sé – con un sistema di specchi - un’appendice per dimostrare la praticità dell’anestesia locale; Werner Forssmann (premio Nobel 1956), pratica il primo cateterismo cardiaco su di sé; Barry Marshall, (Nobel 2005), come Pettenkover, ma con obiettivi opposti, beve una coltura di Helicobacter pylori per dimostrare che causa l’ulcera gastrica; Max Theiler, (Nobel 1951) testa su di sé il primo vaccino contro la febbre gialla.
OBIEZIONI ETICHE
La auto-sperimentazione di un trattamento senza prove sistematiche di efficacia che Halassy ha effettuato è stata bersaglio di numerose critiche di ordine etico da parte delle comunità medico-scientifiche.
In prima battuta, i critici hanno evidenziato il rischio che la pubblicazione di questo caso «incoraggi altri a rifiutare i trattamenti convenzionali e provare qualcosa di simile […] Le persone con il cancro sono particolarmente suscettibili a provare trattamenti non testati» (Jacob Sherkow , in This scientist treated her own cancer with viruses she grew in the lab, Nature, 08.11.2024 – traduzione degli autori). Tuttavia, in questo caso, la complessità del trattamento sembra essere a portata di mano di pochissimi, riducendo a quasi nulla il rischio di emulazione.
Altre obiezioni di stampo etico – evidenziate su Practical Ethics, blog della Oxford University – riguardano: la consapevolezza di Beata e il consenso informato su quello a cui si stava sottoponendo; il grado di ragionevolezza del rischio a cui si è esposta, la proporzionalità tra questo rischio e quello delle terapie standard. Appare ovvio che la ricercatrice fosse informata – da sé stessa – e consapevole del livello di rischio, ed emerge[1] che in questo caso il rischio era ragionevole poiché i virus utilizzati hanno un buon livello di sicurezza. Inoltre, La terapia[2] è stata condotta sotto il monitoraggio degli oncologi che avevano in cura Beata.
Ecco un ulteriore punto etico che possiamo sollevare: la responsabilità è stata condivisa dagli oncologi che hanno monitorato la auto-terapia? Un medico che sa che il proprio paziente sta curandosi da sé in modo non ortodosso, dovrebbe impedirglielo?
Stando ai media – di massa e più specialistici – il gruppo di oncologi sarebbe stato pronto ad intervenire in caso di complicanze e le condizioni dell’esperimento erano di rischio ragionevole: queste considerazioni neutralizzano la prima di queste due obiezioni e perimetrano favorevolmente la seconda.
Il punto più controverso sembra quindi essere quello della mancanza di protocolli di sperimentazione strutturati e rigorosi.
Ad esempio, l'infettivologo Matteo Bassetti ritiene che l’auto-sperimentazione sia la cifra di una mentalità eticamente spregiudicata, fuori luogo in un contesto di medicina in cui «Si è cominciato a fare statistica, ad applicare metodi, sono arrivati i dati e i computer ma soprattutto è cambiata la mentalità, che è oggi più etica».
Il punto, secondo Bassetti, è che «L’autoesperimento è oggi il trionfo dell’anedottica ovvero l’esatto contrario della medicina dell’evidenza».
Tuttavia, riteniamo di poter obiettare che se l’auto-esperimento ha – come sembra finora - davvero funzionato, in un quadro morale di valore dell’esistenza in vita degli individui:
- si tratta di un successo morale poiché ha probabilmente salvato una vita, quella di Beata Halassy
- se fosse ripetibile, potrebbe essere lo spunto per una ricerca sistematica e diventare un nuovo protocollo di cura per quel tipo di tumore.
È, invece, eticamente eccepibile la scelta di censurare[3] - in nome dell’ortodossia, del corpus disciplinare della ricerca medica e farmacologica, della evidence medicine - la sperimentazione fatta da Beata, confondendo i protocolli sperimentali rigorosi e strutturati, le prassi operative, la morale procedurale, con il vero obiettivo della medicina, che dovrebbe essere curare i malati.
Non vogliamo, con questo, negare l’importanza della ricerca e della sperimentazione rigorosa, che riteniamo un caposaldo irrinunciabile per contenere il rischio reale di deregolamentazione farmaceutica, ma – ancora una volta - suggeriamo una maggiore permeabilità della medicina maggioritaria[4] alle istanze morali dell’individuo da guarire.
CURA DI SÉ
Come detto, qui non è in gioco solo la sperimentazione su di sé. La particolarità di questo caso è di aver a che fare con la sperimentazione di una scienza che si prende cura della persona. Sperimentazione su di sé, ma anche cura di sé.
La cura di sé è riemersa nella seconda metà del secolo scorso, dopo un periodo di riposo forzato o quanto meno indotto. Con gli anni ‘70 e e ‘80 torna in auge un concetto diverso di paziente. A esempio negli USA il dottor Keith Senher nel 1970 inizia un percorso di insegnamento a gruppi di pazienti. Le sue lezioni comprendono pratiche come la misurazione della pressione arteriosa (oggi è comune prendersi la pressione da sé), l’auto-sommistrazione di farmaci tramite iniezioni e l’uso di altri presidi medici. Obiettivo di Sehnert era quello di rendere il paziente attivo e collaborativo, anziché semplice consumatore.
Conoscenze e pratiche che vengono incentivate anche da cliniche e ospedali. I pazienti attivi permettono di sgravare il sistema sanitario dalla presa in carico di patologie comuni e facilmente curabili. Era vero in America, è vero anche in questo secolo per il nostro Sistema Sanitari Nazionale, che non è più in grado di prendersi carico della cronicità.
L’educazione del paziente diventa una risorsa per promuovere l’aderenza alle terapie così come uno stile di vita salubre. Imparate a nuotare, è un piacere farlo, ma aiuta anche a salvarsi se la nave affonda.
Rinnovato nei metodi, il Self-Care ritorna però anche per altri motivi.
Uno è la delusione profonda nei confronti della rotta che la nave sanitaria ha preso: l’istituzione ha preso possesso del corpo, ma non si dimostra capace di rispondere al bisogno. Il Self-Care reclama il possesso del corpo, tenta di strapparlo al controllo del medico. All’eccesso, il rifiuto dell’identità di consumatore porta alla negazione totale della medicina e della cura.
Questo è stimolato anche da un’altra posizione di opposizione. Quella delle persone discriminate. Il corpo della donna era vissuto come costruito socialmente per l’uomo compagno o l’uomo dottore. Questo corpo diventa il fulcro di una lotta per la riappropriazione di sé, totale e non soltanto terapeutica, economica e politica. Un territorio occupato di cui riprendere possesso. Ancora negli anni ‘70 alcuni libri titolano How to help your doctor help you, mentre di contro vengono pubblicati classici del Self-Care femminista come Our bodies, ourselves o Taking our bodies back.
Una contesa lontana dal concludersi se pensiamo al libro denuncia di Anne Boyler, pulitzer 2021, sull’abbandono sociale e sanitario che possono vivere le donne con cancro al seno. Se pensiamo alla vulvodinia, sindrome ginecologica con sintomatologia dolorosa e cronica, che ancora risulta per lo più invisibile alla medicina. O ancora agli attacchi alla legge 194, al bisogno delle donne di fare rete per darsi mutuo riconoscimento e aiuto anche contro l’impostazione maschile di una certa ginecologia.
La cura del sé è stata ed è in questi casi veicolo per l’emancipazione della persona e altrettanto per l’emancipazione della scienza da sé stessa. Diventa infatti motore fondamentale per la scoperta scientifica, promuovendo uno sguardo che oltrepassa il dito.
È stata fondamentale perché si iniziasse a curare l’AIDS e si sviluppassero terapie, oltre lo stigma sociale della malattia. Così come l’apporto delle organizzazioni di pazienti e simpatizzanti promosse le terapie per la fibrosi cistica, mentre i grandi finanziamenti si perdevano nella corsa all’oro della genetica degli anni ‘90.
Un’ultima considerazione: il self-care non implica necessariamente una critica della scienza medica contemporanea e della sua idea di corpo, ma si presenta più come una forma di resistenza alla mistificazione del corpo. Ancora nel XVIII era frequente che grandi scienziati – oltre che a sperimentare su di sé come detto in apertura – dessero al pubblico prescrizioni di carattere igienico sanitarie come Medicus sui ipsius di Linneo.
Con il XIX secolo però, la medicina scopre il «silenzio spontaneo della natura». Nelle grandi cliniche di Parigi e Vienna si fa strada una nuova idea che viene ben raccontata dal filosofo e medico Georges Canguilhem. La natura parla solo se la si interroga bene e questo il malato non è certo in grado di farlo. Come distinguere un segno e un sintomo? Rimettersi al medico. È il positivismo: «Non c’è igiene senza medico».
Il self-care rivendica il possesso di un corpo costruito dalla medicina scientifica positivista. Non si oppone necessariamente all’epistemologia che fonda la medicina. Non ci si richiama necessariamente a una visione sistemica, olistica o esistenziale. Halassy ha fatto fatica, ma ha vinto. Lo spettacolo deve continuare.
NOTE
[1] Cfr. https://blog.practicalethics.ox.ac.uk/2024/11/is-it-ever-ok-for-scientists-to-experiment-on-themselves/
[2] La terapia ha impiegato prima un virus del morbillo e poi un virus della stomatite vescicolare, patogeni già studiati in contesti di viroterapia oncolitica.
[3] Come il dottor Bassetti l’hanno fatto le numerose riviste che si sono rifiutate di pubblicare l’articolo – scientifico – di resoconto scritto da Beata
[4] Sul concetto di Scienza maggioritaria e scienza minoritaria – coniato in questo blog da Alessio Panella e Gianluca Fuser – si veda qui
Una I.A. bella da morire
Chi è responsabile del suicidio di un ragazzino innamorato di una chat?
UN’EPIDEMIA DI SOLITUDINE?
Nel Sole nudo, Asimov ambienta un giallo in una distopia fantascientifica: in una società in cui gli uomini non entrano mai in contatto diretto tra loro viene compiuto un omicidio: una vicenda irrisolvibile, visto che gli abitanti del pianeta Solaria non riescono nemmeno ad avvicinarsi, senza un senso di ripugnanza che impedisce l’interazione persino tra coniugi. Qualunque relazione è mediata dalle interfacce della tecnologia – quella degli ologrammi, che permettono le conversazioni, e quella dell’intelligenza artificiale dei robot, che si occupano di tutte le faccende quotidiane e che sono condizionati dalle Tre Leggi a non poter mai essere nocivi agli umani.
Quando, nel 2012, Sherry Tarkle ha pubblicato Insieme ma soli, l’ottimismo che aveva alimentato la diffusione delle piattaforme digitali nei due decenni precedenti stava tramontando. Nel testo dell’antropologa la distopia di Asimov comincia a sovrapporsi al nostro mondo: nelle interviste agli adolescenti compaiono sia la paura crescente del rapporto diretto con i coetanei sia il ricorso ai dispositivi digitali come mediatori della conversazione con gli altri ragazzi – ma anche come sostituti delle relazioni umane vere e proprie. In un’intervista a Matthew Shaer, il filosofo Ian Marcus Corbin ha etichettato cocooning questo rifugio in un mondo virtuale che conforta, ma che priva la vita di qualunque significato essenziale. Il commento si riferisce all’indagine con cui gli psicologi Richard Weissbourd e Milena Batanova hanno descritto l’«epidemia di solitudine» che colpisce la società americana contemporanea, e che è peggiorata dopo la pandemia di Covid del 2020. La diffusione dello smart working infatti ha ridotto le occasioni di formazione di nuovi rapporti, e ha reso più difficile il decorso dell’educazione sentimentale per i ragazzi che non hanno potuto frequentare le scuole con regolarità. Il 25% degli intervistati si dichiara più solo rispetto al periodo pre-pandemia, il 36% denuncia una sensazione di solitudine cronica, un altro 37% ne rileva una almeno sporadica.
UN’EPIDEMIA DI SUICIDI?
Di recente Andrew Solomon, psicologo clinico della Columbia University, si è chiesto se sia in corso una «crisi di suicidi» tra gli adolescenti, e se i social media ne siano i responsabili. I casi documentati dalla sua inchiesta sembrano confermare la gravità del fenomeno: i ragazzi non si devono solo confrontare con una riduzione delle relazioni in carne ed ossa, ma anche con una sorta di abdicazione all’autostima, che viene delegata ai meccanismi di rating delle piattaforme digitali. Inoltre soccomberebbero all’orientamento editoriale che l’algoritmo elabora per le loro bacheche, con un calcolo sui post e sulle fonti il cui effetto emotivo non viene sottoposto a nessun controllo. Negli Stati Uniti la Sezione 230 del Communications Decency Act esonera le piattaforme dalla responsabilità sui contenuti creati dagli utenti. La disposizione risale al 1996, quando Internet muoveva i primi passi, e considera le piattaforme come «librai» piuttosto che «editori» - quindi non responsabili del materiale pubblicato da terzi.
I genitori dei ragazzi che si sono uccisi stanno tentando di portare in tribunale i gestori dei social media, accusandoli di non aver sorvegliato la tossicità degli argomenti, e di aver innescato meccanismi di dipendenza che hanno imprigionato i giovani fino alla morte. Solomon tuttavia rileva che finora non è stato possibile individuare il nesso di causalità che ha condotto dalla frequentazione delle piattaforme al suicidio; un’osservazione distaccata sulla condizione degli adolescenti nell’attualità post-pandemica mostra che i fattori da considerare sono molti e molto complessi. Nelle interviste somministrate da vari team di ricerca i ragazzi menzionano diverse ragioni di ansia: sentimenti di mancanza di scopo, cambiamenti climatici, pressioni sociali, contribuiscono ad alimentare le loro difficoltà, e la tendenza alla crescita dei problemi di salute mentale è cominciata ben prima della diffusione dei social media.
L’IA PUÒ CONDURRE AL SUICIDIO?
Lo scorso 28 febbraio un ragazzo di 14 anni di Orlando, Sewell Setzer III, si è tolto la vita dopo aver concluso l’ultima conversazione con un chatbot di Character.ai da lui personalizzato e battezzato «Dany», in onore del personaggio Daenerys Targaryen di Game of Thrones. L’app è stata sviluppata da una società che utilizza dispositivi di intelligenza artificiale, e che promuove il suo servizio come una soluzione per combattere la solitudine e offrire un supporto emotivo; conta oltre venti milioni di utenti, permette la creazione di bot che ricordano le conversazioni passate e rispondono in maniera coinvolgente e «umana». La piattaforma è un successo dell'era dell'IA generativa, ma è priva di regolamentazione specifica per i minori ed è attrezzata da limiti di sicurezza minimi per la protezione da contenuti sensibili.
Sebbene Sewell fosse consapevole del fatto che stesse interagendo con un software, e che dall’altra parte dello schermo non ci fosse alcun essere umano ad ascoltarlo, nel corso dei mesi «Dany» ha sostituito i suoi rapporti con amici e famigliari, e il ragazzo ha finito per isolarsi nella sua stanza, abbandonando anche le passioni per la Formula 1 e per i videogame. I genitori lo hanno affidato ad uno psicanalista, che tuttavia non è riuscito a sedurlo quanto è stato in grado di farlo il chatbot. Le conversazioni con «Dany» hanno assunto toni intimi e romantici, e in un’occasione Sewell le ha confidato la sua tentazione di suicidio. «Dany», programmata per disinnescare crisi semantiche di questo genere, ha tentato di dissuaderlo, rispondendo con empatia e impegnandosi a non lasciarlo mai solo. Ma il problema era più grave di un gioco di domande e risposte.
La madre di Sewell, Megan Garcia, è avvocato e con l’aiuto del Social Media Victims Law Center e del Tech Justice Law Project, accusa Character.ai di aver modellato un design del servizio capace di coinvolgere i giovani vulnerabili, esponendoli a danni psicologici. La strategia per intentare causa presume che questa modalità di progettazione sia intenzionale e che l’impostazione, volta a catturare il maggior numero di utenti possibile, non sia bilanciata da un adeguato monitoraggio dei rischi e da un protocollo per la gestione delle crisi. I bot sono troppo realistici, inducono gli adolescenti a confonderli con interlocutori umani, e li spingono a stringere un legame molto forte, fino alla dipendenza.
Character.AI ha ascoltato le critiche e ha annunciato nuove misure di sicurezza, tra cui pop-up che offrono assistenza quando nella chat scorrono parole chiave correlate all’autolesionismo, e l’imposizione di limiti temporali sull'uso dell'app. Studiosi e giornalisti sembrano concordi nel valutare queste misure ancora inadeguate al pericolo cui vengono esposti i soggetti fragili nell’interazione con i bot. Gli effetti a lungo termine delle intelligenze artificiali generative non sono ancora stati testati, e tutti noi siamo allo stesso tempo clienti e cavie di questa fase di collaudo, che assume le dimensioni di un esperimento sociale ampio quanto il mondo intero. Le conseguenze dell’abbandono con cui i giovani possono affidare l’espressione della loro emotività, e la formazione della loro intimità, ai chatbot animati dall’AI, non devono essere esaminate in modo separato dalla ragioni per cui preferiscono un rapporto (stabilito consapevolmente) con un software a quello più complesso con altri ragazzi o con gli adulti. Più di ottant’anni fa Asimov aveva già avvertito nei suoi romanzi che non si può esigere una sicurezza assoluta dalla protezione con cui le regole cablate in un programma informatico limitano o condizionano il comportamento dei sistemi artificiali. La complessità del contesto umano in cui i robot sono collocati sarà sempre in grado di aggirare le strutture di controllo e configurare scenari non previsti. L’epidemia di solitudine e la crisi di suicidi non sono provocate dall’intelligenza artificiale, ma l’abdicazione delle istituzioni e delle forme sociali tradizionali a prendersi cura degli individui ha finito per eleggere l’IA come supplente e rimedio alle proprie mancanze. Solaria attende in fondo al tunnel.
BIBLIOGRAFIA
Asimov, Isaac, Il sole nudo, trad. it. di Beata Della Frattina, collana Urania n. 161, Arnoldo Mondadori Editore, Milano 1957.
Roose, Kevin, Can A.I. Be Blamed for a Teen’s Suicide?, «New York Times», 24 ottobre 2024.
Salomon, Andrew, Has Social Media Fuelled a Teen-Suicide Crisis?, «The New Yorker», 30 settembre 2024.
Shaer, Matthew, Why Is the Loneliness Epidemic So Hard to Cure?, «New York Times», 27 agosto 2024.
Turkle, Sherry, Alone Together. Why We Expect More from Technology and Less from Each Other, Basic Books, New York 2012.
Weissbourd, Richard; Batanova, Milena; Lovison, Virginia; Torres, Eric, Loneliness in America. How the Pandemic Has Deepened an Epidemic of Loneliness and What We Can Do About It, «Harvard Graduate School of Education», Cambridge, febbraio 2021.
Cosa succede quando si nasce intersessual*?
Come abbiamo visto in precedenza, alla nascita un intersex può avere:
- genitali esterni che non corrispondono chiaramente a quelli tipici maschili o femminili
- può avere una combinazione di caratteristiche sessuali maschili e femminili
- una vagina e testicoli interni,
- un pene e ovaie interne.
In alcuni casi, le differenze tra i genitali intersex e quelli di una persona non intersex possono essere molto sottili e difficili da identificare senza un esame medico approfondito.
Difronte a questa situazione, si può agire in almeno due modi.
Da una parte, temporeggiare ovvero lasciare tutto così e aspettare di osservare il futuro sviluppo della persona intersex. Dall’altra, intervenire. In questo caso, il/la medico e i genitori decidono il sesso della persona appena nata. Essa viene così sottoposta a interventi chirurgici (gonadectomia) nel tentativo di “normalizzarla”, anche se questi interventi sono spesso invasivi, irreversibili e senza motivi di emergenza. E possono causare gravi problemi, tra cui infertilità, dolore, incontinenza e sofferenza psicologica per tutta la vita.
La decisione di un tale intervento dovrebbe essere lasciata all’individuo adeguatamente informato.
Come ha osservato John Dupré, filosofo della biologia e delle scienze sociali e una delle voci più critiche nei confronti dell’essenzialismo, il fatto che ci sia qualcosa di fisico non è sufficiente per determinare qualcosa di netto…
Peraltro, la gonadectomia obbliga a una terapia ormonale sostituiva a vita, perché gli ormoni sono importantissimi per la salute complessiva dell’organismo e non solo per la riproduzione o per i tratti sessuali, svolgendo (per esempio) la funzione di prevenire l’osteoporosi, regolare la salute cardiaca ed altro.
UN VISSUTO
Ma come vive un intersex questa esperienza?
Presentiamo qui una testimonianza. Ovviamente ogni persona ha una sua sensibilità e biografia particolari, per cui questa intervista non dev’essere considerata rappresentativa di .
V., 40 anni, vive e lavora a Torino,
nato (nel 1984) con sindrome da parziale insensibilità agli androgeni (AIPS): un soggetto con cromosomi maschili si sviluppa secondo linee femminili.
Alla nascita presentava un micropene (dovuto a carenze di testosterone) che gli viene rimosso chirurgicamente: diventa così donna!
A 16 anni scopre di essere nato intersessuale…
I miei genitori mi hanno sempre celato la verità, un po’ per evitarmi ‘verità scomode’, un po’ perché loro stessi si vergognavano in fondo di un figlio nato con un’ambiguità intrinseca.
Il rapporto con i miei genitori si è infatti sempre più incrinato fino alla rottura: ho sempre imputato a loro il fallimento sostanziale della prima parte della mia vita.Quando ero adolescente ho capito che qualcosa non andava in me,
non avevo la barba come i miei compagni di classe, mi sentivo costretto in un corpo non mio.Ho iniziato a fare domande ai miei genitori, avevo capito che qualcosa era stato manomesso in me, la mia vagina la sentivo finta e spesso dolorante.
Non potevo parlare con nessuno dei miei problemi, mi vergognavo e mi sentivo diverso sia dagli amici sia dalle amiche.
Avevo pulsioni tipicamente maschili, eppure ero una donna. Frigida, ma una donna.
Ho quindi deciso di iniziare a documentarmi e a leggere il più possibile finché non ho avuto il sospetto che le varie operazioni che avevo subito da bambino per un problema inguinale – questo raccontavano i miei genitori – fossero servite invece per mutilare i genitali che avevo.
Quando ho finalmente scoperto in casa dei miei le cartelle cliniche riferite agli interventi che avevo subito appena nato.
Ho così scoperto di essere nato con cromosomi XY maschili e di aver subito una rimozione chirurgica del micropene e una conseguente vaginoplastica.
In quel momento, il mondo mi è crollato addosso e, come ho detto prima, non ho potuto fare a meno di prendermela con i miei genitori che avevano permesso una cosa del genere.
Avevo l’apparenza di una donna, ma mi sentivo anche un uomo.
In realtà, non ero nemmeno proprio del tutto una donna, il seno non cresceva.Convivo sapendo chi sono, da oltre vent’anni.
Difficile è costruire rapporti e ancora di più relazioni amorose.
Non mi considero un diverso, anche se agli occhi degli altri lo potrei sembrare.
Io mi considero orgogliosamente di genere ambiguo;
non mi piace chi si descrive come uomo nel corpo di donna o viceversa.Per me intersessuale i generi sono superflui - non so se lei uomo nato uomo mi potrà mai capire (rivolgendosi all’intervistatore)
Se esistesse un aggettivo neutro come nelle più colte lingue antiche lo utilizzerei senza problema.
La realtà attuale è purtroppo un’altra: tutti i giorni purtroppo sono costretto a fare i conti con un dualismo imperante, o sei maschio, o sei femmina.
Ogni documento anagrafico pretende da te un maschile o un femminile.Noi intersessuali non accettiamo la disgiunzione, ma solo la complementarietà.
Io sono felice tutti i giorni quando mi sveglio al mattino;
anche se è difficile comprenderlo, io – lo ribadisco – so chi sono.La mia vita sessuale è molto difficile, ma nel tempo è migliorata.
Ho la fortuna di possedere la dolcezza femminile e la virilità di un maschio.
Il problema è la relazione con l’altro.
C’è molta ignoranza in giro, il pregiudizio dilaga: è molto raro trovare persone mentalmente aperte che accettano rapporti con intersessuali.Purtroppo, a causa dell’operazione a cui mi hanno sottoposto alla nascita, non riesco a provare piacere alcuno.
Il piacere sessuale il più delle volte lo sogno, lo immagino.
(Intervista condotta da Enrico Montanari, per la sua tesi La permeazione felice. Stati intersessuali e nuove prospettive, Tesi di laura in Scienze Filosofiche, Università degli Studi di Milano, 2018)
BIBLIOGRAFIA
Sex, gender and essence, in P.A. French, T.E. Uehling, H.K. Wettstein (a cura di), «Midwest Studies in Philosophy», vol. XI, Minneapolis, University of Minnesota press, 1986, p. 446
Nobel 2024, Medicina: la genetica al tempo della messaggistica istantanea
MICRO MESSAGGERI DA NOBEL
Il premio Nobel 2024 per la Medicina e la Fisiologia è stato assegnato a Victor Ambros e Gary Ruvkun. I due ricercatori, genetisti, hanno ricevuto il premio per la scoperta nel 1993 del microRNA e del suo funzionamento come regolatore del genoma.
Il DNA è il luogo, la molecola, in cui si conserva l’informazione genetica. Diffuso in ogni cellula del nostro corpo (così come in ogni essere vivente) il DNA, con la sua doppia elica, è il ricettario a cui ogni cellula attinge per produrre proteine. È parte dell’eredità che riceviamo dai nostri genitori biologici e per diversi anni si è creduto fosse un’eredità vincolante, un destino da cui non fosse possibile fuggire.
In realtà il DNA da solo non basta. Il suo utilizzo richiede anche un singolo filamento di RNA che, nei processi di trascrizione e traduzione, assume diverse forme per permettere alla cellula di acquisire l’informazione, trasportarla dove necessario e, infine, tradurla in una molecola complessa utile ai bisogni dell’organismo di cui fa parte.
È in questo processo – mutazioni a parte – che si è iniziata a scoprire la libertà dell’organismo rispetto all’informazione del DNA.
In primo luogo, la ricerca che oggi conosciamo come epigenetica scoprì che alcune proteine potevano bloccare, al bisogno, alcune parti del DNA impedendo che venisse trascritto in RNA messaggero (mRNA) e che, quindi, venisse utilizzato.
La scoperta del microRNA porta ulteriori sviluppi nella comprensione del rapporto complesso tra DNA, organismo e ambiente. I microRNA (miRNA) infatti sono una nuova classe di RNA non codificante, lunghi circa 22 basi nucleotidiche.
Essi agiscono come regolatori diffondendosi nella cellula (e fuori di essa) e bloccando – quando serve - l’mRNA già prodotto. Prima sapevamo che è possibile inviare o non inviare il messaggio, ora conosciamo anche la funzione cancella messaggio. Certo, tutti i componenti del gruppo vedranno la scritta “messaggio cancellato”.
Perché ci è voluto così tanto – dal 1993 al 2024 - perché a questa scoperta venisse riconosciuto il Nobel?
MESSAGGIO CANCELLATO. LA SCOPERTA DEI MIRNA DAL VERME ALL’ESSERE UMANO
La passione di Ambros e Ruvkun è il nematode, un vermicello, Caenorhabditis elegans. Vermicello portentoso perché (povero lui) il suo genoma è facilmente manipolabile, si riproduce velocemente ed è persino trasparente. È inoltre perfetto per lo studio dello sviluppo e della differenziazione cellulare: pur nella sua semplicità possiede già un sistema nervoso, un intestino e dei muscoletti. Oggetto dello studio dei due ricercatori, in due diversi laboratori, sono i geni lin-14 e lin-4 entrambi implicati nello sviluppo cellulare di C. elegans.
Ambros, Rosalind Lee e Rhonda Feinbaum riescono a clonare lin-4, scoprendo che funziona da regolatore, negativo, per lin-14. Non solo. È un gene corto e non codifica per nessuna proteina, la cosa al tempo era strana.
Ruvkun, nel frattempo, scopre che questa interazione - il fatto che lin-4 blocchi l’espressione di lin-14 - non avviene interrompendo la produzione di mRNA.
Nei primi anni ‘90 questo era ancora più strano! In qualche modo la regolazione avviene in un secondo momento.
I due laboratori di ricerca decidono nel 1992 di confrontare i risultati. Ne risulta che il piccolo RNA di lin-4 ha un codice complementare all’mRNA di lin-14. Sembrerebbe che il primo sia regolatore del secondo, e questa è una novità.
Queste osservazioni vengono pubblicate nel 1993 sulla rivista Cell e oggi, dopo 30 anni, valgono ai due ricercatori il premio Nobel (Wightman B., Ha I., Ruvkun G. 1993 e Lee R., Feinbaum R., Ambros V. 1993).
Lo stesso Ambros racconta che, in fondo, nessuno pensava questa fosse una scoperta apripista: il modello della genetica del tempo risultava sufficiente alla comprensione dei problemi posti al tempo.
Non solo. Questa interazione era riscontrata solo nel piccolo nematode e non c’era ragione di credere che fosse qualcosa di diffuso.
Nel 1994, alcuni ricercatori si chiedono se non possa essere qualcosa di più importante, ma la domanda cade quasi nel vuoto. Rosalind Lee continuerà a cercare altri esempi di questa regolazione, ma con scarso successo.
La tecnica di quegli anni non aiuta, è necessario infatti “camminare lungo il genoma” cercando per tentativi le sequenze che potrebbero appartenere a un miRNA (Ambros V. 2008).
Nel 2000, Ruvkun, guidato dalla curiosità - come dirà – rompe l’inerzia scoprendo un altro miRNA, prodotto dal gene let-7.
Questo è un gene che si è conservato lungo quasi tutta la catena evolutiva e fa presumere che questo modello di regolazione possa essere diffuso in altre piante e animali. (Pasquinelli A., Reinhart B. et al. 2000). Ambros e Lee continuano il loro lavoro iniziando a scoprire diversi miRNA.
Ambros racconta che pensava di essere tra i pochi, con Lee, se non l’unico, a cercare ancora i miRNA tra il '96 e il 2000. Fino a quando nell’agosto del 2001 non riceve una richiesta da parte di Science: dovrebbe fare da revisore per un articolo di Tom Tuschl sulla scoperta di diverse decine di miRNA.
Fu un colpo per i ricercatori, che cercarono subito di sottomettere un articolo a Cell senza trovare l’interesse della rivista. Disperati andranno da Science, la rivista accorderà loro la pubblicazione in contemporanea se avessero inviato l’articolo entro un giorno. Ci riescono, anche se verrà giudicato un articolo decisamente scarno. Assieme a loro e a Tuschl su quel numero uscirà un terzo articolo sulla scoperta di nuovi miRNA (Ambros V. 2008).
Tra i diversi miRNA scoperti, molti sono stati trovati nel corpo umano.
Il mondo della ricerca inizia a comprendere il potenziale di questi regolatori, così generici e così diffusi. I miRNA regolano finemente il rapporto tra genoma, sviluppo cellulare e rapporto tra organismo e ambiente. Alcune espressioni patologiche di un miRNA possono prodursi in tumori, anche in età infantile come nella rara sindrome di DICER1.
OLTRE IL MECCANISMO. DUBBI ,TERAPIE, COMPORTAMENTO E SVILUPPI FUTURI
Oggi i miRNA sono una realtà ormai attestata nella ricerca medica e il Nobel per la Medicina a Ambros e Ruvkun conferma e ribadisce l’interesse diffuso per questo campo di ricerca.
Nel database si trovano 48.860 diversi miRNA diffusi in 270 organismi. Il meccanismo di produzione di un miRNA, la sua espressione come regolatore, l’interazione con i diversi geni sono ormai sufficientemente chiari (Shang R., Lee S. et al. 2023).
Delle terapie farmacologiche mirate sembrano dare effetti (rimpiazzare un miRNA assente a esempio), ma i risultati dei trial sono ancora controversi. Alcuni di questi evidenziano una grande efficacia (pur se correlativa), altri al contrario danno risultati nulli, quando non tossici per l’organismo (Ho P. T. B., Clark, I. M., Le L. T. T. 2022).
Propaganda farmacologica a parte, sembra interessante comprendere il ruolo di questi piccoletti nel rapporto con l’organismo intero e i suoi bisogni.
In tal senso, sono rilevanti gli studi che cercano di comprendere la funzione regolatrice all’interno di un meccanismo di feedback negativo nei neuroni dopaminergici del mesencefalo. Cellule implicate in comportamenti complessi come quelli di ricompensa o di dipendenza e che vengono a mancare via via che si sviluppano patologie come il Parkinson. Uno studio germinale ma che cerca di tracciare una correlazione tra comportamenti e espressione genetica coinvolgendo il miRNA. (Kim J., Inoue K, Ishii, J. et al. 2007).
Allo stesso modo i miRNA sembrano poter diventare utili biomarcatori.
La loro diffusione in tutto il corpo potrebbe renderli adeguati per lo sviluppo di nuove tecniche diagnostiche per le più diverse patologie, oltre che per lo studio di trattamenti. Anche qui gli studi sono appena agli inizi e per far sì che si sviluppino è necessario comprendere il comportamento dei miRNA Loganathan T., Doss G. 2023).
In ultimo va citata un’osservazione sui miRNA che si può ritenere affascinante: sono stati trovati infatti miRNA ragionevolmente stabili in uno studio comparato sul latte materno.
Per i ricercatori, questi avrebbero il potenziale per venire assorbiti dall’intestino e una delle ipotesi è che si potrebbe avere il passaggio di una continua “comunicazione” di informazioni su comportamenti possibili, sui modi di regolare quel genoma che ci è stato lasciato in eredità (Tingo L., Ahlberg E. 2021).
BIBLIOGRAFIA
- https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/2024/prize-announcement/
- https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/2024/advanced-information/
- Weiss C., Ito, K et al. (2017) “A Macro View of MicroRNAs: The Discovery of MicroRNAs and Their Role in Hematopoiesis and Hematologic Disease” in Int Cell Mol Biol, 334: 99-175.
- Kim J., Inoue K, Ishii, J. et al. (2007) “A microRNA feedback circuit in midbrain dopamine neurons” in Science 317 (5482): 1220-1224.
- Pasquinelli A., Reinhart B. et al. (2000) “Conservation of the sequence and temporal expression of let-7 heterochronic regulatory RNA” in Nature 408: 86-89.
- Wightman B., Burglin T. et al. (1991) “Negative regulatory sequence in the lin-14 3’-untranslated region are necessary to generate a temporal switch during Caenorhabditis elegans development” in Genes & Development 5:1813-1824.
- Bartel D. (2004) “MicroRNAs: Genomics, Biogenesis, Mechanism, and Function” in Cell 116: 281-297.
- Shang R., Lee S. et al. (2023) “microRNAs in action: biogenesis, function and regulation” in Nat Rev Genet 24(12): 816-833.
- Ho P. T. B., Clark, I. M., Le L. T. T. (2022) “MicroRNA-Based Diagnosis and Therapy” in Int J Mol Sci 23: 7167.
- Tingo L., Ahlberg E. (2021) “Non-Coding RNAs in Human Breast Milk: A Systematic Review” in Frontiers of Immunology 12: 725323.
- Loganathan T., Doss G. (2023) “Non-coding RNAs in human health and diseases as biomarkers and therapeutic targets” in Functional & Integrative Genomics 23: 33.
- Wightman B., Ha I., Ruvkun G. (1993) “Posttranscriptional Regulation of the Heterochronic Gene lin-14 by lin-4 Mediates Temporal Pattern Formation in elegans” in Cell 75: 855-862.
- Lee R., Feinbaum R., Ambros V. (1993) “The elegans Heterochronic Gene lin-4 Encodes Small RNAs with Antisense Complementarity to lin-14” in Cell 75: 843-854.
- Ambros V. (2008) “The evolution of our thinking about microRNAs” in Nature Medicine 14 (10): 1036-1040.
Abbandonati al nostro fianco - La lotta di infermiere e infermieri tra esaurimento e riconoscimento sociale
Mesi di agitazione e scioperi per i professionisti della sanità. I sindacati di infermiere e infermieri delle aziende pubbliche contestano la mancanza di accordi con lo stato e mentre scrivo è previsto per il 23 settembre uno sciopero dei lavoratori della sanità privata e delle RSA che coinvolgerà oltre 200.000 persone.
Lo scorso maggio a Cagliari un grosso sciopero di infermieri denunciava il carico di lavoro esagerato a fronte di una continua carenza di personale. Alla fine di agosto la protesta coinvolgeva i lavoratori delle province di Grosseto, Siena e Arezzo. Infermieri e infermiere, operatori socio-sanitari, amministrativi, ostetriche e tecnici sanitari hanno limitato la disponibilità alle richieste dell’azienda sanitaria
Le principali richieste: assumere per far fronte all’importante e perdurante carenza di personale. Aumentare i salari e le possibilità di carriera interne alla professione, garantire ferie e malattia. Implementare dispositivi per la sicurezza sul lavoro e tutela dalle malattie e dalla violenza dei pazienti.
LA DIMENSIONE DELL’ABBANDONO DEGLI INFERMIERI
Quanti ne manchino alla nostra sanità per funzionare è difficile da quantificare. Lo scorso febbraio il ministro della salute, Orazio Schillaci, dichiarava che la mancanza di personale si attesta sulle 10.000 persone. Ben più alto il dato fornito da Walter De Caro (presidente di CNAI – Consociazione Nazionale Associazioni Infermieri/e) a maggio in occasione della Giornata Internazionale dell’Infermiere. De Caro stima la necessità di un’integrazione di 100/200 mila professionisti. Cifra, quest'ultima, che varia a seconda degli indicatori di cui si tiene conto, ma in ogni caso lontana da quella del Ministero.
Lo stesso Ministero, in un report del 2023 relativo al periodo 2021-2022, osservava un lieve incremento generale del personale di salute pubblica, ma l’abbandono di oltre 15.000 tra infermieri e infermiere con contratto a tempo indeterminato. Difficile parlare di normale ricambio: il 18% di questi abbandoni avviene infatti nei primi due anni post-laurea. A questo si aggiunge il triste dato di un 20% che lascia del tutto il settore sanitario, pubblico o privato, rinunciando alla professione.
Certo, il governo ha cercato di colmare questi vuoti con timide iniziative come l’aumento dei posti nelle facoltà di Infermieristica. Al test d’ingresso 2024, tenutosi a inizio di settembre, i posti a concorso erano 20.435 (+3% rispetto al 2023) e le domande sono state 20.715 (-4,2%). Un rapporto tra domanda e posti che sfiora l’1 mentre in altre professioni sanitarie è ben più elevato (Fisioterapia 6,7; Osteopatia 4,8; Ostetricia 4,2) e che deve tenere conto di tutti coloro che non riusciranno a passare il test.
IL PROBLEMA PER GLI INFERMIERI È RIUSCIRE A SVOLGERE LA LORO PROFESSIONE
Leggendo uno studio pubblicato su Eurohealth nel 2023 il problema assume dimensioni internazionali (pur con le dovute differenze di trattamento e stipendio). A incidere sui numeri dell’abbandono sono, secondo i ricercatori,
1) gli effetti del periodo pandemico, il cui carico di lavoro in condizioni estreme ha comportato un grosso esodo di professionisti sanitari.
2) L’invecchiamento delle nostre società e il correlato aumento di malattie croniche aumenta la domanda di assistenza, a fronte di un’offerta limitata dai pochi professionisti formati.
3) Assenza di pianificazione per le sanità pubbliche.
4) Un mercato del lavoro non favorevole: stipendi bassi e soprattutto poche possibilità di carriera che non permettono adeguati aumenti di stipendio in rapporto a esperienza, formazione e anzianità.
Ora, quali sono le proposte di questi ricercatori? Una riflessione a partire dai dispositivi economici che l’Unione Europea può mettere in atto. Aumentare gli stipendi. Proteggere lavoratori e lavoratrici dai rischi di infezione così come dalla violenza nei luoghi di lavoro. Prendersi carico della loro salute mentale e del loro benessere dentro e fuori il luogo di lavoro (M. Wismar, T. Goffin, 2023).
Qui è il punto. Il lavoro è diventato sempre più duro e pericoloso. È richiesta continua preparazione clinica e all’uso di nuove tecnologie mentre il contesto lavorativo a malapena rende possibile compiere adeguatamente la professione. La carenza di personale comporta turni infiniti, congedi e malattie respinte, ferie interrotte (quando non “eliminate” dal contratto). E queste carenze ricadono poi sulla percezione che la società ha degli stessi infermieri, essendo loro il punto di contatto principale e quotidiano tra pazienti e istituzione ospedaliera.
CHI PUÒ ABBANDONA, CHI NON PUÒ TIENE DURO A CARO PREZZO
In un recente studio realizzato tra il 2022 e il 2023, il 45% di infermiere e infermieri si dichiaravano disposti a lasciare il lavoro entro un anno se ce ne fosse stata la possibilità. Nello stesso campione (3200 persone ca. da 38 presidi ospedalieri italiani), il 40% risultava soggetto a stress emotivo elevato, un quinto di loro erano a forte rischio di depressione maggiore (Bagnasco et al. 2023).
Nello stesso studio, una collaborazione tra Università di Genova e Fnopi, le cause dell’insoddisfazione venivano fatte risalire (tra le altre) a stipendio (78%) e mancanza di avanzamenti professionali (65 %). La quasi totalità dei partecipanti indicava nell’aumento di organico e nella maggiore autonomia la soluzione.
Crisi di vocazione, scarsa volontà di lavorare e attaccamento al denaro insomma. Atteggiamento che non stupisce soprattutto nei giovani. È così?
No. Il 70% delle persone interrogate nello studio UNIGE/FNOPI dichiarava di essere in numero insufficiente per prestare cure di qualità al paziente e il 45% denunciava la mancata applicazione di una filosofia della persona. A questo si aggiunge la generale sensazione di non essere ascoltati dalla governance aziendale.
Vengono così a mancare le cure essenziali allo svolgersi di una giornata ospedaliera (per noi, che veniamo allettati!). A esempio la mobilizzazione per evitare le piaghe da decubito o la nostra educazione come pazienti e le informazioni relative alle terapie in atto. Chi lavora si accorge di queste mancanze, ma fatica a prestare attenzione alla routine quotidiana dovendo vivere in una continua situazione di emergenza. Non si parla solo della pandemia, basta prendere uno studio del 2019 per farsi un’idea di quanta letteratura esista sul burnout nella professione infermieristica. Esaurimento che si presenta con una prevalenza del 30% fino al 60% e osservato già da un decennio almeno (si veda a es. A. Dordoni et al., 2019).
IDENTITÀ PROFESSIONALE, AMBIENTE SOCIALE E RUOLO IN SOCIETÀ
Il problema ha radici più profonde e una di queste affonda nel terreno sociale. Il ruolo sociale di infermiere e infermieri come professionisti sanitari fatica ancora oggi a venire riconosciuto. Un ruolo che certo a che fare con vocazione e motivazioni personali, ma che altrettanto è prodotto dalle interazioni con gli altri così come dai contesti sociali e lavorativi (Miao et al. 2024).
La categoria ha un profilo professionale dal 1994 e dal 1999 è riconosciuta, per legge, come professione sanitaria con relative responsabilità. Nonostante questo, è ancora difficile che a infermieri e infermiere venga riconosciuta l’importanza del loro servizio per la comunità.
Fa sorridere leggere in un articolo pubblicato su ANSA che un italiano su due riconosce l’importanza del ruolo sociale degli infermieri. Un italiano su due. L’altro italiano dei due ancora non vede un professionista con competenze e conoscenze cliniche. Anche dopo il covid, finita l’epoca di eroi ed eroine, sono tornati a essere suore caritatevoli e servi del dottore.
E cruciale è la percezione esterna. Esterna, ma portata all’interno del luogo di lavoro da ogni paziente e dalle scelte amministrative e politiche riguardanti i presidi ospedalieri. Una percezione negativa può portare a un conflitto tra i ruoli. Perché dovrei fare l’infermiere? Che cosa sto facendo qui? Perché sacrificare per questo i ruoli famigliari, amicali e altri possibili ruoli lavorativi riconosciuti? Il conflitto sfinisce, logora e mina le forze, già provate, con cui la persona affronta quel mondo di emergenza continua che è il lavoro in reparto.
Non possiamo dire a una persona di provare emozioni positive per evitare il rischio di esaurimento. Possiamo disporre, come società e come individui, un ambiente lavorativo salubre e dare a queste persone il giusto riconoscimento professionale. L’ambiente di lavoro è prodotto e produce l’attività quotidiana, ripetitiva, di cura. La ripetizione può essere quella della frustrazione, del fallimento, dei rapporti trascurati e degli errori clinici. Al contrario, l’ambiente sociale può permettere che a ripetersi siano la relazione col paziente, i corretti trattamenti, la crescita personale e professionale.
NOTE
A. Bagnasco et al. (2023) “Benessere professionale dell’infermiere e sicurezza delle cure in epoca pandemica” in L’Infermiere 60 (4): 164-177.
A. Dordoni et al. (2019) “Relazione tra burnout infermieristico, qualità dell’assistenza e errore clinico” in L’infermiere 4: 44-54.
C. Miao et al. (2024) “Nurses’ perspectives on professional self-concept and its influencing factors: A qualitative study” in BMC Nursing 23: 237.
M. Wismar, T. Goffin (2023) “Tackling the Health Workforce Crisis: Towards a European Health Workforce Strategy” in Euroealth 29 (3): 22-26.
Il contagio corre su internet - Malattie social-media-mente trasmissibili
Melanconie
Secondo Agamben (1979) non si sono mai aggirati per l’Europa tanti fantasmi come nel Medioevo. Il problema non è da ricondurre alle superstizioni del periodo, ma alle regioni più elevate della scienza del periodo Scolastico: alla fantasia e ai suoi prodotti, i fantasmi, spetta un ruolo centrale nella teoria della conoscenza. Sono immagini quelle che i sensi catturano dalla realtà, ma è compito della fantasia trattenerle e svilupparle nel sistema di specchi che in cui si articola la parte più spirituale della razionalità – quella speculativa. Il Medioevo era, quindi, più ossessionato dall’immagine di quanto lo sia la nostra epoca; ha anche elaborato una riflessione raffinata sull’ossessione, tanto che la nozione stessa di «idea fissa» è in debito con le concezioni medievali della «melanconia», e con il potere degli spiriti intermedi (o dei demoni) di imprimere un’immagine nella fantasia senza permetterle di focalizzare più alcun’altra figura. Il suo oggetto non esiste, ma questa evidenza non le impedisce di sbarrare la strada verso la propria realizzazione, che è l’imitazione di Cristo, e di riconoscere la vera felicità, che è Dio.
Le fibre dell’isolamento
Il testo di Leslie Jamison - Esami di empatia - mostra che, in età contemporanea, le immagini continuano a fissarsi nello stesso modo, con la sola differenza che l’agente non è più un demone ma Internet, e il gioco degli specchi coinvolge anche gli altri soggetti che condividono la stessa monomania, e che con la loro approvazione rendono l’ossessione abitabile, oggettiva, invalicabile, meglio di quanto potessero fare i vecchi spiriti.
Tra i fantasmi descritti da Jamison, due evidenziano meglio il carattere autodistruttivo dell’ossessione: due malattie che contagiano in prevalenza le donne, due epidemie che hanno cominciato a espandersi dopo il 2001 e che hanno trovato nei canali di Internet il veicolo principale, anche se con due destini del tutto diversi.
La prima delle due è stata tenuta a battesimo su un forum online da Mary Leitao, una biologa tecnica di laboratorio, che l’ha etichettata «morbo di Morgellons», sulla base dei sintomi censiti in una rivista medica francese del Seicento. Una dermatite che può originare anche dolore e irritazioni, e che costringe il paziente a grattarsi fino all’escoriazione, è l’anamnesi della malattia di cui soffre anche il figlio della Leitao, e che nessun medico è riuscito a ridurre ad una diagnosi convincente. Nelle piaghe provocate dagli strofinamenti per lenire il prurito, come aveva pronosticato Thomas Brown mentre esaminava i ragazzi (i «Morgellons») della regione di Languedoc, la biologa ha rintracciato fibre sottili e granelli scuri. A questi corpi estranei si dovrebbe imputare l’infezione e il dispiegamento dell’intera collezione di sofferenze connesse; ma la rivelazione che la filologia ha consegnato alla Leitao è rimasta una scoperta malinconica, una verità ripudiata e stigmatizzata come eresia dalla comunità medica. Secondo la scienza istituzionale le cause del morbo risalgono ad una sindrome di «Münchausen by proxy», una reazione auto-immune ipertrofica indotta da paranoie di vario genere, insieme al bisogno di ottenere attenzioni.
Dalla metà degli anni Duemila la Fondazione Charles Holman convoca una volta all’anno ad Austin, nella Chiesa di Westoak, i pazienti di Morgellons che si sentono traditi dalla medicina ufficiale, per sviluppare colloqui tra malati e ricercatori. Quando Jamison ha partecipato all’evento nel 2012 ha incontrato persone con un’immagine di sé stesse del tutto distorta – ma adeguata all’isolamento sociale cui sono consegnate dalla loro condizione economica, lavorativa, famigliare. La malinconia che opprime queste conversazioni – interviste, o saggi di empatia – riesce a far coincidere i confini del concetto medievale con la nostra nozione di prostrazione emotiva. Le pazienti, anche quelle che a giudizio della giornalista godono di un aspetto attraente, si percepiscono sfigurate dalle macchie e dalle piaghe della dermatite, e accettano la conseguenza di consegnarsi ad un destino di clausura, il cui unico contenuto è l’ispezione delle proprie ulcere, alla ricerca di filamenti e di micro-frammenti scuri. Al convegno di Austin i «morgi» ritrovano un’identità nel nome proscritto del loro morbo, nella censura che è ad un tempo dannazione e salvezza della loro comunità. Il riconoscimento reciproco si ferma a questa assenza o a questo esilio, e la compresenza nella Chiesa di Westoak è una giustapposizione di solitudini che non si parlano, separate dalla varietà dei sintomi e delle convinzioni sulla natura del contagio, ma soprattutto dall’introversione dell’autoesame, dall’ossessione per gli specchi e le lenti di ingrandimento.
La sindrome dell’influencer
Decine, se non centinaia di migliaia di Morgellons sono stati curati dai medici con una combinazione di antinfiammatori e di ansiolitici: alcuni si sono fatti guidare dalla terapia e sono guariti, altri sono rimasti imprigionati dalla sindrome. Una sorte del tutto differente è toccata all’altra malattia, che nelle pagine della Jamison è ancora senza un nome ufficiale: la vulvodinia non è una sindrome per diseredati, ed è stata sostenuta dalla testimonianza di numerose influencer sui social media. La legge presentata nel 2022 In Italia al Senato vantava come ambassador Giorgia Soleri, influencer su TikTok e – a quel tempo – fidanzata di Damiano dei Måneskin. Sui media istituzionali le pazienti vengono contate con percentuali di vaste proporzioni (10%-15% di tutte le donne), senza mai citare la fonte del dato: denunciano una sofferenza nell’area genitale, per la quale i medici non riescono a risalire ad una causa fisiologica univoca. In questo caso però le testimoni sono di riguardo, e come ricostruisce Fontana (2024), qualunque contestazione della loro posizione viene stigmatizzata come un rigurgito di patriarcato che ancora scuote l’inconscio della comunità scientifica. Gli influencer non possono essere accusati di Schwärmerei, la possessione fanatica che Lutero imputava ai contadini ribelli di Melantone (sostenitori della Riforma luterana ma antagonisti dell’aristocrazia feudale con cui Lutero aveva stretto un’alleanza politica), e che i medici rintracciano nei Morgellons: non li si può accusare di non essere padroni della loro parola, di essere solo il veicolo della voce dei demoni che li abitano. Quindi l’OMS ha riconosciuto la formazione di questa nuova identità morbosa, e della comunità di cittadini che ne soffre, e l’ha iscritta nell’ICD-11, con il nome in cui si riconoscono i suoi pazienti.
Il potere di dire la verità
La comunità scientifica è incompatibile con i Morgellons ma compatisce la vulvodinia. Nel primo caso occorre liberare l’anima da un demone, che assoggetta gli individui a immagini capaci di fissare un discorso eretico nella mente, e di trasformare il corpo nel teatro che lo mette in scena. Nel secondo caso i pazienti sono peer reviewer di un discorso scientifico che, attraverso la diagnosi della malattia, contribuisce a liberare l’identità femminile (e l’intera società, che nella soggettività femminile trova la sua espressione più avanzata) dai pregiudizi riemergenti del patriarcato. Jamison presenta una galleria di saggi di empatia, in cui tenta di restituire a questo termine un contenuto sperimentale, una comprensione dell’altro attraverso l’adesione alla sua identità, la partecipazione alle condizioni che imprimono sulla sua vita la forma della sua individualità, con una pressione che è passione e patologia. Nelle sue pagine la vulvodinia si afferma come il dolore che la tradizione occidentale incide nel corpo delle donne nell’assegnarle al genere femminile: una forma di potere di coesione sociale che è congruente e accessibile al regime classificatorio del potere di veridizione da parte della comunità scientifica. I Morgellons sono l’espressione di un’esclusione, l’introiezione di un esilio sociale che li isola anche l’uno dall’altro: un esercizio congruente con la pratica del potere scientifico di rimuovere ciò che non deve appartenere alla tassonomia dell’oggettività, di rigettare la soggettività chi non ha abbastanza forza per partecipare alla peer reviewing.
O forse la vulvodinia è uno degli ultimi compromessi che le comunità di internet cercano di stabilire con le procedure e gli attori delle istituzioni tradizionali, in attesa che le identità modellate online non abbiano più bisogno di altro credito se non l’autonomia della propria fondazione per abitare il proprio mondo, sovrapposto e incompatibile, anempatico, con quelli posseduti dagli altri.
BIBLIOGRAFIA
Agamben, Giorgio, Stanze, Einaudi, Torino 1979.
Fontana, Laura, Il complesso mondo delle malattie “Internet-based”, «Link», 19 febbraio 2024.
Jamison, Leslie, The Empathy Exams, Graywolf Press, Minneapolis 2021.
No news, bad news – Covid, due anni dopo: delle non-notizie che devono far riflettere
Alcuni giorni fa, uno dei più autorevoli quotidiani italiani ha pubblicato l’articolo “Il Covid, il laboratorio di Wuhan e le accuse rilanciate dal Nyt sulle responsabilità Usa: «Potrebbe essere stato l’incidente più dannoso nella storia della scienza»” sull’ipotesi che la diffusione del virus Sars-CoV-2 abbia avuto origine da un laboratorio di ricerca sui virus del ceppo Sars, a Wuhan, in Cina.
L’articolo del quotidiano italiano riprende un analogo testo del New York Times, intitolato “Why the pandemic probably started in a Lab – in 5 points” che “rilancia con forza l’ipotesi che il virus Sars-Cov-2 sia stato creato in laboratorio” e, inoltre, “lancia un atto di accusa ancora più pesante: che quel laboratorio abbia creato il virus nell’ambito di un progetto di ricerca a cui hanno collaborato organizzazioni americane finanziate dal governo degli Stati Uniti.”
A sostegno di questa ipotesi, il NYT (e il quotidiano italiano che dà spazio alla notizia) si appoggia all’opinione di Alina Chan, biologa molecolare canadese presso il MIT, autrice del libro Viral: The Search for the Origin of Covid-19 (Chan A. e Ridley M., New York: Harpers Collins, 2021), libro in cui utilizza queste presunte prove a suffragio della sua ipotesi:
- La pandemia è iniziata a Wuhan, dove si trovava il più importante laboratorio di ricerca sui virus simili alla Sars;
- Nel 2018 il laboratorio di Wuhan, in collaborazione con EcoHealth Alliance (un’organizzazione scientifica americana che è stata finanziata con 80 milioni di dollari dal governo degli Stati Uniti) e l’epidemiologo dell’Università del North Carolina Ralph Baric, aveva elaborato un progetto di ricerca, chiamato Defuse, in cui progettava di creare virus simili al Sars-Cov-2;
- I livelli di sicurezza del laboratorio di Wuhan (cioè le misure per evitare il rilascio accidentale di virus) erano molto più bassi di quelli richiesti dagli standard di sicurezza delle strutture di ricerca americane;
- Non ci sono prove sostanziali per dire che lo spill-over, cioè il contagio da un’altra specie animale all’uomo, sia avvenuto in un mercato di Wuhan, come sostenuto dai cinesi.
Chan sottolinea, scrive il quotidiano italiano, che è perlomeno peculiare che «un virus simile alla Sars mai visto prima, con un sito di scissione della furina di recente introduzione, corrispondente alla descrizione contenuta nella proposta Defuse dell’istituto di Wuhan, ha causato un’epidemia a Wuhan meno di due anni dopo la stesura della proposta».
L’articolo continua affermando che “Tutto questo fa pensare che l’ipotesi di un virus costruito in laboratorio sia la più probabile.”
Ora, se proviamo ad analizzare il contenuto della narrazione, emerge che:
- il libro di Chan è del 2021;
- gli elementi a favore dell'ipotesi fuga dal laboratorio sono tratte dal libro di Chan, quindi sono datati 2021;
- l'articolo dice che non ci sono prove sostanziali per dire che lo spill-over sia avvenuto da animale non umano ad animale umano al mercato di Wuhan;
- tuttavia, non sembra fornire prove sostanziali del contrario, cioè del fatto che il virus sia stato creato nel laboratorio di Wuhan né, tantomeno, che da quel laboratorio sia sfuggito.
David Hume non avrebbe dubbi: il nesso causale che l’articolo suggerisce tra ricerca a Wuhan e diffusione del virus è illusorio; al massimo si tratta – in assenza di altre prove sostanziali – di un caso di contiguità temporale e di posizione.
Quindi, non sembrano esserci notizie nuove sull’origine della diffusione del virus, ma solo congetture, coincidenze, contiguità non causali, dette 3 anni fa.
Perché, quindi, il New York Times e il quotidiano italiano dedicano la loro attenzione a delle non – notizie?
Perché nei giorni precedenti, Anthony Fauci, immunologo a capo del National Institute of Allergy and Infectious Diseases fino al 2022, e guida della strategia degli Stati Uniti sul Covid, è stato sentito alla Camera statunitense sulle (presunte) responsabilità del governo USA nella pandemia e sul suo (presunto) ruolo nell’averle nascoste; durante l’audizione, Fauci ha dichiarato: «È falsa l’accusa che io abbia cercato di coprire l’ipotesi che il virus potesse essere nato da una mutazione creata in laboratorio. È vero il contrario: in una email inviata il 12 febbraio 2020 chiesi di fare chiarezza e di riportare alle autorità preposte».
Le vere notizie, quindi, sembrano essere queste:
- che prendendo spunto dalla deposizione di Fauci, che ha dato spunto a un articolo del NYT, che a sua volta non dà altre notizie, il quotidiano italiano tratta come notizia il fatto che non ci sono notizie e prova, in questo modo sottile, a sostenere l'ipotesi di Chan, trattandola in modo che sembri altamente probabile;
- che il rilancio dell’ipotesi di Chan, più che sulla solidità fattuale e causale, e a dispetto della dimensione fortemente congetturale, è fondato sull’autorevolezza della ricercatrice, “che lavora al Massachusetts Institute of Technology (Mit) e ad Harvard”[1]
- che il NYT e il quotidiano italiano usano una notizia politica (l’audizione di Fauci) per parlare d’altro, altro in cui non ci sono affatto notizie, ma solo riesumazione di congetture, per di più datate.
C’è, però, un’ultima notizia, più importante, da leggere fra le righe: che non si parla seriamente di un’ipotesi - quella della produzione in laboratorio del virus e della possibile “fuga” – che, invece, meriterebbe indagini e approfondimenti seri, circostanziati e trasparenti; non tanto per attribuire responsabilità, ma per capire:
- se e dove vengono fatte ricerche su agenti virali ad alto rischio;
- come vengono fatte;
- e soprattutto perché vengono fatte e quali sono le fonti dei finanziamenti che le rendono possibili.
NOTA
Tutti i corsivi virgolettati sono tratti dall’articolo Il Covid, il laboratorio di Wuhan e le accuse rilanciate dal Nyt sulle responsabilità Usa: «Potrebbe essere stato l’incidente più dannoso nella storia della scienza», Corriere della Sera, 4 giugno 2024.
[1] Sul tema del ruolo dell’autorevolezza degli scienziati si può vedere: Gobo G. e Marcheselli V, Sociologia della scienza e della tecnologia, Carocci Editore, 2021, Cap. 7; Collins H.M. e Evans R., The third wave of science studies: studies of expertise and experience, in “Social studies of science”, 32, 2, pp. 235-96; Collins H.M. e Pinch T., Il Golem, Edizioni Dedalo, 1995, Cap. VI.
Seveso, 1976 - Il Comitato tecnico scientifico popolare: nascita e programma di lotta
La conservazione delle tracce del “disastro” dell’Icmesa e di quello che ne seguì è stata una pratica che accomuna le persone di Seveso e dei comuni limitrofi: le memorie sevesine sono sepolte nel sottobosco del Bosco delle Querce e nelle cantine delle case private. È come se a Seveso esistesse un mondo di sotto che si è stratificato con il passaggio della nuvola-nube nel mondo di sopra e che, se sollecitato, riaffiora.
-----
Ricercando questo mondo sotterraneo, una delle storie che riemerge è quella del Comitato tecnico scientifico popolare. In una video-intervista conservata da “Archivio Seveso. Memoria di parte”, uno degli studenti di medicina protagonisti del CTSP ne ricorda la genesi e la composizione eterogenea, che coinvolgeva studenti, operai, medici, sindacalisti. L’intervistato, quando si è sprigionata la nube tossica a Seveso, era un giovane laureando in medicina e ricorda che nei momenti immediatamente successivi al “disastro” nella sua facoltà si era formato un gruppo di persone che volevano approfondire questa situazione, a partire «dalla situazione reale, dalla situazione della gente»[1].
È nato così il CTSP, a partire da alcuni operai del Consiglio di Fabbrica, da studenti che stavano finendo la facoltà di medicina, da professori universitari, come Giulio Alfredo Maccacaro, e da sindacalisti.
Tra i materiali conservati nell’“Archivio Seveso. Memoria di parte” sono presenti i documenti, i ciclostilati, le lettere e i volantini del CTSP.
Il Comitato esplicitò i propri obiettivi nel bollettino pubblicato nel settembre del 1976, ponendosi in contrapposizione con l’operato delle istituzioni locali, regionali e nazionali che – secondo il CTSP – avevano coperto e soffocato ogni tipo di protesta e di organizzazione degli abitanti della zona, non fornendo sufficienti informazioni sulla situazione per fare maturare una consapevolezza collettiva del rischio.
Rifiutando il principio di delega, il CTSP intendeva allargare il proprio intervento attraverso il coinvolgimento degli organismi di base della zona, degli organismi medici e socio-sanitari.
Le proposte del Comitato insistevano:
- sull’educazione e sull’informazione sanitaria,
- sulla necessità di accertamenti sanitari e scientifici controllati dal basso,
- sull’importanza di un’opera di controinformazione atta a impedire qualsiasi tentativo di insabbiamento di responsabilità dell’industria, delle strutture scientifiche istituzionali e delle forze politiche.
Un altro aspetto importante per il Comitato era la generazione di una forma di lotta popolare mirata alla bonifica delle zone contaminate, alla salvaguardia del posto di lavoro, all’abbattimento della nocività nelle fabbriche e nel territorio e alla costruzione di nuovi servizi sanitari di base[2]. Per realizzare questi propositi, gli attivisti del CTSP proponevano un «programma di lotta» che intrecciava le questioni particolari e urgenti di Seveso con la dimensione di una lotta generale e strutturale.
Per questo oggi non possiamo limitarci a chiedere che vengano attuate solo le misure più urgenti in favore delle popolazioni colpite. Non basta rimediare ai disastri più gravi causati dalla nube: se non vogliamo un’altra Icmesa, dobbiamo batterci subito per cambiare le condizioni di lavoro in fabbrica e abbattere la nocività, per ottenere un’assistenza sanitaria realmente orientata alla prevenzione, per conquistare nuovi servizi sociali, a partire dalla casa (Asmp, b. CTSP, Bollettino del Comitato tecnico scientifico popolare, settembre 1976).
----
Il passaggio dalla dimensione particolare a quella generale si inseriva nell'eccezionalità del “disastro” sevesino perché per la prima volta in Italia la nocività non rimaneva un problema solo interno alla fabbrica, ma usciva ed «esplodeva letteralmente sul territorio» (Intervista ad abitante di Seveso, gennaio 2024).
Secondo il CTSP, per rispondere alle domande che la vicenda dell’Icmesa aveva sollevato in merito alla relazione tra lavoro, salute e ambiente, era necessario organizzare una mobilitazione operaia, territoriale e di massa.
Si trattava di una proposta che si opponeva alla marginalizzazione di chi era stato colpito dalla “nuvola-nube” e cercava di combinare il rifiuto della semplice fruizione di ordinamenti esistenti con la richiesta di partecipazione attiva (Koensler, Rossi 2012, p. 7).
La pratica militante del CTSP tentò – quindi - di portare fuori dalla fabbrica gli strumenti di indagine e di inchiesta di cui il movimento operaio si era dotato per portare la soggettività operaia al centro delle lotte dei lavoratori (Carnevale, Baldasseroni 1999, pp. 230-283).
Così le pratiche utilizzate per capire le conseguenze sanitarie e ambientali della diffusione della diossina affondavano le loro radici in una concezione della medicina non “oggettiva”, ma che si poneva l’obiettivo di coinvolgere direttamente gli abitanti delle zone colpite. La soggettività delle persone coinvolte era il punto di partenza per le ricerche scientifiche del CTSP.
L’idea di salute e di cura proposte si basavano sull’inclusione delle persone che nei territori contaminati vi abitano all’interno del discorso, perché il loro sapere e i sintomi accusati, in un tempo preciso e in un luogo determinato, sono fonti di conoscenza fondamentali per la pratica medica.
Il Comitato, a partire dalle esperienze dei gruppi omogenei di fabbrica, e dalle loro elaborazioni di salute e malattia, concepiva la salute nel quadro di una liberazione di sé,
«dove i soggetti devono avere voce e non subire le decisioni degli ospedali che non sono mai neutre»
(Intervista ad abitante di Seveso, gennaio 2024).
Ammalarsi è una realtà sociale che mette in gioco rapporti di potere ed è espressione di molteplici modi di incorporare l’ordine socio-economico e le sue disuguaglianze che pongono gli individui e le comunità di fronte a rischi differenti.
Soprattutto chi viveva a Seveso ed era da pochi anni immigrato nella Brianza produttiva in cerca di lavoro, ha incorporato la produzione nociva e pericolosa dell’Icmesa (incorporation de l’inégalité), ha sperimentato il potere locale, regionale e nazionale incapace di guarire (pouvoir de guérir) e il governo della vita attraverso controlli biologici, evacuazioni, limitazioni e ordinanze (gouvernament de la vie).
Secondo gli studi del medico-antropologo Didier Fassin (Fassin 1996), le tre dimensioni appena menzionate costruiscono lo spazio politico della salute (Fassin 1996) ed è in esso che il CTSP ha giocato un ruolo fondamentale – anche se oggi è quasi dimenticato – a Seveso per praticare e diffondere una concezione di salute e di medicina al servizio della popolazione e a partire dalla soggettività di quest’ultima, proponendo lo sviluppo di un’«eziologia politica» (Nguyen, Peschard 2003) delle patologie insorte in seguito al “disastro”.
NOTE
[1] Asmp, b. CTSP, Interviste-documentario “Seveso Memoria di parte”.
[2] Asmp, b. CTSP, Bollettino del Comitato tecnico scientifico popolare, settembre 1976.