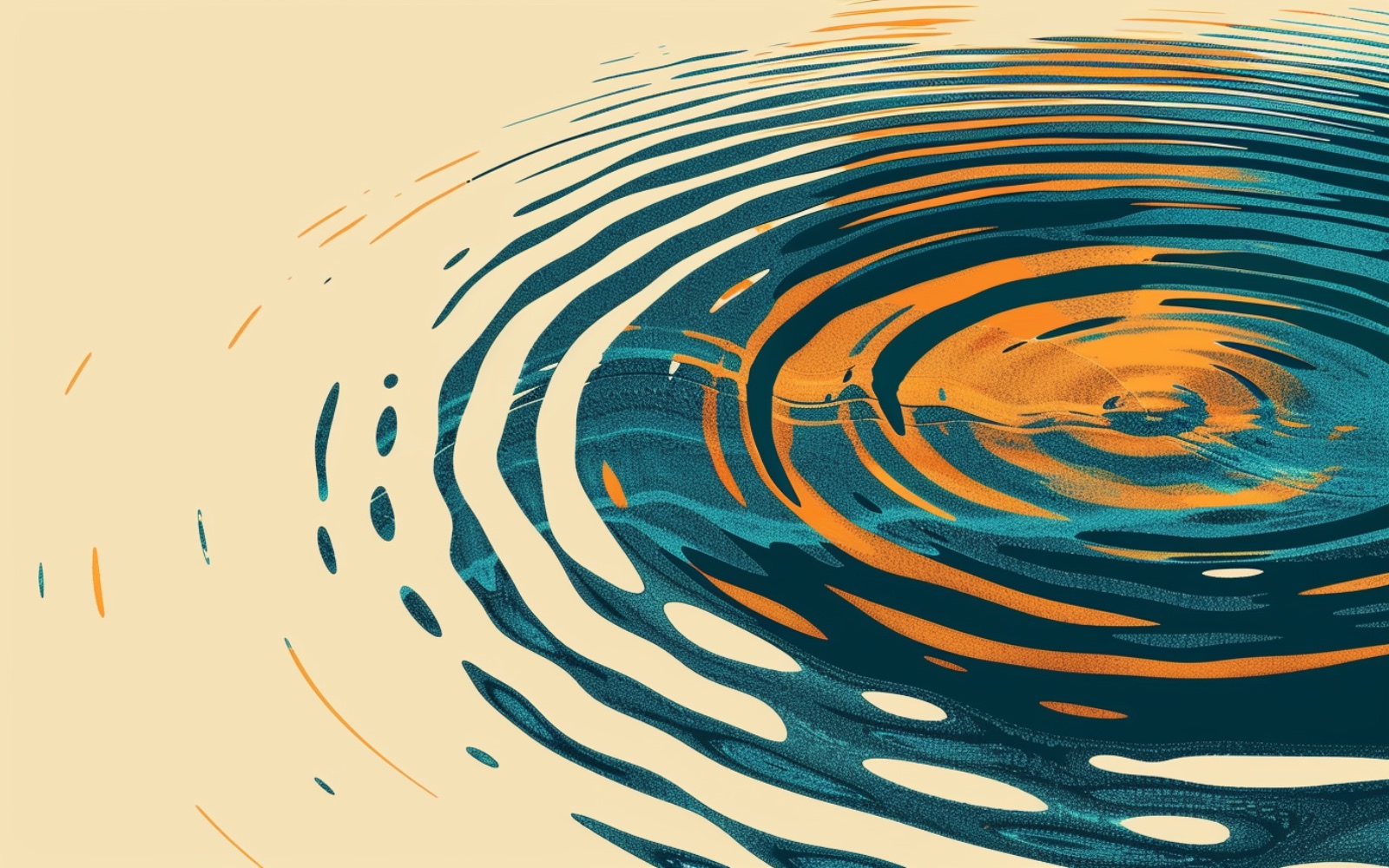Un pensiero per coloro che periscono di certezza
Alla lunga, diventa piuttosto insostenibile vagare con il solo scopo di diffondere opinioni nate altrove. Per questo, inizio con un’ammissione di colpevolezza, forse più d’una.
Prima ammissione: questa risposta, pensata in origine come contraltare all’articolo di Matteo Donolato sul caso del sovraesteso femminile, è stata riscritta più volte di quanto mi piacerebbe ammettere. Al punto che mi ero convinto che valesse la pena scrivere un collage che comprendesse tutte le versioni precedenti. Sarebbe stata un’opzione molto democratica e molto moderna, sufficientemente paritaria. C’era tutto, pro e contro, e tutti nati in seno ad una stessa persona, che poi sarei io…
Seconda ammissione, corollario della prima: devo confessare di essere stato sballottato a fasi alterne dall’una all’altra parte della staccionata, e con altrettanta momentanea convinzione, con fretta e foga, ho interpretato il burattino degli uni e degli altri, di chi ci sta e di chi non ci sta. Ed ogni volta bisognava analizzare, e poi giudicare e condannare o perdonare. Arrivavo alla fine, e quel minimo di non-so-bene-cosa mi faceva scrivere, ad ogni conclusione, «che idiota!».
Dunque, ricomincio. C’è il fatto, lo strano caso del sovraesteso femminile: l’Università di Trento decide di andare per la via della provocazione, ogni professione indicata al maschile nei documenti d’Ateneo diverrà femminile, dunque sovraesteso. Ogni presidente è ora presidenta, ogni studente può diventare studentessa - the sky is the limit!
A dirla tutta, non nasce interamente come “caso”, lo diventa. Ci sono due rami della questione. Da una parte, mediaticamente, la divisione si forma sulla capacità divisiva dell’atto stesso, dall’altra questo stesso effetto di polarizzazione fomenta, in un fenomeno di feedback, l’amplificarsi della questione. Ecco, all’orizzonte, il «caso mediatico», il cui intimo meccanismo reclama la polarizzazione come elemento necessario per la sua riuscita, anzi, per la sua stessa esistenza.
Se tutto va a buon fine, da qualche parte si imbandisce un panel televisivo saggiamente strutturato per raccogliere il peso della provocazione e semplificare il tutto in una disputa tra contendenti. L’amplificazione iniziale funziona come una disseminazione ad alta velocità, «bisogna che se ne parli». Diversamente, lo scontro mediatico raccoglie i frutti con una sorta di sistema ad imbuto per generare categorie altamente digeribili. Rallenta il tempo, si distilla una suddivisione semplice delle parti contendenti: chi sta di qua e chi sta di là. È tutto propedeutico al nutrimento dell’ascoltatore. Due opinioni opposte l’una all’altra, ma sufficientemente chiarificate, possono essere distribuite al popolo, che a sua volta produrrà ancora una volta un effetto a cascata verso il basso. Così, la buona novella circola per il mondo, molto più semplice e strutturata di prima, e ciascun talk show si ripete in ogni bar che offra da bere del bianchino alle dieci del mattino, o qualche spritz all’happy hour.
Ma stai di qua o stai di là?
Se non hai deciso una parte, allora cosa parli a fare?!
Innanzitutto, pazienza… e dubbio che, a intenderlo propriamente, dovrebbe essere il metodo per sviare da questo inferno. Se dico «propriamente», è perché la polisemia di dubbio rischia di generare - ahimè - un ulteriore dubbio, dunque riformulo.
In un primo senso, dubitare contraddistingue un modo dell’intelligenza di procedere in avanti: dubito tra questa e quell’opzione. Nei limiti del possibile, possiamo chiamarlo un fatto di «problem solving». Quando dubito se sia meglio andare a destra o a sinistra, non dubito della mia inclinazione a giungere alla destinazione che mi sono precedentemente prefissato.
Dall’altra parte, con «dubbio» potremmo intendere ciò che da Henri Bergson in poi chiamiamo «l’inversione del normale corso di pensiero»: andare indietro, piuttosto che in avanti. Non consiste nel dubitare di quale opzione favorire - cosa scegliere dal menu o quale strada sia più favorevole al raggiungimento della meta -, ma piuttosto dubitare del modo nel quale le opzioni sono poste - sarà il menù giusto? Perché vado dove vado?
Non è più un’operazione dell’intelligenza dettata dal superamento di un ostacolo, ma più propriamente un atto del pensiero e della riflessione e…del dubbio.
A proposito di questo metodo, quando l’autore del Saggio sui dati immediati della coscienza (1889) ripropone il classico paradosso di Achille e la tartaruga, la contrapposizione tra spazio e tempo è sviscerata nel medesimo modo: non bisogna partire dalla dicotomia tra spazio e tempo come problema già formato, ma piuttosto risalire fino alla formulazione della questione. Primo lato della questione: siamo sicuri che spazio e tempo vadano posti come sono posti? Secondo lato della questione: perché, ed è una domanda a cui è altrettanto fondamentale rispondere, la dicotomia è stata posta proprio in questi termini?
È un modo di procedere che contraddistingue tutta l’opera bergsoniana: è necessario risalire la catena delle false contrapposizioni, curandosi di dar ragione del perché, in primo luogo, quella falsa dicotomia è venuta ad essere. In Materia e memoria la dicotomia tra idealismo e realismo è denunciata come errore già nelle pagine introduttive, mentre ne L’evoluzione creatrice sono poste in questione le (false) dicotomie tra ordine e caos, finalismo e meccanicismo, e molto altro ancora. Pur con qualche postilla, si può affermare che quello del filosofo francese è un metodo generale del pensiero.
Dunque, nel nostro caso si tratta non soltanto di osservare con scrupolo le opzioni che l’opinione pubblica ci propina, ma di saggiare le modalità stesse di questa produzione di schieramenti e, ultimo ma non ultimo, riflettere sulle ragioni per cui il dubbio che procede a “ritroso” parrebbe, almeno ad un primo e fugace sguardo, essere così sistematicamente avversato.
Perché da ambo le parti c’è una certa fretta, tanto di coloro che con fermezza reclamano la condanna repentina, quanto degli altri che gioirebbero sentendo annunciare che ciò che ieri era provocazione, oggi diventa legge e imposizione; ed ambo le parti sfruttano il “dubbio” solo nel suo senso “semplice”, ossia nel riproporre, piuttosto incessantemente, dei dubbi da risolvere rapidamente tra alternative già determinate: vai di qua o vai di là?
Possibile aver così poca cura di ciò che ci circonda da altalenare tra l’immediato rifiuto del nuovo o la condanna di ciò che è stato, con l’ottusa fiducia che ciò che sarà, per ciò stesso, sarà meglio? Anche l’altalena tra il «nuovo» e il «già stato», direbbe Bergson, è una falsa alternativa.
D’altra parte, nel suo secondo significato il dubbio rivela - almeno potenzialmente - l’inganno delle opzioni, scoprendosi come l’atto stesso di contrapposizione alla fretta delle parti. In virtù di ciò, non è un primariamente un meccanismo deduttivo per risolvere l’incertezza tra le opzioni, ma un metodo di retrocessione per porre sotto esame la creazione stessa del campo di alternative che ci sono proposte.
Se dovessi ipotizzare dove ci porterebbe questa ricerca, in primis si rivolgerebbe con sospetto verso la foga che contraddistingue questi schieramenti della domenica, che il giorno prima ci sono, il giorno dopo spariscono a favore di qualcos’altro. Bisognerebbe indagare psichicamente questa famelica necessità di applaudire e ripudiare, in quello che a tutti gli effetti sembrerebbe una continua fioritura di micro-identificazioni “alla giornata”, il cui funzionamento necessita la ripetizione ininterrotta di nuove approvazioni, così come richiede la brevità temporale di ogni nuova “battaglia”.
In ciò, si rivelerebbe al fondo degli attuali movimenti pseudo rivoluzionari, di cui “la provocazione del sovraesteso” fa parte, la loro ingenuità: a foga e certezza rispondono con foga e certezza, a iper-legiferazione rispondono con altrettanta iper-legiferazione, di conseguenza sono interamente determinati - oso dire prodotti - dal sistema stesso che credono di fronteggiare.
Di conseguenza, tra coloro che ci fanno ballare tra l’innegoziabilità di ciò che è sacro e la rinegoziazione di ogni cosa, la nostra attenzione dovrebbe vertere non tanto sulla valutazione di quale alternativa preferire, ma sulla presentazione stessa di questa alternativa, e delle ragioni storiche e culturali che forzano questo ristretto menù contro i nostri occhi, limitandoci la vista. Scoveremmo, come ho già scritto, il loro modo comune, l’intenzione manifesta di passare per la via dell’iper-legiferazione, che - in aggiunta o parallelamente - non passa più per i soli canali statali o sovrastatali, ma opera con un taglio trasversale tramite sistemi che mimano, ovunque, i tribunali: “giudizio-sulla-rete”, “cancel-culture” e “bolle mediatiche”, sono pienamente in linea con la definizione di questo percorso iperbolico della codificazione.
Scoveremmo tra coloro che difendono a spada tratta una lingua - come se questa fosse nata in seno alla mente brillante di un solo ed eroico legiferatore patriottico - e coloro che professano la possibilità di rinegoziare ogni parola - come se la lingua rinascesse nuova e candida ad ogni mattina - il comune desiderio di agire su vasta scala ad una micro-codificazione della lingua, fin nelle sue più intime fibre, al fine di direzionare le fibre sociali che stanno per essa… almeno in teoria.
Tra i movimenti rivoluzionari della lingua, e i moti controrivoluzionari della cultura, scoveremmo il timore comune di perdere il controllo di ciò che varia - di quel «che varia davvero, nonostante ogni previsione o premonizione» - benché l’una parte se ne dichiari fallacemente a favore, e l’altra esplicitamente contraria.
Una rettrice uomo salverà il mondo?
Il 28 marzo scorso il Consiglio di Amministrazione dell’università di Trento ha deciso per l’uso del femminile sovraesteso in tutti i suoi documenti ufficiali. Ovvero, per esempio, il rettore e il presidente diventano la rettrice e la presidente, anche se si tratta di uomini.
A seguito di questa decisione il rettore Flavio Deflorian diventa la rettrice Flavio Deflorian, il quale (o la quale?) ha così commentato il suo nuovo status: “Leggendolo mi sono sentito escluso. Così ho capito il senso della decisione”.
Il comunicato ufficiale recita: “È il primo caso di atto redatto in questo modo all’Università di Trento. Dall’adozione nel 2017 delle guida sul linguaggio rispettoso delle differenze, prosegue l’impegno dell’Ateneo per la costruzione di un’università più inclusiva”.
L’obiettivo di costruire un’università sempre più inclusiva è senz’altro condivisibile e, d’altro canto, il tema dell’inclusività è diventato uno dei temi più sensibili in tutte le università del mondo occidentale. Nel frattempo io faccio una certa fatica a capire perché nelle università non sia altrettanto popolare, che so, il tema dello sfruttamento dei bambini nelle miniere di litio africane per estrarre il raro minerale indispensabile per far funzionare i nostri pc e le nostre auto pulite… ma vabbè, sto divagando.
Torniamo al punto, naturalmente questa iniziativa ha fatto discutere sui giornali e sui social (ma per quel che ho visto, avrei immaginato un dibattito più caldo e serrato, segno forse che l’iniziativa di UniTrento non è stata presa molto sul serio?). Naturalmente molte voci a favore, provenienti soprattutto dalle aree culturali riconducibili ai movimenti come quello delle transfemministe e, a rimorchio, dai partiti di sinistra; qualche voce scettica, anche a sinistra, e non poche voci ironiche o sarcastiche, non necessariamente provenienti solo da visioni socio politiche di destra o reazionarie.
A questo punto però credo che ci siano due domande da farsi, la prima: una iniziativa di questo tipo ha una funzione di reale utilità nella lotta alle diseguaglianze di genere nella società? E la seconda: è per forza necessario dividersi per schieramenti ideologici (e partitici) su un tema come questo?
Provo a rispondere, a puro titolo personale, a entrambe le questioni. Senza girarci troppo attorno, credo che iniziative come questa non servano assolutamente a nulla per la causa dell’inclusione e, anzi, siano controproducenti. Già, perché ai reazionari con mentalità patriarcale (e chi decide se uno è reazionario con mentalità patriarcale?) un’iniziativa a come questa non solo NON li farà riflettere, ma servirà ad aumentare la loro convinzione di essere “in un mondo di pazzi” dal quale difendersi arroccandosi sulle proprie rassicuranti posizioni.
Poi però serve a poco (o a nulla) anche con le persone di mentalità aperta e consapevoli. Perché costoro sanno bene che esistono problemi reali, di contenuto, e scrivere rettrice di un uomo non risolve nulla dei problemi reali. E, quindi, quando leggo la dichiarazione della rettrice / rettore, che dice di essersi sentito escluso e di aver (finalmente!) capito (il non detto è “il dramma dell’esclusione femminile e fluida”), mi viene da ridere. Per cui, professoressa Flavio & C., se lei ha bisogno di questa cosa per capire che ci sono ancora da colmare dei gap di genere, siamo messi male male…
In realtà farei un torto all’intelligenza della rettrice / rettore a pensare che solo attraverso questa iniziativa lei / lui abbia preso coscienza esistenziale delle disuguaglianze di genere. Così a me questa iniziativa di UniTrento non sembra neppure una provocazione per sensibilizzare. Mi sembra, invece, solo un atto di piaggeria verso le frange estreme della cosiddetta cultura woke che, detto en passant, nulla hanno a che spartire col concetto di inclusività. Peggio ancora.
Ma qui c’è un altro punto, qualcuno effettivamente cerca un dialogo e un confronto su questi temi? A qualcuno interessa parlare di contenuti, di situazioni concrete? Francamente vedo sempre più intransigenza da una parte e dall’altra e sempre meno voglia di capire le ragioni altrui, e questo vale per tutti i temi di confronto del vivere comune nelle nostre società. Vengo poi alla seconda domanda. È proprio necessario creare delle contrapposizioni ideologiche?
Parrebbe di sì. Uno sport diffusissimo nel mondo intero, da sempre, è quello di dividersi in fazioni. A prescindere, in parte o anche completamente, dai contenuti. Contrapposizioni tra fazioni che spesso sfociano nella categorizzazione e demonizzazione del pensiero altrui e, infine, in odio reciproco; odio di appartenenza, di bandiera, che non è una bella cosa e che sa tanto di disagio psicologico.
Il problema è rompere questa spirale e spostare la discussione dal “packaging” al contenuto.
Non saranno delle rettrici uomini a riuscire in questo.
Perturbare l’universale - Un sasso lanciato nello stagno
Il rapporto tra genere e istituzioni è problematico fin dalle origini, poiché le istituzioni stesse sono le prime ad aver contribuito, spesso in maniera determinante, alla produzione e riproduzione del sessismo. In particolare, le istituzioni hanno agito in due modi: attraverso la discriminazione di alcuni gruppi, a partire dalle donne, fino a omosessuali, transessuali, intersessuali, etc., evidenziandone le particolarità; oppure esse hanno agito nel senso opposto, invisibilizzando gli stessi gruppi attraverso l’uso di un neutro universale. Per questo chiedersi quale possa essere il ruolo del linguaggio delle istituzioni nella sovversione del binarismo di genere è una domanda complessa e sfaccettata.
Già nel 1986, Alma Sabatini, una linguista femminista, su segnalazione della Commissione Nazionale Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, ha scritto un testo per dare indicazioni per attenuare il sessismo della lingua italiana. A seguito di un’indagine sulla terminologia usata nel linguaggio istituzionale, nei libri di testo e nei mass media, Sabatini sottolineò la prevalenza del genere maschile, usato in italiano anche con doppia valenza (il cosiddetto maschile neutro) che annulla la presenza del soggetto femminile dai discorsi. Ha sottolineato il mancato utilizzo di termini istituzionali e di potere declinati al femminile (ministra, assessora, sindaca) e il prestigio concesso a un termine maschile, ma non al corrispettivo femminile. Sabatini afferma che: “La premessa teorica alla base di questo lavoro è che la lingua non solo riflette la società che la parla, ma ne influenza e limita anche il pensiero, l'immaginazione e lo sviluppo sociale e culturale”.
Le fondamentali riflessioni di Sabatini, e le sue raccomandazioni, hanno evidenziato l’assenza delle donne dal linguaggio della scena pubblica, ma allo stesso tempo hanno mostrato come criticare l’universale maschile non significhi uscire dal binarismo di genere. La struttura della lingua italiana, infatti, richiede una costante esplicitazione del genere a cui si appartiene, arrivando ad attribuirlo anche alle cose inanimate. Inoltre, per esprimere questa appartenenza di genere, in italiano è possibile riferirsi solo al maschile o al femminile, poiché non esiste un genere neutro che possa essere utilizzato. Negli ultimi anni, molti movimenti sociali che si definiscono queer hanno cercato di mettere in discussione questo binarismo imposto attraverso l’uso di asterisco, @ o -u come desinenze non sessuate. In questo senso i movimenti parlano di “queerizzare” la lingua italiana. Ciò significa pensare al modo in cui la lingua può essere forgiata dall’interno per opporsi, seguendo le indicazioni della linguistica queer[1], alle idee essenzialiste, naturalizzate ed egemoniche su genere e sessualità. Queste sperimentazioni, però, non trovano spazio negli ambiti istituzionali, nei quali sono ancora percepite come elementi di disordine[2]. Una forma di resistenza linguistica che proviene dai movimenti politici, da un uso situato e perturbante della lingua e dalla possibilità di utilizzare il linguaggio contro se stesso.
Allo stesso tempo, è importante notare come, nella tradizione del femminismo italiano della cosiddetta seconda ondata, il rapporto con la legge è spesso stato problematico ed è stato messo in discussione in molti modi. Come reso evidente riflessione del Collettivo della Libreria Femminista di Milano Non credere di avere dei diritti (1987), l’inclusione delle donne nell’attuale sistema giuridico è considerata un rischio: in questo senso era . In questo testo su giustizia e diritto si sostenevano alcune tesi: il diritto è concepibile solo come traducibilità e fonte dell’esistenza sociale; la giustizia può andare oltre il diritto attraverso la formula del giudizio politico sull’ingiustizia; fare giustizia significa praticare, ciascuna nel luogo in cui si trova, un’idea di mondo giusto fondata innanzitutto sulla valorizzazione dell’esperienza e sulla trama delle relazioni umane. Come sottolinea Tamar Pitch: “una caratteristica comune dell’approccio femminista è la messa in discussione della definizione positiva del diritto e della tradizione più rigida del positivismo giuridico, producendo norme e ragionando su norme al di fuori del perimetro della legge [...]. Questo non solo perché il femminismo costituisce ‘punto di vista esterno’, [...] ma perché ragiona sulle norme in vista della possibile produzione di regole giuste” (Pitch T., I diritti fondamentali: differenze culturali, disuguaglianze sociali, differenza sessuale, Giappichelli, 2004, p. 62).
Con queste premesse è possibile capire perché le teorie femministe guardino in maniera ambivalente i regolamenti, che allo stesso tempo esprimono le norme ma possono essere anche terreno della loro risignificazione, anche a partire dal linguaggio. In particolare da un linguaggio, come l’italiano, che non solo propone un rigido binarismo di genere, ma che riproduce costantemente l’egemonia maschile e la maschilità egemonica: “la maschilità egemone […] garantisce (o si presume garantisca) la posizione dominante degli uomini e la subordinazione delle donne. […] Il segno distintivo dell’egemonia è, infatti, l’autorità reclamata e ottenuta, più che la violenza diretta” (Raewyn W. C. Connell, Masculinities, Polity Press, 1995, p. 69) ed è pertanto quell’insieme di comportamenti, abitudini, modi di vita e di azione che riproducono il dominio senza bisogno di agire forme di coercizione. La maschilità egemone non è un tipo di carattere fisso, sempre e ovunque lo stesso, bensì si tratta della “maschilità che occupa una posizione egemone in una struttura data di relazioni di genere, una posizione che è sempre possibile contestare” (Cit., p. 76), anche da parte degli stessi maschi.
La teoria della maschilità egemone si basa sul pensiero di Antonio Gramsci e sul suo uso del concetto egemonia, il processo grazie al quale le classi dominanti ottengono un potere epistemico di definizione della cornice di significato entro la quale la realtà viene letta. Gramsci sottolinea come le classi dominanti mantengano la propria posizione di privilegio non solo attraverso l’azione diretta di un dominio, ma anche attraverso la creazione di modelli culturali tramite che possano creare consenso nelle classi subordinate rispetto alla legittimità e l’inevitabilità della posizione di privilegio della classe dominante stessa.
E le donne si trovano a occupare la posizione subalterna, a potersi esprimere solo con le parole e l’immaginario maschile, anche quando parlano di loro stesse. E i termini maschili e le desinenze maschili vengono presentate come neutre e in quanto tali universali e incontestabili. Proprio per questo, anche attraverso l’analisi del linguaggio, “possiamo […] ripensare la mascolinità egemonica come contesto pervasivo, superando la semplice distinzione tra soggettività egemoni e marginali o subalterne. Insomma intendere una più generale egemonia della e non nella maschilità, leggendo criticamente i riferimenti simbolici che strutturano, in forme diverse, tutte le maschilità” (Ciccone S., Maschi in crisi, Rosenberg & Sellier, 2019, p. 119).
Parlare di sé al maschile (come quando io, da donna, scrivo “eravamo tutti d’accordo") o riconoscersi in un appellativo al maschile (come quando le studenti rispondono al “buongiorno a tutti” di chi entra in aula), svela come l’essere donna sia una condizione straniante, in cui si è oggetto dei discorsi senza poterne diventare soggetto. Le donne imparano a pensarsi, in qualche modo, attraverso lo sguardo e le parole maschili e poi lavorano per differenza, per scarto rispetto a quello che vivono, in un processo che sovverte le traiettorie usuali del riconoscimento: non si tratta, infatti, di scoprire qualcosa, ma di smantellare qualcosa di già detto, di già riconosciuto.
Seguendo Teresa de Lauretis potremmo dire, così, che “il femminismo […] scoprì l’inesistenza della donna: il paradosso di essere allo stesso tempo catturate e assenti nei discorsi, sempre parlate ma inascoltate, e nell’impossibilità di esprimersi, mostrate come uno spettacolo eppure non rappresentate o irrappresentabili […], un essere la cui esistenza e la cui specificità sono simultaneamente affermate e rifiutate, negate e controllate” (de Lauretis T., Eccentric Subjects, in Ead. Figures of Resistance (1990), University of Illinois Press, 2007, p. 151). Questa inesistenza della donna diventa il motore per non poter fare a meno di interrogarsi costantemente su cosa voglia dire donna e “la ragione per cui non possiamo farne a meno è che, per le donne, il paradosso della donna non è un’illusione o un’apparente contraddizione, ma una realtà” (Cit., p. 154). Donna, quindi, sarebbe il prodotto di un’esclusione, di un’alterità che si mostra in maniera lampante nel linguaggio che utilizziamo.
In tutta la storia dei femminismi, non a caso, le donne si sono appropriate del lessico politico degli esclusi, dall’uguaglianza della Rivoluzione Francese all’emancipazione sindacale, per risignificarlo e svelarne la parzialità. Quando Olympe de Gouges scrive la Dichiarazione della donna e della cittadina nel 1792 non fa altro che questo: perturbare la rivendicazione dei diritti dell’uomo mostrando come quella stessa pretesa di universalità escluda le donne. Sostituire la parola donna alla parola uomo negli articoli della Dichiarazione, quindi, non è un gesto puramente semantico – come non lo sono mai le sovversioni linguistiche femministe, lesbiche, gay e transfemministe –, ma si tratta uno spaesamento che permette di cogliere i dispositivi di inclusione ed esclusione che sottendono alla politica. De Gouges lascia quasi invariato il testo della Dichiarazione, sostituendo donna e cittadina tutte le volte che compare uomo e cittadino, ma modifica in maniera sostanziale l’articolo dedicato alla libertà di opinione, che nella sua formulazione recita:
la libera comunicazione dei pensieri e delle opinioni è uno dei più preziosi diritti della donna, poiché tale libertà assicura la legittimità dei padri nei confronti dei figli. Ogni cittadina può quindi affermare liberamente: sono madre di un figlio che vi appartiene, senza che un barbaro pregiudizio la costringa a dissimulare la verità
(Olympe de Gouges, Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, 1791; trad. it., Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina, Il Melangolo, 2007, pp. 21-22).
De Gouges lega così la libertà di opinione alla possibilità di mettere in discussione uno dei cardini dell’ordine patriarcale: l’indissolubile legame tra paternità e matrimonio. Un gesto che sovverte l’ordine familiare, basato sull’idea della centralità del matrimonio come baluardo della legittimità della prole e strutturato attraverso il predominio maschile. E in questo modo, a partire da una condizione apparentemente privata come la maternità, mette in crisi quell’ordine politico fondato proprio sull’ordine domestico.
De Gouges svela anche l’impostura di una volontà generale che si esprime in una universalità che in realtà è maschile. Inoltre, riformulando l’articolo IV, pone in relazione libertà e giustizia, definendola come l’azione di restituire tutto quello che appartiene ad altri: poiché le donne non hanno mai posseduto nulla, possono così riappropriarsi di tutto quello che è loro. Emerge, così, un ideale di uguaglianza che cerca di tutelare anche la differenza[3], chiedendo un’inclusione nello spazio pubblico che non cancelli una storia differente, fatta si sopraffazione e ingiustizia, ma anche di resistenza.
In questo senso utilizzare un femminile sovraesteso permette un inciampo nel pensiero e nel linguaggio che può spingerci a riflettere sulle modalità di costruire l’universalità e i soggetti come omogenei, intercambiabili. Il disagio che gli uomini possono provare nel sentirsi inclusi in un tutte o nel trovarsi descritti come le docenti può essere produttivo non tanto per fondare una nuova norma, ma per perturbare quelle già esistenti e per provare a modificare la percezione delle cariche, dei ruoli di potere ma anche della pretesa universalità del maschile sottolineando le esclusioni che provoca. Il campo del linguaggio, in questo senso, è un campo di battaglia su cui vale la pena scendere e che sicuramente vale la pena osservare, anche per dare spazio ad altre narrazioni e ad altre possibili strutture, senza dimenticare, però, gli effetti materiali trasformativi che può produrre e che dovrebbero essere prodotti.
[1] La linguistica queer è una definizione data da Heiko Motschenbacher a quella branca della linguistica che, ispirandosi alle teorizzazioni sul queer, analizza criticamente le nozioni essenzialiste, egemoniche e naturalizzate su genere e sessualità. Si veda M. Heiko, Taking Queer Linguistics further: sociolinguistics and critical heteronormativity research, International Journal of the Sociology of Language, 212, 2011, pp. 149-179.
[2] Cfr. M. Baldo, Frocie, femminelle, terrone, polentone e favolosità varie. Quando il queer è di casa, online, 2017, http://www.queeritalia.com/blog/2017/5/13/frocie-femminelle-terrone-polentone-e-favolosit-varie-quando-il-queer-di-casa1 e I. Marotta e S. Monaco, Un linguaggio più inclusivo? Rischi e asterischi nella lingua italiana, Gender/sexuality/Italy, 3, 2016.
[3] Cfr. Martina Reuter, Equality and Difference in Olympe de Gouges’ Les droits de la femme. A La Reine, Australasian Philosophical Review, 3, 4, 2019, pp. 403-12.